Il RUNTS È attivo il Registro degli Enti del terzo settore

Egregio Avvocato
Pubblicato il 28 feb. 2022 · tempo di lettura 4 minuti
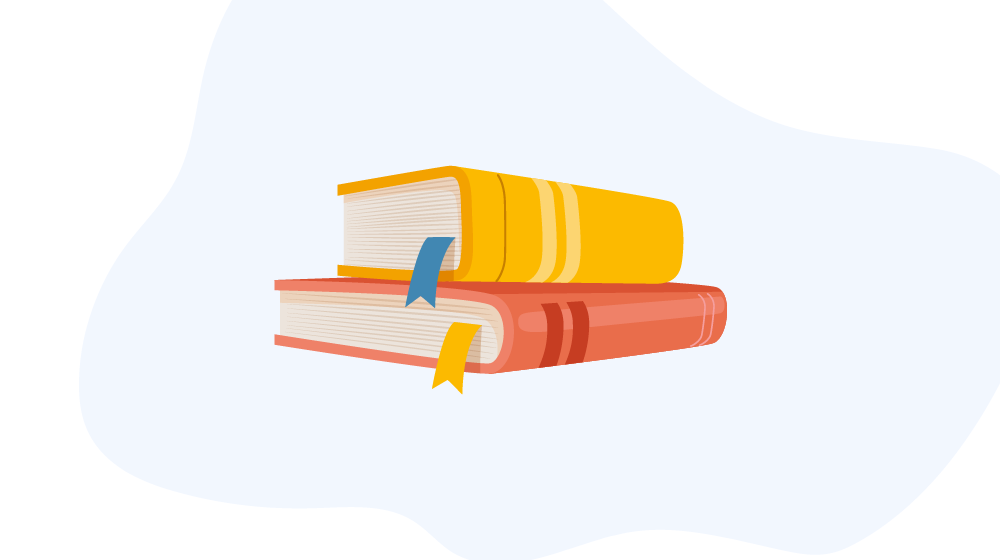
Dal 23 novembre 2021 è attivo il RUNTS! Gli Enti del terzo Settore possono, finalmente, iscriversi all'apposito Registro e beneficiare così della disciplina premiale prevista dal D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, noto come Codice del Terzo Settore.
Ecco una breve guida su dove e come presentare la richiesta d’iscrizione per associazioni e fondazioni.
1 - Cos'è il RUNTS
2 - I presupposti per l’iscrizione.
3 - Associazioni e Fondazioni: come iscriversi.
4 - Associazioni: personalità giuridica sì o no.
1 - Cos’è il RUNTS.
Il RUNTS è l’acronimo di “Registro Unico Nazionale del Terzo settore” al quale possono iscriversi gli enti che intendono ottenere la qualifica di Enti del Terzo Settore, o in breve “ETS”, e beneficiare della disciplina premiale introdotta dal legislatore con il D.lgs. 117/2017, anche detto Codice degli Enti del Terzo settore (CTS).
Per sapere cosa siano gli ETS leggi QUI.
2 - I presupposti per l’iscrizione.
L’iscrizione al RUNTS è subordinata alla conformità degli atti costitutivi e statuti degli enti no profit alle condizioni prescritte dal Codice del Terzo settore, ad esempio, l’indicazione nella denominazione sociale dell’acronimo ETS, avere ad oggetto sociale il perseguimento di finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una delle attività di interesse sociale tassativamente elencate all’art. 5 del CTS, l’assenza dello scopo di lucro e la previsione obbligatoria, per alcuni enti, dell’organo di controllo.
Gli enti già costituiti dovranno, quindi, conformare il proprio atto costitutivo alle prescrizioni richieste, e se necessario per la tipologia di ente, ciò dovrà avvenire per il tramite di un notaio.
3 - Associazioni e Fondazioni: come iscriversi.
Le Associazioni e le Fondazioni sono nella prassi le forme maggiormente diffuse. Come possono iscriversi al RUNTS?
Per le associazioni occorre distinguere se esse intendano acquisire o meno la personalità giuridica, o se già costituite, se sono riconosciute o non riconosciute, cioè se risultano iscritte presso il Registro delle Persone giuridiche.
Si aprono, quindi, due iter alternativi:
a) se l’ente vuole operare la mera iscrizione al Runts, senza ottenere la personalità giuridica: l'iscrizione è a cura del rappresentante legale dell'ente (es. il Presidente del Consiglio Direttivo).
La domanda d'iscrizione deve essere presentata telematicamente presso la piattaforma disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (clicca qui per accedere al Registro) e corredata dai documenti ed indicazioni analiticamente indicate nell’art. 8 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020.
Per accedere al registro e presentare la domanda il rappresentante legale deve essere in possesso dello Spid o della carta d'identità elettronica, nonché della Pec e firma digitale per la gestione dei documenti.
b) se l’ente vuole operare l'iscrizione al registro ed ottenere la personalità giuridica oppure l'associazione è già riconosciuta: l'iscrizione è a cura del notaio (ai sensi degli art. 16 e ss. del predetto Decreto Ministeriale.)
In questo caso, se si aspira al riconoscimento, l’art. 22 comma 4 del CTS impone che l’ente abbia un patrimonio minimo di 15.000 euro, la cui consistenza deve essere attestata dal notaio. Il patrimonio può essere costituito sia in denaro o beni diversi il cui valore dovrà essere accertato da una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
Per le fondazioni, riconosciute dalla Prefettura ed iscritte presso il Registro delle Persone giuridiche (come per prassi è nella maggior parte dei casi, lasciando ad altra sede la discussione circa l’ammissibilità di fondazioni “non riconosciute”), vale quanto detto sub. b).
L’ente dovrà, infine, dotarsi del codice fiscale e di un indirizzo di posta elettronica certificata per tutte le interlocuzioni con le amministrazioni pubbliche.
4 - Associazioni: personalità giuridica sì o no.
Abbiamo distinto i due iter di iscrizione in base alla scelta di voler ottenere o meno la personalità giuridica. Cos’è e cosa comporta?
L’acquisto della personalità giuridica comporta la cd. “autonomia patrimoniale perfetta” ossia la limitazione di responsabilità per le obbligazioni sociali al solo patrimonio dell’associazione, nel senso che ad esse risponde solo l’associazione con il suo fondo e non gli associati o i componenti dell’organo amministrativo (in altri termini, il patrimonio del singolo partecipante è insensibile ai debiti dell’ente, e viceversa).
La mancanza del riconoscimento della personalità giuridica comporta che l’ente – pur essendo un autonomo “soggetto di diritto” rispetto ai suoi associati – non gode di un’autonomia patrimoniale perfetta, cioè, in caso d’incapienza del patrimonio dell’associazione per il soddisfacimento delle obbligazioni sociali, i creditori sociali possono chiedere l’adempimento delle medesime anche agli associati che hanno agito in nome e per conto dell’ente (cfr. art. 38 c.c.).
Per l’ottenimento del “riconoscimento” (n.b. non per la mera costituzione e la richiesta di iscrizione al registro degli ETS) è necessaria la forma notarile.
Editor: Dott.ssa Flavia Carrubba
Condividi:
Il RUNTS È attivo il Registro degli Enti del terzo settore
Pubblicato da:

Egregio Avvocato
Articoli che potrebbero interessarti
Il diritto degli ascendenti alla frequentazione dei nipoti tra interesse del minore e poteri officiosi del Giudice
23 feb. 2026 • tempo di lettura 4 minuti
In materia di provvedimenti riguardanti i minori, la giurisprudenza di legittimità ribadisce costantemente che il criterio guida di ogni decisione giudiziale è rappresentato dall’interesse superiore del minore, da valutarsi con riferimento alla situazione concreta esistente al momento della decisione. Ne discende che il Giudice è tenuto a considerare anche i mutamenti intervenuti nel corso del procedimento e, in presenza di circostanze sopravvenute idonee a incidere negativamente sul benessere psicofisico del minore, può modificare l’assetto delle relazioni familiari precedentemente stabilito.In tale cornice si collocano le sentenze della Corte di Cassazione nn. 9144 e 9145 del 2020, le quali affrontano il tema del diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti, chiarendone limiti, presupposti e natura giuridica.La Suprema Corte ha precisato che il riconoscimento del diritto di visita dei nonni non si configura come un diritto soggettivo pieno ed autonomo, bensì come una situazione giuridica funzionalmente subordinata all’interesse esclusivo del minore. Tale impostazione trova fondamento nell’art. 317-bis, comma 2, c.c., nonché nei principi sovranazionali sanciti dall’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall’art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo.La frequentazione con gli ascendenti assume rilevanza giuridica solo nella misura in cui sia idonea a contribuire positivamente allo sviluppo armonico della personalità del minore e si inserisca in una fruttuosa cooperazione educativa con i genitori, titolari esclusivi della responsabilità genitoriale.Con la sentenza n. 9145/2020 la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso proposto da un nonno avverso la decisione di merito che aveva modificato in senso restrittivo il regime di incontri con le nipotine. Nel caso di specie, le indagini svolte dai servizi sociali avevano evidenziato un marcato deterioramento dei rapporti tra il nonno e i genitori delle minori, tale da generare una condizione di disagio emotivo nelle bambine e da incidere negativamente sulla serenità del nucleo familiare.Secondo la Corte, la conflittualità tra gli adulti e l’assenza di una cooperazione educativa rendevano la frequentazione non solo improduttiva, ma potenzialmente pregiudizievole per le minori, giustificando così la revisione “in peius” delle modalità di esercizio del diritto di visita.Analoga conclusione è stata raggiunta nella sentenza n. 9144/2020, relativa al ricorso di una nonna acquisita, nuova compagna del nonno, la quale aveva instaurato con le minori un rapporto caratterizzato da atteggiamenti critici e invasivi rispetto alle scelte educative dei genitori.Pur in presenza di un legame affettivo inizialmente favorito dagli stessi genitori, la Corte ha ritenuto legittima la decisione di modificare le modalità di frequentazione, in quanto l’ingerenza educativa e la costante critica all’operato genitoriale interferivano con il progetto educativo familiare e rischiavano di compromettere l’equilibrato sviluppo psicofisico delle minori.Dalle pronunce in esame emerge con chiarezza l’ampiezza dei poteri officiosi attribuiti al Giudice, il quale può adottare, anche d’ufficio, tutti i provvedimenti ritenuti opportuni per garantire il benessere del minore, inclusa la modifica delle modalità di frequentazione con gli ascendenti.Tali poteri trovano giustificazione nella necessità di adeguare le decisioni giudiziarie alla realtà dinamica delle relazioni familiari, soprattutto quando sopravvengano comportamenti o situazioni idonee a turbare lo sviluppo del minore.I principi sopra richiamati sono stati ulteriormente ribaditi dal Tribunale per i Minorenni di Catanzaro con decreto depositato il 31 gennaio (Pres. dott. Luciano Trovato, Rel. dott.ssa Teresa Chiodo), che ha rigettato il ricorso dei nonni materni volto a ottenere un provvedimento ex art. 333 c.c. per la frequentazione delle nipotine.Dall’istruttoria era emerso che le minori erano serene, ben inserite nel contesto familiare e supportate da genitori adeguati e rassicuranti. Al contrario, risultava evidente una situazione di forte e persistente conflittualità tra nonni e genitori, alimentata dalla totale disapprovazione dei primi rispetto all’indirizzo educativo adottato dai secondi, nonché da indebite intrusioni nella privacy familiare.Il Tribunale ha sottolineato come tali condotte costituissero un fattore di interferenza negativa sul progetto educativo e sull’armonico sviluppo della personalità delle minori, escludendo che una frequentazione imposta in via giudiziaria, in un clima apertamente ostile, potesse rispondere al loro interesse.Dalla ricostruzione giurisprudenziale emerge un orientamento ormai consolidato:il rapporto tra nonni e nipoti, pur riconosciuto come valore affettivo e relazionale, non può tradursi in una indebita ingerenza nelle prerogative genitoriali. L’educazione dei figli spetta esclusivamente ai genitori, mentre agli ascendenti compete un ruolo di supporto affettivo, da esercitarsi nel rispetto dei confini educativi familiari.In presenza di comportamenti invasivi, conflittuali o comunque idonei a compromettere il benessere del minore, il Giudice può legittimamente limitare o modificare il diritto di visita degli ascendenti. Il bene primario da tutelare resta il benessere psicofisico del minore, a fronte del quale ogni altro interesse è destinato a recedere.
Continua a leggere
Scritto da:
L’indennizzo a seguito di vaccinazioni obbligatorie
29 nov. 2021 • tempo di lettura 6 minuti
Ai sensi dell’art. 32 co. 2 Cost., “Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”. Ma cosa succede se una persona riporta, a seguito di un trattamento sanitario obbligatorio, delle lesioni permanenti o, addirittura, decede? La L. 210/1992 prevede, con specifico riferimento alle conseguenze correlate alle vaccinazioni obbligatorie, un indennizzo da parte dello Stato.Vediamo meglio di cosa si tratta.I principi costituzionali in materia di diritto alla saluteLa legge 210/1992 e l’indennizzo da vaccinazioni obbligatoriePrecisazioni terminologiche: differenza fra indennizzo e risarcimento1 - I principi costituzionali in materia di diritto alla saluteL’art. 32 Cost. afferma che il diritto alla salute è un “fondamentale diritto dell’individuo”.Tale principio opera a più livelli. Da un lato, il diritto alla salute e all’integrità psicofisica trova tutela nei confronti dei terzi: infatti, tutti i consociati hanno l’obbligo di astensione da condotte che possano cagionare ad altri malattie, infermità o menomazioni. Dall’altro lato, il diritto alla salute e all’integrità psicofisica è rimesso all’autodeterminazione del suo titolare. È la stessa Costituzione a precisare, all’art. 32 co. 2, che “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.Da questa norma deriva, dunque, il fondamentale principio di autodeterminazione in ambito sanitario: gli accertamenti ed i trattamenti sanitari, cioè, sono volontari, nel senso che richiedono il consenso, espresso e specifico, dell’avente diritto, che ha il diritto di opporre un rifiuto alle cure.Tuttavia, la legge può prevedere l’obbligo di un determinato accertamento o trattamento sanitario, come una vaccinazione. Tale imposizione, secondo quanto affermato anche in tempi recenti dalla Corte costituzionale (Corte cost. 26 aprile 2012, n. 107), è legittima e compatibile con la Costituzione solo nella misura in cui dipenda dalla necessità di tutelare l’interesse, ritenuto superiore, alla protezione della sanità pubblica. Ancora, in una più risalente pronuncia (Corte cost. 307/1990), la stessa Corte costituzionale aveva precisato che “la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’articolo 32 della Costituzione se il trattamento sia diretto a migliorare o a preservare lo Stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell’uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale”.Da questo sintetico quadro deriva, dunque, che i trattamenti sanitari obbligatori sono legittimi se rispettano due requisiti:sono previsti da una legge dello Stato;sono diretti a tutelare un interesse collettivo. Peraltro, non sono rari i casi in cui il legislatore ha fatto ricorso allo strumento della vaccinazione obbligatoria per far fronte a gravi situazioni di emergenza sanitaria.Da ultimo, con il d.l. 44/2021, il nostro legislatore ha previsto l’obbligo di vaccinazione contro SARS-CoV-2 per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura ed assistenza.A fronte di tale potere, è oggi previsto, nella L. 210/1992, un indennizzo da parte dello Stato a favore di “chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie (…), lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica”.2 - La legge 210/1992 e l’indennizzo da vaccinazioni obbligatorieLa legge 210/1992 riconosce un indennizzo ai soggetti danneggiati in modo irreversibile da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati infetti.Per quanto qui interessa, secondo l’art. 1 della legge, “chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge, o per ordinanza, di un’autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato”.Si tratta di un riconoscimento in denaro ispirato al principio della solidarietà sociale, erogato a prescindere dal reddito del richiedente, esente dalle imposte sui redditi e cumulabile con altre eventuali provvidenze economiche percepite a qualsiasi titolo. Dà, inoltre, diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e dal pagamento della quota fissa per ricetta limitatamente alle prestazioni sanitarie per la diagnosi e la cura delle patologie vaccino-correlate. La legge stabilisce che l’indennizzo e gli altri benefici previsti spettano a chi, alternativamente:si è sottoposto a vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria;ha praticato vaccinazioni non obbligatorie, ma necessarie per motivi di lavoro o per incarichi d’ufficio o per poter accedere ad uno stato estero; rientra nella categoria dei soggetti a rischio operanti in strutture sanitarie ospedaliere» e, in quanto tale, si è sottoposto a vaccinazioni, anche non obbligatorie.L’indennizzo previsto dalla legge n. 210/1992 consiste in un assegno mensile vitalizio oppure, in caso di morte, in un assegno una tantum da erogare ai familiari del soggetto deceduto. La legge n. 229/2005 ha riconosciuto, inoltre, un indennizzo in favore sia dei soggetti danneggiati, sia dei congiunti che prestino al danneggiato assistenza in maniera prevalente o continuativa.Per quanto riguarda l’assegno vitalizio mensile, da corrispondersi qualora sia accertata una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica del richiedente causata dalla vaccinazione obbligatoria, l’indennità si compone di due quote: una somma determinata sulla base dell’invalidità accertata e un’indennità integrativa speciale. La prima delle due somme si determina sulla base di tabelle del Ministero della Salute: queste tabelle contengono otto categorie di invalidità, dalla più grave alla meno grave. Per il 2020, le tabelle hanno riconosciuto importi ricompresi fra euro 1.599,37 ed euro 1.791,01.In caso di patologie plurime, è possibile ottenere, un indennizzo aggiuntivo del 50% rispetto a quello stabilito per la patologia più grave. In caso di decesso, invece, gli eredi del danneggiato hanno diritto ad un assegno reversibile per 15 anni o ad un assegno una tantum pari a euro 77.468,53 ed alle rate di indennizzo maturate dalla data della domanda al giorno della morte. L’indennizzo deve essere richiesto con apposita domanda indirizzata all’Azienda Sanitaria di appartenenza. All’istanza deve essere allegata la documentazione che comprovi la data della vaccinazione, i dati relativi al vaccino, le manifestazioni cliniche conseguenti alla vaccinazione e l’entità delle lesioni o dell’infermità da cui è derivata la menomazione permanente. Se il danneggiato è deceduto, l’istanza può essere proposta dagli eredi. Ricevuta la domanda, l’Azienda Sanitaria la inoltrerà alla Commissione Medica Ospedaliera (CMO), che a sua volta provvede a convocare a visita medica l’interessato, ad esaminare la documentazione sanitaria e a redigere il giudizio sul nesso causale tra l’infermità e la trasfusione.Acquisito il parere, l’Azienda Sanitaria notifica all'interessato l'esito della sua istanza e, in caso di riconoscimento del diritto all'indennizzo, emette un decreto per la liquidazione e relativo mandato di pagamento.Il diritto all’indennizzo si prescrive in tre anni decorrenti dal momento in cui si è avuto piena conoscenza dei danni provocati dalla vaccinazione.3 - Precisazioni terminologiche: differenza fra indennizzo e risarcimentoCome abbiamo visto, quello che la legge riconosce in caso di menomazioni permanenti dell’integrità psico-fisica in conseguenza di vaccinazioni obbligatorie è un indennizzo e non un risarcimento. In estrema sintesi, l’indennizzo consegue ad un’azione lecita, consentita o addirittura imposta dall’ordinamento: pur in assenza di un fatto illecito, la legge ritiene comunque opportuno che il soggetto leso riceva una somma per equilibrare una situazione che rischierebbe di diventare ingiusta. Si tratta, in altri termini, di una misura di solidarietà sociale con funzione assistenziale.Il risarcimento, invece, è imposto dalla legge in tutti i casi in cui si debba riparare ad un danno ingiusto e trova il proprio presupposto nell’accertamento di una responsabilità colposa o dolosa dei sanitari. Pertanto, è possibile ottenere il risarcimento per i danni da vaccino nel caso in cui questi potevano essere previsti ed evitati, ad esempio perché il vaccino è stato eseguito nei confronti di un soggetto cui era controindicato. Quando, invece, non sia possibile ravvisare alcuna responsabilità in capo ai sanitari, il danno sarà semplicemente indennizzabile.Editor: dott.ssa Elena Pullano
Continua a leggere
Scritto da:

Egregio Avvocato
L’amministrazione di sostegno
29 mar. 2021 • tempo di lettura 5 minuti
L’ordinamento giuridico italiano ha vissuto una profonda evoluzione del proprio sistema in merito alla “incapacità delle persone” mediante l’introduzione di un nuovo istituto, quale l’amministrazione di sostegno. Il legislatore ha cercato di superare l’eccessiva rigidità che connotava il sistema previgente, volendo permettere una maggiore libertà e flessibilità nella disciplina del singolo soggetto incapace. Vediamo, quindi, i principali caratteri di questo nuovo istituto e in che modo si rapporta con gli istituti previgenti.L’origine della legge n. 6 del 2004I presupposti dell’amministrazione di sostegnoChi è l’amministratore di sostegnoI rapporti con interdizione e inabilitazione1 - L’origine della legge n. 6 del 2004L’intervento legislativo in esame assume una rilevanza fondamentale per il sistema delle “incapacità delle persone” previsto nell’ordinamento giuridico italiano, avendo introdotto l’istituto della amministrazione di sostegno nel codice civile, e in particolare nel Capo I del Titolo XII, intitolato “Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia”.L’esigenza di dare un nuovo assetto al sistema nasce dopo il superamento dei manicomi (mediante la legge Basaglia n. 180 del 1978), quando si è posto il grande problema della riorganizzazione della vita dei “manicomializzati” al di fuori delle mura degli istituti. Il sistema previgente, infatti, prevedeva solo la inabilitazione e la incapacità di agire, che non consentivano una flessibilità della disciplina: il soggetto o era totalmente capace di agire e autodeterminarsi, o non lo era affatto; non si consentiva una via di mezzo. Non vi era un sistema di incapacità che guardava al singolo incapace, venivano tutti considerati uguali tra loro. Rispetto a questa realtà gli ex manicomializzati si trovavano spesso in una sorta di zona grigia, tra chi stava bene e chi stava male, e la disciplina del codice del ’42 risultava del tutto inadeguata, per questo, si è sentita la necessità di prevedere una misura ad hoc. Già dall’art. 1 della legge in esame è esplicitata la finalità cui il legislatore aspira: “La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”. Quindi, la logica è quella della minima privazione (l’intento è quello di promuovere la persona). L’art. 409 co. 1 c.c. prevede espressamente che il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno. Ciò che l’incapace non può fare deve essere espressamente previsto dal decreto di nomina disposto dal giudice tutelare. L’istituto è di ausilio alla persona, e non ai familiari.2 - I presupposti dell’amministrazione di sostegnoIl protagonista di questa disciplina è il beneficiario: l’amministrazione di sostegno, infatti, può essere aperta anche su ricorso dello stesso beneficiario, che deve essere sentito dal giudice tutelare. Così, il beneficiario non viene escluso dal traffico giuridico, ma anzi viene promossa la sua attività. Il giudice gradua il decreto proprio tenendo conto delle peculiari necessità dell’interessato.Il primo presupposto richiesto è che vi sia una “infermità ovvero una menomazione fisica o psichica”. È un’indicazione molto ampia, e fa riferimento a qualsiasi menomazione che possa pregiudicare la possibilità di compiere atti giuridici (si va dai disabili agli alcolisti).Il secondo presupposto, invece, è quello della “impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi”. Occorre verificare anche se il potenziale beneficiario abbia un corredo familiare e sociale di riferimento che gli consenta comunque di provvedere ai propri interessi. Il giudice non deve considerare solo la persona isolatamente considerata in astratto, ma deve verificare se anche all’interno della formazione sociale e della comunità di riferimento, è in grado di farlo (es. se il soggetto è inserito all’interno di una comunità che lo aiuti). Quindi, ruolo fondamentale è svolto dal giudice tutelare, il quale deve redigere il decreto di nomina nel quale indica cosa l’incapace non può fare autonomamente, e può anche intervenire autonomamente per modificarlo e integrarlo. Si vuole cercare di non aggravare la giustizia in tutti quei casi in cui il soggetto, anche se menomato, è comunque in grado di soddisfare i propri interessi grazie al corredo familiare o sociale di riferimento.3 - Chi è l’amministratore di sostegno? Il legislatore prevede che il beneficiario stesso possa designare l’amministratore per il caso di una futura incapacità, e di regola il giudice si attiene a questa assegnazione (salvi gravi motivi); altrimenti il giudice farà riferimento ai soggetti della cerchia familiare del soggetto. L’art. 408 c.c. prevede un ordine di scelta, anche se il giudice può scegliere sulla base di un diverso ordine tra soggetti diversi – per esempio può indicare anche il convivente stabile del beneficiario.Di regola l’incarico è gratuito, ma il giudice può prevedere una indennità a favore dell’amministratore di sostegno. Quest’ultimo risponde nei confronti del beneficiario per i danni causati nel corso dell’amministrazione, ma non è indicato a che titolo. Per la tesi preferibile si tratterebbe di inadempimento di obbligazione ex lege (quindi si tratta di una responsabilità ex art. 1218 c.c.); per altre tesi invece si tratterebbe di responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.)Il beneficiario risponde sicuramente senza alcuna deroga nei confronti dei terzi: si tratterà di responsabilità extracontrattuale ex artt. 2047 e 2048 c.c. nel caso in cui l’amministratore abbia un dovere di sorveglianza del soggetto incapace che cagioni un danno ai terzi.L’art. 405 c.c. prevede due tipi di modelli di amministrazione di sostegnoil modello di rappresentanza esclusiva, ove l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario tutti gli atti indicati dal giudice tutelare nel decreto di nomina;il modello di rappresentanza assistenziale, ove il beneficiario può compiere quei determinati atti solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno.4 - I rapporti con interdizione e inabilitazioneStrutturalmente, sono istituti diversi: la interdizione e la inabilitazione sono di regola più rigide, anche se dopo la riforma tale rigidità si è attenuata (art. 427 co.1 c.c.), mentre l’amministrazione di sostegno trova la sua peculiarità proprio nella flessibilità. Dalla riforma posta in essere mediante la legge n. 6 del 2004 vi è una predilezione per l’amministrazione di sostegno: consente di plasmare le misure della incapacità sulle esigenze dello specifico beneficiario.È lo stesso legislatore a preferire l’amministrazione di sostegno; e ciò si desume dal fatto che il legislatore la prevede al Capo I del Titolo dedicato a tali istituti. A tal proposito, è stata criticata quella giurisprudenza che, pur potendo in astratto optare per l’amministrazione di sostegno, abbia in concreto disposto un’altra misura. In conclusione, bisogna preferire sempre l’istituto dell’amministrazione di sostegno ove possibile, a meno che l’incapacità del singolo sia talmente grave che tale scelta darebbe luogo a vuoti di tutela, e quindi sarebbe pregiudizievole per l’incapace stesso. Editor: dott.ssa Claudia Cunsolo
Continua a leggere
Scritto da:

Egregio Avvocato
Pubblicità ingannevole: come denunciarla?
14 nov. 2021 • tempo di lettura 1 minuti
Per pubblicità ingannevole si intende la pratica commerciale posta in essere da un professionista in modo scorretto. In contrasto con il principio della diligenza professionale, la pubblicità ingannevole induce in errore il consumatore medio, falsandone il processo decisionale (acquista un prodotto che non avrebbe acquistato). Le informazioni ingannevoli possono riguardare il prezzo, le caratteristiche del prodotto, i rischi connessi al suo impiego.Ogni cittadino e qualsiasi associazione che ne abbia interesse può richiedere l’intervento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust) per denunciare i casi di pubblicità ingannevole e le pratiche commerciali scorrette. Nei casi in cui l’Antitrust ritenga esistenti sufficienti elementi probatori, avvia il procedimento amministrativo: il termine di conclusione del procedimento è di 120 giorni, decorrenti dalla data di protocollo della comunicazione di avvio, e di 150 giorni quando si debba chiedere il parere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom).Si può segnalare attraverso i seguenti canali:tramite posta ordinaria inviando la segnalazione all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Piazza Giuseppe Verdi 6/A – 00198 Roma;inviando la segnalazione scritta alla casella di posta elettronica certificata: protocollo.agcm@pec.agcm.it;compilando e inviando on line il modulo cui si accede tramite il sito www.agcm.it/segnala-online/index.
Continua a leggere
Scritto da:

Egregio Avvocato
Commenti
Non ci sono commenti



