Eredità Digitale

Egregio Avvocato
Pubblicato il 27 lug. 2021 · tempo di lettura 3 minuti
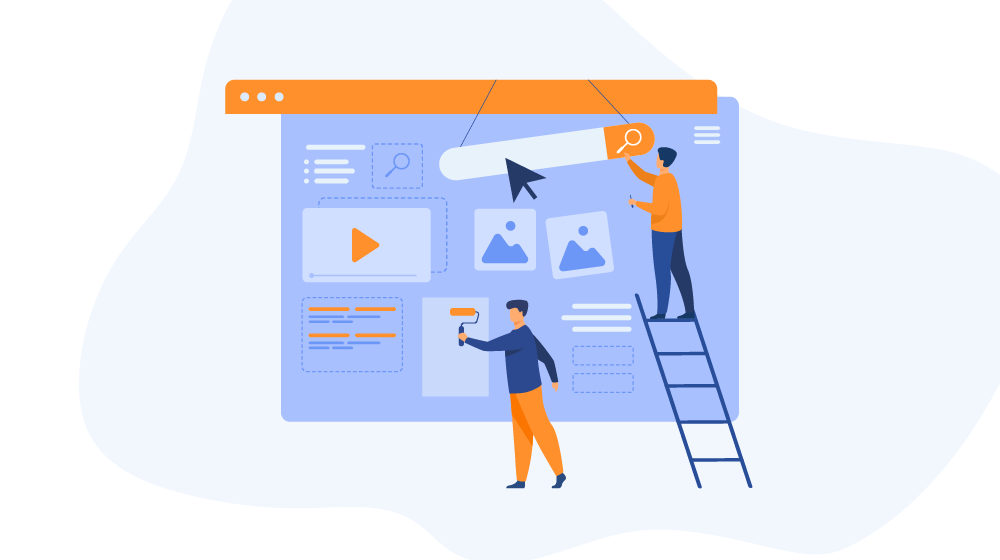
La miriade di informazioni che ogni giorno lasciamo in questo mondo online forma la nostra identità digitale. Profili social, contenuti multimediali, messaggi di posta elettronica: tutto ciò che fine fa alla nostra morte? I dati personali-digitali non muoiono con l’interessato ed allora, in assenza di una efficiente regolamentazione, nascono nuove soluzioni operative.
1. Cos’è l’eredità digitale?
2. Cosa prevedono alcune piattaforme online.
3. In che modo posso disporne?
1 - Cos’è l’eredità digitale?
Non esiste una legislazione specifica in materia dalla quale poter prendere in prestito una definizione, tuttavia, possiamo definire l’eredità digitale come la trasmissione a soggetti terzi del nostro patrimonio digitale.
Intendiamo per “patrimonio digitale” l’insieme di tutti i rapporti giuridici e beni, con o senza valore economico, presenti o su un supporto elettronico o conservati su server remoti, accessibili solo online mediante apposite credenziali, riferibili alla cd. identità digitale. Fanno quindi parte dell’eredità digitale non solo i dispositivi fisici (come hard disk e chiavi usb) ma, ad esempio, i profili dei social network, l’online-banking, la posta elettronica, le chat, gli spazi di archiviazione, i file multimediali, le licenze software e le criptovalute.
2 - Cosa prevedono alcune piattaforme online.
Alcuni social come Facebook ed Instagram danno la possibilità a ciascun utente di scegliere che l’account venga eliminato in modo permanente al proprio decesso.
Facebook, in assenza di indicazioni, provvede a convertire i profili social in account commemorativi che “permettono ad amici e familiari di raccogliere e condividere ricordi di una persona che è venuta a mancare” e dal 2018 permette di individuare un “contatto erede”, ossia la designazione di un soggetto al quale viene concesso di accedere e gestire, con alcuni limiti, l’account del de cuius.
Altro discorso è possibile fare per i servizi di posta elettronica, i quali hanno politiche molto diverse tra loro. Ad esempio, Google offre ai propri utenti la facoltà di stabilire chi, alla propria morte, potrà avere accesso alla casella di posta elettronica oppure che la stessa venga cancellata, o, in assenza di indicazioni, impone la collaborazione con gli stretti congiunti circa la destinazione dell’account, tutelando il diritto alla riservatezza. Ancora, Yahoo, stabilisce l’automatica cancellazione della casella di posta alla notizia della morte del titolare, così imponendo una sorta di non-trasferibilità del patrimonio digitale.
3 - In che modo posso disporne?
Come detto, in Italia non esiste una legislazione in materia di successione nel patrimonio digitale ed, inoltre, i “dati personali” di soggetti deceduti non rientrano neppure nell’ambito di applicazione del Regolamento Europeo in materia di dati personali n. 2016/679.
Ad oggi, l’unico riferimento normativo sul tema è l’art. art. 2-terdecies del Codice Privacy (d. lgs. 196/2003), il quale stabilisce che i diritti “riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione” e che l'esercizio dei predetti diritti non è ammesso nei casi previsti dalla legge o allorquando “l'interessato lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a quest'ultimo comunicata”.
Pertanto, in assenza di un'armonizzazione comunitaria del mercato unico “digitale” e in difetto di un’opportuna legislazione nazionale, la soluzione migliore per tutelare il proprio patrimonio digitale appare essere il testamento. Infatti - oltre ad informarsi sulle regole stabilite da ciascun servizio digitale utilizzato - attraverso il testamento è possibile assegnare le credenziali di accesso di server e piattaforme a chi crediamo possa farne buon uso oppure conferire a persone fidate l’incarico di gestire, secondo precise istruzioni, la propria eredità digitale (si parla in quest’ultimo caso di “mandato post mortem”).
Se sei interessato al tema leggi anche “Il diritto all’oblio”.
Editor: Dott.ssa Flavia Carrubba
Condividi:
Eredità Digitale
Pubblicato da:

Egregio Avvocato
Articoli che potrebbero interessarti
Affidamento dei figli minori e trasferimento all'estero
27 apr. 2023 • tempo di lettura 1 minuti
Uno dei temi più dibattuti da noi avvocati matrimonialisti/divorzisti è, ovviamente, l'affido dei figli minori in seno ad un giudizio di separazione. Dando per scontato che, nella maggior parte dei casi, i Tribunali optano per l'affido condiviso, quid iuris quando uno dei genitori - per i più svariati motivi - decide di spostare la propria residenza all'estero? Il tema è stato di recente analizzato dalla Suprema Corte nella decisione in commento. (Corte di Cassazione - Ordinanza n. 24651/2022, Sez. Prima Civile) L'orientamento qui espresso pare assolutamente condivisibile. Ed invero, il consenso di un genitore al collocamento dei figli presso l'ex coniuge (id est, spesso la madre) non presuppone sic et simpliciter un'implicita autorizzazione al trasferimento all'estero, in quanto tale passo - seppur costituzionalmente garantito, stante la libertà di decidere dove vivere - comporta notevoli limitazioni alla bigenitorialità e all'esercizio di quel diritto/dovere ad essa intrinsecamente connesso. Ne discende che qualsiasi decisione unilaterale di trasferimento all'estero con figli minori è da ritenersi lesivo dei diritti dell'altro genitore, che si vede de facto limitato nell'esercizio delle prerogative genitoriali, e, pertanto, costituisce illecito di sottrazione internazionale di minori, tema che è regolamentato persino a livello internazionale dalla Convenzione internazionale de L'Aia. La decisione degli Ermellini appare impeccabile sotto un profilo logico ed interpretativo e rappresenta sicuramente un piunto fermo nella soluzione di simili controversie.Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo Matrimonialista - Divorzista - Curatore Speciale del Minore
Continua a leggere
Scritto da:
L’indennizzo a seguito di vaccinazioni obbligatorie
29 nov. 2021 • tempo di lettura 6 minuti
Ai sensi dell’art. 32 co. 2 Cost., “Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”. Ma cosa succede se una persona riporta, a seguito di un trattamento sanitario obbligatorio, delle lesioni permanenti o, addirittura, decede? La L. 210/1992 prevede, con specifico riferimento alle conseguenze correlate alle vaccinazioni obbligatorie, un indennizzo da parte dello Stato.Vediamo meglio di cosa si tratta.I principi costituzionali in materia di diritto alla saluteLa legge 210/1992 e l’indennizzo da vaccinazioni obbligatoriePrecisazioni terminologiche: differenza fra indennizzo e risarcimento1 - I principi costituzionali in materia di diritto alla saluteL’art. 32 Cost. afferma che il diritto alla salute è un “fondamentale diritto dell’individuo”.Tale principio opera a più livelli. Da un lato, il diritto alla salute e all’integrità psicofisica trova tutela nei confronti dei terzi: infatti, tutti i consociati hanno l’obbligo di astensione da condotte che possano cagionare ad altri malattie, infermità o menomazioni. Dall’altro lato, il diritto alla salute e all’integrità psicofisica è rimesso all’autodeterminazione del suo titolare. È la stessa Costituzione a precisare, all’art. 32 co. 2, che “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.Da questa norma deriva, dunque, il fondamentale principio di autodeterminazione in ambito sanitario: gli accertamenti ed i trattamenti sanitari, cioè, sono volontari, nel senso che richiedono il consenso, espresso e specifico, dell’avente diritto, che ha il diritto di opporre un rifiuto alle cure.Tuttavia, la legge può prevedere l’obbligo di un determinato accertamento o trattamento sanitario, come una vaccinazione. Tale imposizione, secondo quanto affermato anche in tempi recenti dalla Corte costituzionale (Corte cost. 26 aprile 2012, n. 107), è legittima e compatibile con la Costituzione solo nella misura in cui dipenda dalla necessità di tutelare l’interesse, ritenuto superiore, alla protezione della sanità pubblica. Ancora, in una più risalente pronuncia (Corte cost. 307/1990), la stessa Corte costituzionale aveva precisato che “la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’articolo 32 della Costituzione se il trattamento sia diretto a migliorare o a preservare lo Stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell’uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale”.Da questo sintetico quadro deriva, dunque, che i trattamenti sanitari obbligatori sono legittimi se rispettano due requisiti:sono previsti da una legge dello Stato;sono diretti a tutelare un interesse collettivo. Peraltro, non sono rari i casi in cui il legislatore ha fatto ricorso allo strumento della vaccinazione obbligatoria per far fronte a gravi situazioni di emergenza sanitaria.Da ultimo, con il d.l. 44/2021, il nostro legislatore ha previsto l’obbligo di vaccinazione contro SARS-CoV-2 per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura ed assistenza.A fronte di tale potere, è oggi previsto, nella L. 210/1992, un indennizzo da parte dello Stato a favore di “chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie (…), lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica”.2 - La legge 210/1992 e l’indennizzo da vaccinazioni obbligatorieLa legge 210/1992 riconosce un indennizzo ai soggetti danneggiati in modo irreversibile da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati infetti.Per quanto qui interessa, secondo l’art. 1 della legge, “chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge, o per ordinanza, di un’autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato”.Si tratta di un riconoscimento in denaro ispirato al principio della solidarietà sociale, erogato a prescindere dal reddito del richiedente, esente dalle imposte sui redditi e cumulabile con altre eventuali provvidenze economiche percepite a qualsiasi titolo. Dà, inoltre, diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e dal pagamento della quota fissa per ricetta limitatamente alle prestazioni sanitarie per la diagnosi e la cura delle patologie vaccino-correlate. La legge stabilisce che l’indennizzo e gli altri benefici previsti spettano a chi, alternativamente:si è sottoposto a vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria;ha praticato vaccinazioni non obbligatorie, ma necessarie per motivi di lavoro o per incarichi d’ufficio o per poter accedere ad uno stato estero; rientra nella categoria dei soggetti a rischio operanti in strutture sanitarie ospedaliere» e, in quanto tale, si è sottoposto a vaccinazioni, anche non obbligatorie.L’indennizzo previsto dalla legge n. 210/1992 consiste in un assegno mensile vitalizio oppure, in caso di morte, in un assegno una tantum da erogare ai familiari del soggetto deceduto. La legge n. 229/2005 ha riconosciuto, inoltre, un indennizzo in favore sia dei soggetti danneggiati, sia dei congiunti che prestino al danneggiato assistenza in maniera prevalente o continuativa.Per quanto riguarda l’assegno vitalizio mensile, da corrispondersi qualora sia accertata una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica del richiedente causata dalla vaccinazione obbligatoria, l’indennità si compone di due quote: una somma determinata sulla base dell’invalidità accertata e un’indennità integrativa speciale. La prima delle due somme si determina sulla base di tabelle del Ministero della Salute: queste tabelle contengono otto categorie di invalidità, dalla più grave alla meno grave. Per il 2020, le tabelle hanno riconosciuto importi ricompresi fra euro 1.599,37 ed euro 1.791,01.In caso di patologie plurime, è possibile ottenere, un indennizzo aggiuntivo del 50% rispetto a quello stabilito per la patologia più grave. In caso di decesso, invece, gli eredi del danneggiato hanno diritto ad un assegno reversibile per 15 anni o ad un assegno una tantum pari a euro 77.468,53 ed alle rate di indennizzo maturate dalla data della domanda al giorno della morte. L’indennizzo deve essere richiesto con apposita domanda indirizzata all’Azienda Sanitaria di appartenenza. All’istanza deve essere allegata la documentazione che comprovi la data della vaccinazione, i dati relativi al vaccino, le manifestazioni cliniche conseguenti alla vaccinazione e l’entità delle lesioni o dell’infermità da cui è derivata la menomazione permanente. Se il danneggiato è deceduto, l’istanza può essere proposta dagli eredi. Ricevuta la domanda, l’Azienda Sanitaria la inoltrerà alla Commissione Medica Ospedaliera (CMO), che a sua volta provvede a convocare a visita medica l’interessato, ad esaminare la documentazione sanitaria e a redigere il giudizio sul nesso causale tra l’infermità e la trasfusione.Acquisito il parere, l’Azienda Sanitaria notifica all'interessato l'esito della sua istanza e, in caso di riconoscimento del diritto all'indennizzo, emette un decreto per la liquidazione e relativo mandato di pagamento.Il diritto all’indennizzo si prescrive in tre anni decorrenti dal momento in cui si è avuto piena conoscenza dei danni provocati dalla vaccinazione.3 - Precisazioni terminologiche: differenza fra indennizzo e risarcimentoCome abbiamo visto, quello che la legge riconosce in caso di menomazioni permanenti dell’integrità psico-fisica in conseguenza di vaccinazioni obbligatorie è un indennizzo e non un risarcimento. In estrema sintesi, l’indennizzo consegue ad un’azione lecita, consentita o addirittura imposta dall’ordinamento: pur in assenza di un fatto illecito, la legge ritiene comunque opportuno che il soggetto leso riceva una somma per equilibrare una situazione che rischierebbe di diventare ingiusta. Si tratta, in altri termini, di una misura di solidarietà sociale con funzione assistenziale.Il risarcimento, invece, è imposto dalla legge in tutti i casi in cui si debba riparare ad un danno ingiusto e trova il proprio presupposto nell’accertamento di una responsabilità colposa o dolosa dei sanitari. Pertanto, è possibile ottenere il risarcimento per i danni da vaccino nel caso in cui questi potevano essere previsti ed evitati, ad esempio perché il vaccino è stato eseguito nei confronti di un soggetto cui era controindicato. Quando, invece, non sia possibile ravvisare alcuna responsabilità in capo ai sanitari, il danno sarà semplicemente indennizzabile.Editor: dott.ssa Elena Pullano
Continua a leggere
Scritto da:

Egregio Avvocato
Networking nel settore legale: perché è così importante?
14 dic. 2020 • tempo di lettura 4 minuti
Networking significa intrattenere rapporti, alimentare connessioni e scambiare informazioni al fine di aumentare le proprie opportunità professionali e lo sviluppo della propria carriera. Il successo di ogni professionista, ed in particolare nel settore legale, dipende dal mantenimento e dall'espansione delle relazioni con i clienti esistenti e dall'attrazione di nuovi. Per far questo, è necessario incrementare il proprio network di conoscenze ed instaurare nuovi rapporti. Come in ogni settore, molto spesso non conta solo “cosa sappiamo” o “quanto siamo competenti”, ma anche “chi conosciamo”. Essere conosciuti da colleghi e clienti è necessario per poter essere scelti.Da sempre, la raccomandazione ed il passaparola sono strumenti fondamentali per costruire la propria “reputazione legale” e generare nuove opportunità di lavoro. Ma espandere i propri contatti oltre le conoscenze personali non è così semplice e basarsi su “chi potremmo conoscere direttamente” spesso non basta. Ancora di più se si deve competere in un mercato sempre più concorrenziale e soggetto a fattori di mutamento ed evoluzione continui. Per questo, entrare a far parte di una rete online di contatti professionali è uno strumento fondamentale per garantire all’avvocato non solo una maggiore visibilità nei confronti di potenziali clienti, ma soprattutto l’ampliamento delle proprie relazioni nel settore. E allora, se trovare nuovi riferimenti ed aumentare la propria presenza sul web è necessario per affrontare le sfide che l’attività professionale oggi pone, scegliere un giusto canale di networking aiuta il professionista a generare rapporti di lavoro. L’esigenza di essere trovati più facilmente da possibili clienti o datori di lavoro online spiega il successo che ha avuto Linkedin negli ultimi anni. La cui principale caratteristica sta nella creazione da parte dell’utente di una rete di contatti, che avvalorino le sue capacità e aumentino le sue opportunità. Per questo abbiamo creato Egregio Avvocato. Un network online esclusivamente e totalmente dedicato alla professione legale. Una community di avvocati a livello nazionale. Perché far parte di una rete composta da professionisti del diritto equivale a far parte di una rete di potenziali clienti.L’obiettivo di Egregio Avvocato è sicuramente far fronte alla sempre maggiore richiesta da parte degli utenti che, non sapendo a chi rivolgersi, cercano un avvocato online. Come può un avvocato essere trovato dall’utente se non è presente nel mondo digitale?Anche per coloro che già sono dotati di un sito web personale, essere rintracciabile non è così semplice. Ma, far parte di un gruppo aumenta la visibilità online dei singoli. Egregio Avvocato, attraverso la presenza sui social media – instagram, linkedin, facebook – la pubblicazione di articoli online e l’indicizzazione delle pagine personali degli avvocati con la tecnologia SEO, garantisce visibilità alla piattaforma ed alle pagine personali dei singoli avvocati. Ogni professionista avrà una vetrina professionale, nella quale potrà inserire le competenze acquisite, il percorso formativo svolto e case study che evidenziano le effettive esperienze maturate, ciò al fine di costruirsi una adeguata reputazione online. Attraverso la pubblicazione dei propri materiali di studio e approfondimento nelle aree dedicate della piattaforma digitale, l’avvocato genererà maggiori visite degli utenti sulla propria pagina personale e sul proprio sito web, aumentando così le possibilità di essere conosciuto e di acquisire nuovi clienti, interessati ad un consulto sulle tematiche trattate dal legale nei propri articoli. Ma la funzione di Egregio Avvocato non si esaurisce qui, piuttosto è volta alla creazione di un rapporto vivo e collaborativo tra colleghi del settore legale. Lo scambio di idee e la possibilità di esprimere la propria opinione sui contributi pubblicati da altri professionisti, permetterà all’avvocato di farsi conoscere sull’intero territorio nazionale e rimanere aggiornato sulle ultime tematiche in materia. Confrontarsi con colleghi esperti ed avere una visione d’insieme del problema, in una professione così complessa e soggetta a multidisciplinarietà, è senz’altro utile al fine di fornire una migliore consulenza al cliente ed arrivare a nuove soluzioni. Sfruttando le connessioni che la rete genera, il singolo professionista non solo attrae maggiori opportunità professionali, ma sviluppa le proprie aree di competenza personale. La possibilità di mostrare le proprie qualità lavorative permette al legale di essere raccomandato da colleghi che vogliono consigliare ai propri clienti un avvocato di altro foro o di altra area di competenza. Il feedback positivo, quando proviene da chi svolge una stessa professione, ha un fortissimo potere di influenza sui clienti. Ogni avvocato potrà poi rendersi disponibile a svolgere attività di domiciliazione, potendo in questo modo essere apprezzato da colleghi su tutto il territorio nazionale che potrebbero poi decidere di avviare ulteriori collaborazioni professionali. In conclusione, Egregio Avvocato è un progetto interamente dedicato alla carriera legale. Una piattaforma con cui non solo l’avvocato sarà presente nel mondo digitale e potrà essere trovato dai clienti che cercano un “avvocato online”, in modo più semplice ed efficace rispetto al proprio sito personale. Ma soprattutto una piattaforma attraverso la quale creare la propria rete di contatti nel mondo legale ed acquisire visibilità agli occhi dei colleghi, pubblicando i propri lavori ed attingendo ad approfondimenti e contributi di altri legali al fine di mantenersi informati ed accrescere le proprie conoscenze.
Continua a leggere
Scritto da:

Egregio Avvocato
Contratti bancari: a quale tasso prestare attenzione.
29 set. 2022 • tempo di lettura 2 minuti
La contrattazione bancaria è sempre molto complessa. Il cliente è, generalmente, chiamato a sottoscrivere dei moduli prestampati, ricchi di clausole e condizioni di non facile e immediata comprensione. Per tale ragione, molto spesso si finisce per accettare condizioni svantaggiose, nell'errata convinzione di non avere altra scelta.Ecco, quindi, un rimedio a tale problema: conoscere i tassi di interesse e sapere quale sia quello rivelatore della convenienza del contratto.Molto spesso, infatti, indotti anche da un'errata pubblicità, si ritiene che il tasso cui riferirsi per valutare il costo del contratto che si vuol sottoscrivere, mutuo-finanziamento-credito al consumo-, sia il TAN (tasso annuo di interesse nominale).In verità, il tasso da tenere sotto controllo è il TAEG (tasso annuale effettivo globale), che ha la funzione di indicazione di costo globale del contratto, espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito. Il TAEG, essendo un indicatore sintetico del costo totale del credito, si compone sia degli interessi, che del costo di tutti gli ulteriori elementi accessori connessi al contratto, cioè quegli oneri che l'istituto di credito pone a carico del cliente come condizione per la stipula (ad esempio le assicurazioni o altre garanzie richieste dalla banca).E' necessario che il cliente venga posto nelle condizioni di conoscere il TAEG del proprio contratto, prima della sua sottoscrizione e in modo chiaro e preciso.Tale indicatore, infatti, è il solo che consente un reale raffronto tra le offerte presenti sul mercato, potendo valutare la rispettiva convenienza.In altre parole, anche se lo slogan recita "TAN zero", bisogna prestare molta attenzione, perchè il TAEG potrebbe essere molto più elevato.Ancora diverso è il TEG (tasso effettivo globale), il quale è rilevante ai fini della determinazione delle soglie d'usura. Serve, dunque, per valutare se le condizioni di costo delle operazioni creditizie praticate dalle banche abbiano, o meno, carattere usurario.Per qualunque dubbio, rivolgiti ad un legale di fiducia che possa valutare con te il contratto che intendi stipulare, oppure che hai già sottoscritto.
Continua a leggere
Scritto da:
Commenti
Non ci sono commenti




