La simulazione del matrimonio

Avv. Elisa Calviello
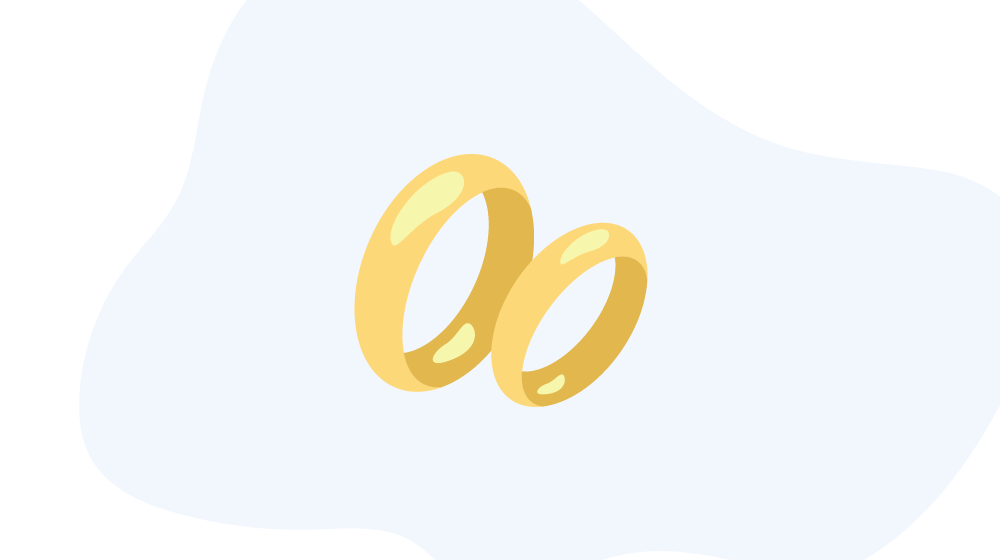
A differenza della simulazione contrattuale, il matrimonio simulato è un atto voluto, poiché le parti vogliono effettivamente conseguire lo status coniugale sia pure per la realizzazione di fini ad esso estranei.
Mentre il contratto simulato è inefficace, il matrimonio simulato, nonostante il patto di non esecuzione dei diritti e degli obblighi da esso discendenti, è soltanto annullabile ed è suscettibile di sanatoria.
In una prospettiva di valorizzazione del consenso e di certezza nel far corrispondere la realtà effettiva dei rapporti coniugali e dei relativi status giuridici, l’articolo 123 c.c. consente l’impugnazione del matrimonio (o dell’unione civile tra persone dello stesso sesso) contratto dagli sposi che abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e non esercitare i diritti da esso discendenti.
La norma è stata introdotta per far fronte a quei casi in cui il matrimonio avesse svolto una “funzione umanitaria di salvataggio” di persone esposte a persecuzioni; rientrano nell’ambito del matrimonio simulato anche il matrimonio di compiacenza, celebrato per soddisfare un desiderio del genitore in fin di vita; il matrimonio per l’acquisto di punteggi in vista dell’assegnazione di un alloggio e dell’ottenimento di un posto di lavoro; il matrimonio celebrato per assicurare alla donna un’adeguata sistemazione economica.
1. In cosa consiste l’accordo simulatorio?
2. Chi ha la legittimazione ad agire e qual è il termine di decadenza?
3. Come si prova la simulazione?
4. Simulazione, divorzio e separazione
1 – In cosa consiste l’accordo simulatorio?
Con il matrimonio simulato l’intento degli sposi è quello di creare, attraverso la celebrazione del matrimonio, una situazione apparente in ordine all’attuazione dei diritti e degli obblighi che ne formano il consenso tipico.
Il consenso prestato dagli sposi non esprime la reale volontà delle parti ma viene prestato per motivi che esulano dalle finalità proprie del matrimonio.
L’accordo simulatorio deve essere precedente alla celebrazione del matrimonio, ovvero gli sposi devono essere preventivamente accordati nel senso di escludere gli effetti propri del matrimonio.
Tale accordo simulatorio deve riguardare l’insieme dei diritti e dei doveri propri del rapporto coniugale e non solo singoli obblighi o diritti.
Pertanto, la simulazione parziale non produce alcun effetto invalidante sul matrimonio.
I motivi che hanno indotto gli sposi alla celebrazione del matrimonio sono del tutto irrilevanti, ma l’irrilevanza di tali motivi posti alla base dell’accordo si arresta di fronte alle ipotesi in cui le nozze costituiscano lo strumento per eludere norme di rilevanza pubblicistica, come quelle in materia di immigrazione o di cittadinanza.
2 - Chi ha la legittimazione ad agire e qual è il termine di decadenza?
La legittimazione a far valere la simulazione spetta soltanto ai coniugi, anche se tale soluzione è criticabile in quanto il negozio matrimoniale può essere anche strumentalizzato anche in danno di terzi o in frode alla legge, per cui, secondo una parte minoritaria della dottrina, la legittimazione attiva spetta anche al p.m. e, più in generale, a qualunque interessato.
Il secondo comma dell’articolo 123 c.c. al fine di conciliare l’impugnazione per simulazione con l’esigenza della certezza dei rapporti giuridici inerenti agli status stabilisce che l’azione non può essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi successivamente alla celebrazione medesima.
Quanto alla convivenza come coniugi, non è sufficiente la semplice coabitazione sotto lo stesso tetto ma è necessaria quella consuetudine di vita coniugale, stabile e continua nel tempo, esteriormente riconoscibile attraverso corrispondenti fatti specifici e comportamenti dei coniugi, che i coniugi stessi avevano inizialmente escluso con l’accordo simulatorio.
Non è prevista una durata minima della convivenza.
3 - Come si prova la simulazione?
La prova dell’accordo simulatorio può essere fornita con ogni mezzo: diversamente da quanto previsto in materia contrattuale ex art. 1417 c.c., è ammessa la prova testimoniale ma non la confessione e il giuramento, visti i profili di indisponibilità che governano il matrimonio.
Eventuali dichiarazioni scritte dovranno essere valutate con particolare attenzione, al fine di impedire facili strumentalizzazioni dell’azione in esame, atte a liberarsi di un matrimonio non più voluto.
4 - Simulazione, divorzio e separazione
Nel caso in cui l’incosumazione del matrimonio sia stata dai nubendi preordinata prima delle nozze, come avviene qualora il matrimonio sia simulato perché, ad esempio celebrato al solo fine di far acquistare alla moglie la cittadinanza italiana, è possibile ricorrere a due diversi rimedi per far venire meno il vincolo formale: a) dedurre l’invalidità del matrimonio per simulazione, da esprimere nel termine di decadenza di cui all’art. 123 c.c.; b) il divorzio per inconsumazione ex art. 3, n. 2, lett. f), L. 898/1970, che può essere fatto valere anche quando sia già maturato il termine di decadenza previsto per l’azione di simulazione.
Nel procedimento di separazione personale, l’esistenza di un accordo simulatorio, con l’intesa dei coniugi di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti discendenti dal matrimonio, può assumere rilevanza, ai fini dell’addebito della separazione sotto il profilo soggettivo, quale ragione del convincimento in buona fede del coniuge di non essere soggetto a detti obblighi.
Condividi:
Articoli che potrebbero interessarti
La "normale tollerabilità" nella disciplina delle immissioni, tra priorità d'uso ed esigenze di produzione
12 apr. 2025 • tempo di lettura 0 minuti
Il presente elaborato consiste in una analisi della più recente giurisprudenza di legittimità relativamente al concetto di "normale tollerabilità" nella disciplina delle immissioni ex art. 844 C.C. e del suo rapporto con i criteri della priorità d'uso e delle esigenze di produzione.Pubblicato il 22.09.2018 su Salvis Juribus (ISSN 2464-9775). Clicca qui per leggere l'articolo.
Continua a leggere
Scritto da:
Risarcimento danni da alienazione parentale: una nuova causa di responsabilità aquiliana?
2 ago. 2024 • tempo di lettura 2 minuti
La pas o più comunemente conosciuta come "sindrome" dell'alienazione parentale non è una malattia ma una condotta illecita.Si definisce "sindrome " da alienazione genitoriale il comportamento di un genitore,che, soprattutto in fase di separazione, scredita e allontana l'altra figura genitoriale.Appare opportuno sottolineare che tale disturbo esiste sia al maschile che al femminile.Le Corti italiane sono sempre state restie nel riconoscere tale condotta ma, recentemente, alcune aperture in tal senso si sono verificate. Al riguardo, vogliamo ricordare la vicenda al vaglio del Tribunale di Cosenza (Trib. Cosenza, 549/2019), che, chiamato a pronunciarsi sulla sindrome di alienazione parentale, ha accolto la richiesta di risarcimento danni avanzata da un padre avverso l'ex moglie, colpevole di aver emarginato la figura paterna per oltre tre anni. Il Tribunale, tenuto conto della durata della condotta della donna, dei presumibili disagi e sofferenze patite sia dal padre per il distacco - fisico ed emotivo - dal figlio, che dal figlio, privato dell'apporto del padre rispetto alla sua crescita, educazione e formazione, ha reputato equo liquidare il pregiudizio in Euro 5.000,00 per ciascuno dei soggetti danneggiati. Secondo i Giudici, anche prescindendo dalla valdità o invalidità teorica di questa sindrome, bisogna "accertare, in concreto, la sussistenza di tali condotte, alla stregua dei mezzi di prova propri della materia, quali l’ascolto del minore, nonché le presunzioni, ad esempio desumendo elementi anche dalla eventuale presenza di un legame simbiotico e patologico tra il figlio ed il genitore collocatario, motivando quindi adeguatamente sulla richiesta di modifica, tenendo conto che, a tale fine, e a tutela del diritto del minore alla bigenitorialità ed alla crescita equilibrata e serena, tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali del figlio con l’altro genitore, al di là di egoistiche considerazioni di rivalsa su quest’ultimo." Poichè non erano stati adeguatamente forniti elementi istruttori con cui ritenere provate le condotte di abuso da parte del padre – compresa la CTU – il Tribunale concludeva che l’allontanamento padre – figlio fosse stato causato dalla madre. Per tali ragioni, visto il condizionamento perpetrato dalla madre a danno del figlio e le carenze di entrambi i genitori di gestire il conflitto personale con modalità idonee a preservare l’equilibrio psichico del figlio, il Giudice di prime cure disponeva l’affidamento ai servizi sociali, ripristinava gli incontri padre e figlio e accoglieva la richiesta di risarcimento formulata da parte ricorrente per aver la madre "gravemente pregiudicato la relazione affettiva padre-figlio, in tal modo ledendo tanto il diritto del minore alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena, quanto il diritto dell’uomo di svolgere il proprio ruolo genitoriale."La soluzione appare pienamente condivisibile, anche e soprattutto alla luce di un fenomeno che è sempre più diffuso e che, pertanto, deve assumere valenza giuridica per evitare abusi del diritto ai danni di genitori vittime di rancori e depressioni dell'ex.Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo Matrimonialista - Divorzista - Curatore Speciale del Minore
Continua a leggere
Scritto da:
La cosiddetta “Giustizia lumaca” e l’equa riparazione prevista dalla Legge Pinto
27 mag. 2021 • tempo di lettura 7 minuti
Il tema della cosiddetta Giustizia Lumaca è, da anni, al centro del dibattito pubblico e svariati - e non sempre del tutto efficaci - sono stati i tentativi di riforma della giustizia italiana. Nell’ottica di una riduzione delle lungaggini dei processi sono stati introdotti vari metodi stragiudiziali ed alternativi di risoluzione delle dispute: i c.d. metodi ADR, dall’acronimo inglese Alternative Dispute Resolution.Tuttavia, il nostro ordinamento giuridico ha inteso prevedere, con l’emanazione della Legge Pinto, anche un procedimento per il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, derivanti dalla irragionevole durata del processo. Qual è, quindi, l’ambito di applicazione della Legge Pinto? Quali sono i presupposti per la richiesta del risarcimento dei danni? Come si svolge il relativo procedimento?La Legge Pinto: perché è stata introdotta? Qual è il suo ambito di applicazione?Quali sono i presupposti per la proposizione della domanda di equa riparazione?Come identificare il danno risarcibile?Come si svolge il relativo procedimento?1 - La Legge Pinto: perché è stata introdotta? Qual è il suo ambito di applicazione?La Legge n. 89 del 24 marzo 2001, nota come Legge Pinto, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico un apposito procedimento per il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, che derivino dalla durata irragionevole del processo.Ma, in concreto, qual è la ratio di questa legge?La risposta a tale quesito è immediata: tutelare il principio di ragionevole durata dei processi sancito dall’articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e costituzionalizzato, quale corollario del principio del giusto processo, dalla nostra Costituzione all’articolo 111, il cui secondo comma testualmente recita «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata».Prescindendo dal grado in cui si concludono, il procedimento introdotto dalla Legge Pinto si applica alle controversie civili, ai procedimenti penali ed amministrativi, alle procedure fallimentari ed anche ai procedimenti tributari.2 - Quali sono i presupposti per la proposizione della domanda di equa riparazione?Ai fini della proposizione della domanda di equa riparazione prevista dalla Legge Pinto è necessario il rispetto di alcuni requisiti. In particolare: l’irragionevole durata del processo, l’attuazione dei c.d. rimedi preventivi, l’esistenza di un danno e il nesso di causalità tra l’irragionevole durata del processo e il danno.Ma, nel concreto, quando si può dire che un processo si sia concluso in un termine ragionevole?L’articolo 2, comma 2 bis della Legge Pinto prevede che il termine di ragionevole durata del processo sia rispettato se non eccede la durata di:3 anni per i procedimenti di primo grado;2 anni per i procedimenti di secondo grado;1 anno per il giudizio di legittimità;3 anni per i procedimenti di esecuzione forzata;6 anni per le procedure concorsuali.In ogni caso, va detto che il termine ragionevole è rispettato laddove il giudizio sia definitivo in modo irrevocabile in un tempo non superiore a 6 anni.Per quanto riguarda il computo della durata è opportuno riferirsi a criteri diversi a seconda della natura del processo. Nel processo civile, il termine decorre dal deposito del ricorso introduttivo ovvero dalla notifica dell’atto di citazione. Invece, nel processo penale, il termine decorre dal momento in cui il soggetto indagato viene a conoscenza del procedimento a suo carico mediante atto dell’autorità giudiziaria.Come detto, la ragionevole durata del processo non è l’unico requisito richiesto affinché si possa proporre il procedimento per l’equa riparazione. Difatti, sono necessari anche i cosiddetti rimedi preventivi. A far data dal 31 ottobre 2016, invero, la procedura prevista dalla Legge Pinto è attivabile, a pena di inammissibilità, esclusivamente dopo aver esperito tali rimedi preventivi che variano a seconda del procedimento contestato.In particolar modo, nel processo civile il rimedio preventivo è rappresentato dalla proposizione del giudizio con rito sommario ovvero dalla richiesta di passaggio dal rito ordinario a quello sommario da effettuarsi entro l’udienza di trattazione e, comunque, almeno sei mesi prima che trascorrano i tre anni del primo grado di giudizio. Nell’ipotesi in cui non sia possibile il rito sommario di cognizione, invece, il rimedio preventivo nel processo civile è rappresentato dalla richiesta di trattazione orale prevista dall’articolo 281 sexies del codice di procedura civile, da effettuare sei mesi prima che scada il termine di ragionevole durata del processo.Per quanto concerne il processo penale, il rimedio preventivo è rappresentato dalla cosiddetta istanza di accelerazione, anch’essa da presentare sei mesi prima che spiri il termine di ragionevole durata del processo. In maniera del tutto similare, nei processi contabili e pensionistici dinanzi alla Corte dei Conti e alla Corte di Cassazione, il rimedio preventivo è esperito con la presentazione di un’istanza di accelerazione, in questi casi da presentare, rispettivamente, almeno sei mesi ed almeno due mesi prima della scadenza del termine di ragionevole durata.Nel processo amministrativo, infine, il rimedio preventivo è rappresentato dal deposito di un’istanza con cui si segnala l’urgenza.3 - Come identificare il danno risarcibile?Appurata l’irragionevole durata del processo ed esperiti, a pena di inammissibilità, i rimedi preventivi, è necessario provare l’esistenza di un danno, nonché il relativo nesso causale.Ma cosa prevede, nello specifico, la Legge Pinto?La Legge n. 89/2001, per come modificata nel corso degli anni, sancisce chiaramente che chi, pur avendo esperito i rimedi preventivi […], ha subìto un danno patrimoniale o non patrimoniale a causa dell’irragionevole durata del processo ha diritto ad una equa riparazione.In particolare, è possibile richiedere la riparazione del danno patrimoniale nella sua duplice accezione di danno emergente, ossia la perdita economica effettivamente subìta, e di lucro cessante, vale a dire il mancato guadagno che, invece, si sarebbe potuto produrre se il processo si fosse concluso entro i termini della ragionevole durata.Anche per ciò che concerne il danno non patrimoniale è opportuno distinguere diverse, per così dire, “tipologie”. Infatti, può essere richiesto il danno morale, relativamente al turbamento dello stato d’animo del soggetto interessato, il danno biologico, nell’ipotesi di lesione dell’interesse all’integrità psichica e fisica della persona, ovviamente a seguito di accertamento medico, ed il danno esistenziale, laddove si provi l’esistenza della lesione di altri interessi di rango costituzionale riguardanti la persona interessata.È comunque ovvio che il danno vada provato e, seguendo l’orientamento prevalente, l’onere grava sul soggetto ricorrente.4 - Come si svolge il relativo procedimento?Il procedimento di equa riparazione si svolge in due fasi. La prima, sempre necessaria, si svolge, , inaudita altera parte, vale a dire sulla base del solo ricorso presentato dal soggetto interessato.La seconda fase, invece, solo eventuale, si svolge in contraddittorio, nel caso in cui vi sia opposizione. Come accennato, la domanda si propone con ricorso, che deve necessariamente contenere gli elementi prescritti dall’articolo 125 del codice di procedura civile e deve essere presentato al Presidente della Corte d’Appello del distretto in cui ha sede il Giudice dinanzi al quale si è svolto il primo grado del processo di cui si contesta l’irragionevole durata.Il ricorso è presentato nei confronti: del Ministro della giustizia in ipotesi di procedimenti del giudice ordinario; del Ministro della difesa quando si tratti di procedimenti del giudice militare;del Ministro dell’economia e delle finanze, in tutti gli altri casi.Unitamente al ricorso è necessario il deposito di copia autentica di:atto di citazione, ricorso, comparse e memorie relative al procedimento nel cui ambito si asserisce che si sia verificata la violazione;verbali di causa e provvedimenti del giudice;provvedimento che ha definito il giudizio, ove questo si sia concluso con sentenza o con ordinanza irrevocabili.Inizialmente, la Legge Pinto prevedeva che il ricorso dovesse essere presentato entro sei mesi dal momento in cui la decisione che concludeva il procedimento fosse divenuta definitiva. Tuttavia, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 88 del 2018, ha parzialmente dichiarato incostituzionale tale previsione, prevedendo, così, la possibilità di proporre domanda di equa riparazione anche in pendenza di procedimento.Il Presidente della Corte d’Appello – o altro magistrato designato – deve pronunciarsi sulla domanda di equa riparazione entro il termine di 30 giorni dal deposito del ricorso.In caso di accoglimento della domanda, il Giudice ingiunge, con decreto motivato provvisoriamente esecutivo, all’amministrazione interessata, di pagare la somma liquidata a titolo di equa riparazione. Tale indennizzo si determina ai sensi dell’articolo 2056 del codice civile tenendo conto dell’esito del processo in cui è verificata la violazione, del comportamento del Giudice e delle parti, della natura degli interessi coinvolti e del valore e della rilevanza della causa.L’indennizzo liquidato dal Giudice non può essere inferiore a € 400,00 né superiore a € 800,00 per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi che ecceda il termine di ragionevole durata.Editor: avv. Marco Mezzi
Continua a leggere
Scritto da:

Egregio Avvocato
L'avvocato familiarista, definito anche avvocato matrimonialista o divorzista, è un Professionista specializzato in diritto di famiglia, tra i cui temi rientrano, tra gli altri, matrimonio, unioni civili, coppie di fatto, separazioni e divorzi, nonché i diritti della persona, dei minori e delle successioni. Oggi, desideriamo far luce sulle principali questioni che riguardano i figli nati al di fuori del matrimonio, oggetto di domanda o discussione poste da moltissime coppie non coniugate Riconoscimento del figlio nato da coppia non sposata: Il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto dai genitori (purchè più grandi di 16 anni), anche se già uniti in matrimonio con altra persona all’epoca del concepimento, tanto congiuntamente quanto separatamente. In caso di genitori con età inferiore ai 16 anni, è necessario che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all’interesse del figlio. Qualora il minore abbia compiuto 14 anni il riconoscimento è subordinato al suo assenso, in quanto si presuppone che a 14 anni l'individuo abbia raggiunto un grado di maturità tale da consentirgli di decidere sul suo interesse ad acquistare un nuovo status. Invece, il riconoscimento del figlio che non ha compiuto 14 anni non può avvenire senza il consenso dell’altro genitore se questo ha già effettuato il riconoscimento. Tuttavia, il consenso non può essere rifiutato ove il riconoscimento risponda all’interesse del figlio. Per opporvisi, chi vi abbia già provveduto deve provare l’esistenza di circostanze eccezionali tali da comportare, ove il secondo riconoscimento venga effettuato, un serio pregiudizio per lo sviluppo psicofisico del minore. In proposito, non rilevano valutazioni comparative dei due genitori, né apprezzamenti negativi circa la personalità o la condotta di chi intende effettuare il secondo riconoscimento, se non nei limiti in cui possano evidenziare che l’acquisto di quei diritti sia foriero, per il minore stesso, più di nocumento che di vantaggio. Che succede se un genitore non vuol far riconoscere il figlio all’altro. La conflittualità tra i genitori, come pure la mancanza di affetto, la diversità culturale, di origini, di etnia e di religione e una condotta morale non esente da censure (a meno che questi sia parte di un'organizzazione criminale o sia detenuto per gravi motivi) non sono una valida ragione per negare il proprio consenso al riconoscimento del figlio da parte dell’altro genitore. Soltanto il fanatismo religioso può assumere rilievo dirimente, qualora esso si traduca in un’indebita compressione dei diritti di libertà del minore o in un pericolo per la sua crescita. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, se il consenso dell’altro genitore è rifiutato, ricorre al giudice competente, che fissa un termine per la notifica del ricorso all’altro genitore. Se entro trenta giorni dalla notifica non viene proposta opposizione, il giudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante. Se viene proposta opposizione, il giudice, assunta ogni opportuna informazione, dispone l’audizione del figlio minore che abbia compiuto quattordici anni, o anche di età inferiore, ove capace di discernimento, e assume eventuali provvedimenti provvisori e urgenti al fine di istaurare la relazione, salvo che l’opposizione non sia palesemente infondata. Come si fa il riconoscimento del figlio di una coppia non sposata? Il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio è fatto nell’atto di nascita, oppure con un’apposita dichiarazione, posteriore alla nascita, davanti ad un ufficiale dello stato civile o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo. Il riconoscimento è irrevocabile. Quando è contenuto in un testamento ha effetto dal giorno della morte del testatore, anche se il testamento è stato revocato. L’atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non può contenere indicazioni relative all’altro genitore. Cosa succede con il riconoscimento del figlio? Il riconoscimento comporta da parte del genitore l’assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli. In capo al genitore che procede al riconoscimento, dunque, sorgono gli obblighi di educazione, di istruzione, di assistenza morale e di mantenimento fino all’indipendenza economica. Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. L’obbligo di mantenere il figlio decorre dal momento della nascita, anche nel caso in cui il riconoscimento avvenga a distanza di vari anni dalla nascita, pertanto il genitore che ha effettuato successivamente il riconoscimento deve rimborsare pro quota l’altro genitore che abbia integralmente provveduto al mantenimento del figlio medesimo, tenuto conto di quanto l’obbligato avrebbe dovuto corrispondere qualora il riconoscimento avesse avuto luogo fin dalla nascita del figlio, Il figlio nato da coppia non sposata è erede? I figli nati fuori del matrimonio hanno gli stessi diritti sull’eredità dei genitori rispetto ai figli nati all’interno del matrimonio. Quale cognome prende il figlio di una coppia non sposata? Il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome sia del padre che della madre. Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre. Che cosa si può fare quanto uno dei genitori non riconosce il figlio? In tal caso, l’altro può trascinarlo in tribunale affinché sia il giudice ad accettare il rapporto di filiazione. La maternità è dimostrata provando l’identità di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre.La paternità viene di solito dimostrata tramite il test del Dna. Il padre non può esimersi senza giustificato motivo al prelievo del sangue. L’eventuale rifiuto comporta l’automatico riconoscimento del figlio da parte del giudice. La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all’epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità naturale. Non assume carattere di prova assoluta e certa neanche la dimostrazione dell’esistenza di rapporti sessuali tra la madre e il preteso padre durante il periodo del concepimento. Ciò, tuttavia, non esclude che tali circostanze, nel concorso di altri elementi, anche presuntivi, possano essere utilizzate a sostegno del proprio convincimento dal giudice del merito. Questi è infatti dotato di ampio potere discrezionale e può legittimamente basare il proprio apprezzamento in ordine all’esistenza del rapporto di filiazione anche su risultanze probatorie indiziarie, previa indicazione degli elementi su cui intende fondare la pronuncia. L’azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità può essere promossa: dal figlio; dai discendenti se il figlio muore prima di avere iniziato l’azione; dal genitore esercente la responsabilità genitoriale se il figlio è minore; dal tutore per l’interdetto. . Se il figlio ha compiuto l’età di 14 anni occorre il suo consenso quale presupposto necessario per promuovere o per proseguire l’azione. L’azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità o la maternità, se condotta dal figlio, non cade mai in prescrizione. La sentenza che dichiara la filiazione produce gli effetti del riconoscimento.
23 set. 2024 • tempo di lettura 2 minuti
Il coniuge che lascia la propria abitazione è, nell'immaginario collettivo, l'origine scatenante la crisi del rapporto matrimoniale. Ad un'attenta analisi, però, non può sfuggire che, invece, la crisi matrimoniale affonda le sue ragioni in un momento antecedente, pertanto l'andarsene via di casa rappresenta solo la plateale esplosione di un malessere che già da tempo covava nella coppia.La ragione per una tale drastica decisione può avere diverse spiegazioni logiche, che esulano dagli scopi di questo intervento. Quello che dobbiamo precisare è la rilevanza giuridica di un tale atto.Oggi, non vi è più il reato di abbandono del tetto coniugale, ma questo gesto può avere delle importanti conseguenze sul piano civilistico in sede di separazione e divorzio. Un tale gesto, infatti, può avere conseguenze importanti ai fini dell'addebito, ragion per cui - qualora ci si dovesse decidere di farlo - è opportuno pianificare le proprie azioni con il proprio legale, onde evitare spiacevoli conseguenze. Pertanto, riteniamo opportuno suggerire di non abbandonare mai la casa coniugale, cercando di resistere - laddove possibile - fino all'udienza presidenziale. Ovviamente, laddove dovessero presentarsi situazioni gravemente conflittuali o il pericolo di strumentalizzazioni o false denunce di violenza, è meglio depositare un ricorso e andare via da casa. In ogni caso, tali decisioni debbono essere attentamente valutate comunemente con il proprio difensore, in quanto, in via astrattamente teorica, esistono delle situazioni in cui l’abbandono immediato della casa coniugale è la soluzione migliore per tutelarsi; difatti, è considerata prevalente la tutela del coniuge eventualmente vittima di episodi di violenza psicologica o fisica. In questi casi, diventa fondamentale far prevalere il diritto del soggetto ad allontanarsi dalla fonte della violenza, rappresentata dall’altro coniuge.Recentemente, la Suprema Corte (Cass. N. 20228/2022) si è interessata all'argomento, asserendo che "l’abbandono della casa coniugale da parte di uno dei coniugi non costituisce presupposto per l’addebito della separazione qualora la convivenza sia già divenuta intollerabile, non avendo quindi alcuna efficacia causale sulla rottura del vincolo coniugale". Sulla stessa scia, gli Ermellini si erano già espressi precedentemente (Cass. Sez. I, 16.04.2018, n. 9384), sottolineando che “l’abbandono del tetto coniugale è giustificato dalla violazione degli obblighi di fedeltà da parte del marito, intento alla ricerca di relazioni extraconiugali tramite internet. Ciò costituisce una circostanza oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi ed a provocare l’insorgere della crisi matrimoniale all’origine della separazione”.In conclusione, appare opportuno valutare attentamente, insieme al proprio procuratore, tutte i fattori presenti e decidere, sempre di comune accordo, sul da farsi. In ogni caso, sono da evitare i colpi di testa insensati e non opportunamente ponderati.Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo Matrimonialista - Divorzista - Curatore Speciale del Minore
Continua a leggere
Scritto da:
Commenti
Non ci sono commenti





