Pubblicità ingannevole: come denunciarla?

Egregio Avvocato
Pubblicato il 14 nov. 2021 · tempo di lettura 1 minuti
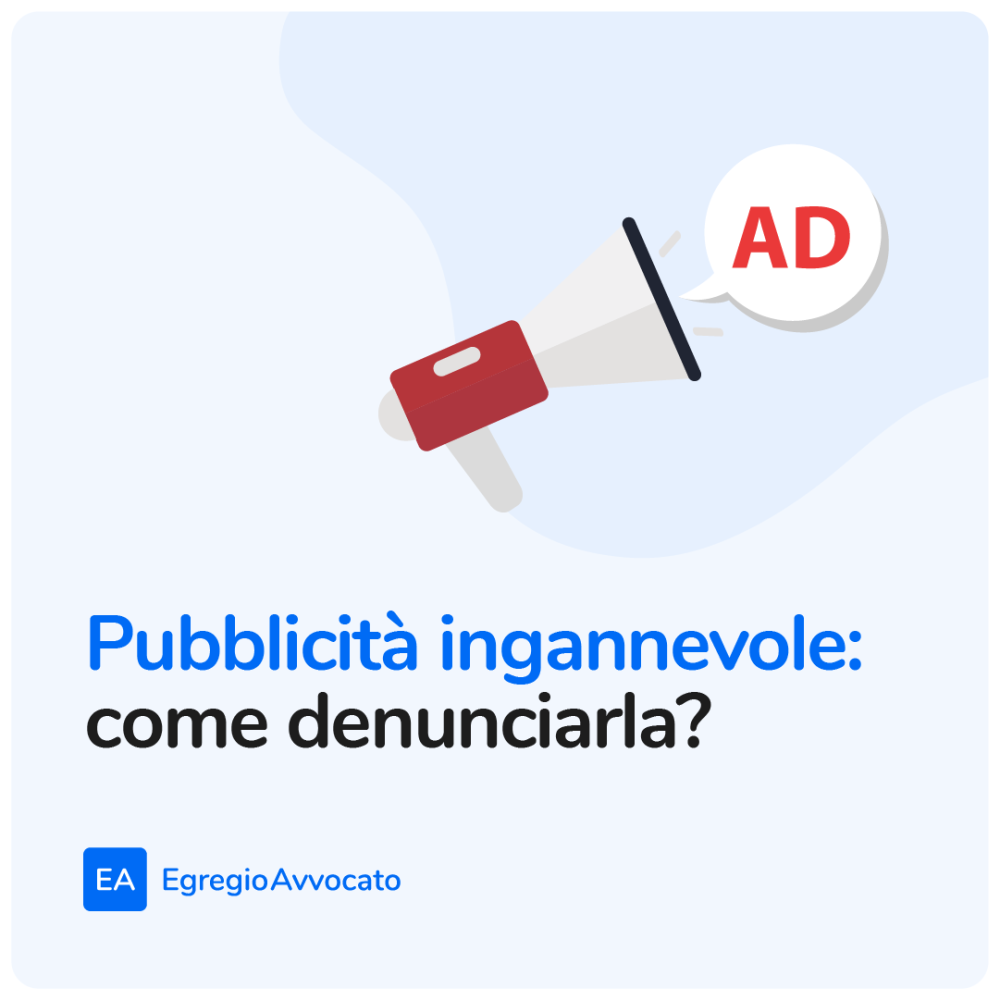
Per pubblicità ingannevole si intende la pratica commerciale posta in essere da un professionista in modo scorretto. In contrasto con il principio della diligenza professionale, la pubblicità ingannevole induce in errore il consumatore medio, falsandone il processo decisionale (acquista un prodotto che non avrebbe acquistato). Le informazioni ingannevoli possono riguardare il prezzo, le caratteristiche del prodotto, i rischi connessi al suo impiego.
Ogni cittadino e qualsiasi associazione che ne abbia interesse può richiedere l’intervento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust) per denunciare i casi di pubblicità ingannevole e le pratiche commerciali scorrette.
Nei casi in cui l’Antitrust ritenga esistenti sufficienti elementi probatori, avvia il procedimento amministrativo: il termine di conclusione del procedimento è di 120 giorni, decorrenti dalla data di protocollo della comunicazione di avvio, e di 150 giorni quando si debba chiedere il parere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom).
Si può segnalare attraverso i seguenti canali:
- tramite posta ordinaria inviando la segnalazione all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Piazza Giuseppe Verdi 6/A – 00198 Roma;
- inviando la segnalazione scritta alla casella di posta elettronica certificata: protocollo.agcm@pec.agcm.it;
compilando e inviando on line il modulo cui si accede tramite il sito www.agcm.it/segnala-online/index.
Condividi:
Pubblicità ingannevole: come denunciarla?
Pubblicato da:

Egregio Avvocato
Articoli che potrebbero interessarti
La famiglia di fatto: aspetti giuridici e patrimoniali
12 gen. 2026 • tempo di lettura 4 minuti
Fino a pochi anni fa, il diritto italiano riconosceva e tutelava esclusivamente la famiglia fondata sul matrimonio. La situazione è cambiata radicalmente nel 2016, quando la Legge Cirinnà ha introdotto un quadro normativo per disciplinare le convivenze di fatto. Questa legge ha formalmente riconosciuto "lo stabile legame affettivo che unisce due persone maggiorenni non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile", prendendo atto dei mutamenti sociali del Paese.A quasi un decennio dall'entrata in vigore, sebbene la legge abbia fornito un'ossatura solida, permangono ancora questioni interpretative che destano non poca preoccupazione in Giurisprudenza. Al riguardo, cercheremo di sintetizzare i diversi istituti analizzandone il contenuto in maniera separata: 1. Requisiti per la CostituzioneLa convivenza di fatto è un istituto aperto a coppie (eterosessuali o omosessuali) che, pur non volendo sposarsi o unirsi civilmente, desiderano formalizzare la loro relazione. I requisiti fondamentali includono: Soggettivi: Entrambi i partner devono essere maggiorenni, liberi da altri vincoli legali e uniti da un legame affettivo stabile e reciproca assistenza morale e materiale.Oggettivi: La coppia deve coabitare e avere la dimora abituale nello stesso Comune. Questa condizione deve essere formalizzata tramite l'iscrizione congiunta allo stato di famiglia presso l'anagrafe comunale.2. Diritti e Doveri Durante la ConvivenzaLa legge stabilisce specifici diritti e doveri per i conviventi formalizzati:Assistenza: Obbligo reciproco di assistenza morale e materiale.Rappresentanza: Possibilità di designare il partner (tramite atto scritto) per decisioni mediche urgenti o disposizioni post-mortem (es. donazione organi, funerale).Diritti Economici: Il convivente che lavora stabilmente nell'impresa del partner ha diritto a una partecipazione agli utili proporzionata al lavoro svolto.Abitazione: In caso di morte del partner proprietario, il superstite ha diritto di abitare nella casa familiare da 2 a 5 anni (estendibile in presenza di figli minori o disabili). In caso di locazione, il convivente superstite subentra nel contratto.3. Gestione Patrimoniale: Il Contratto di ConvivenzaA differenza del matrimonio, per i conviventi non esiste un regime patrimoniale legale automatico (come la comunione dei beni). Per gestire gli aspetti economici, è necessario stipulare un contratto di convivenza in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata. Questo contratto permette di definire il regime patrimoniale, il contributo alle spese e le disposizioni per un futuro scioglimento. 4. Modalità di Scioglimento La convivenza di fatto cessa in diversi modi:Volontà Congiunta: Entrambi i conviventi dichiarano congiuntamente la cessazione all'anagrafe.Atto Unilaterale: Un solo convivente comunica la decisione di interrompere il rapporto, notificandola all'altro e all'ufficio anagrafe.Nuovi Vincoli: Uno o entrambi i partner contraggono matrimonio o unione civile (tra loro o con terzi).Decesso: Morte di uno dei conviventi.Cessazione della Coabitazione: Quando i partner prendono residenze separate.5. Conseguenze Economiche Dalla formazione della famiglia di fatto derivano le seguenti conseguenze economiche:Assegno di Mantenimento: Non è mai previsto un assegno di mantenimento come per i coniugi separati.Assegno Alimentare: L'unica eccezione è l'assegno alimentare, richiedibile dal partner che si trova in un grave stato di bisogno e non è autosufficiente. La sua durata è proporzionale alla durata della convivenza e l'obbligo è sussidiario rispetto a quello di altri parenti (figli, genitori). La richiesta dell'assegno alimentare richiede un procedimento separato e autonomo presso il Tribunale Ordinario, distinto da eventuali ricorsi per la regolamentazione dei rapporti genitoriali.La Corte di Cassazione ha recentemente rafforzato il riconoscimento delle unioni di fatto come formazioni sociali rilevanti ai sensi dell'Art. 2 della Costituzione, riconoscendo che i doveri morali e sociali tra i partner possono talvolta tradursi in "obbligazioni naturali" che permangono anche dopo la fine del rapporto. Dice, infatti, la Suprema Corte (Cass. 02.01.2025, n. 28): "le unioni di fatto sono un diffuso fenomeno sociale (…) e sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale, di ciascun convivente nei confronti dell’altro, che possono concretizzarsi in attività di assistenza materiale e di contribuzione economica prestata non solo nel corso del rapporto di convivenza, ma anche nel periodo successivo alla cessazione dello stesso e che possono configurarsi, avuto riguardo alla specificità del caso concreto, come adempimento di un’obbligazione naturale (…)”.Tale orientamento riprende quanto già in precedenza affermato dalla stessa Cassazione, (cfr. Cass. civ. 16864/2023), secondo cui "le unioni di fatto, quali formazioni sociali che presentano significative analogie con la famiglia formatasi nell'ambito di un legame matrimoniale, assumono rilievo ai sensi dell'art. 2 Cost." 6. Tutela dei Figli La legge garantisce piena parità giuridica a tutti i figli, indipendentemente dallo status civile dei genitori. In caso di scioglimento della convivenza, i genitori sono tenuti a regolamentare i rapporti genitoriali (affidamento, mantenimento) nell'esclusivo interesse dei minori o dei figli maggiorenni non autosufficienti.In conclusione, è possibile affermare che il Legislatore, prendendo spunto da un fenomeno oggigiorno assai diffuso, ha inteso regolamentare questo aspetto della vita quotidiana, adattando i principi regolatori del matrimonio a questa fattispecie, ed eliminando l'alea di incertezza che, in assenza di una regolamentazione legislativa, si era creata. D'altro canto, però, non si può sottacere come parte della dottrina più tradizionalista abbia criticato questa impostazione, volta de facto a smantellare il tessuto sociale tradizionale, fondato sul matrimonio e derivante dalla millenaria tradizione e dall'eterno insegnamento di Santa Romana Chiesa. Lasciamo ai posteri il compito di valutare, ex post, eventuali conseguenze della regolamentazione qui esposta. In un successivo intervento ci occuperemo di analizzare i contenuti del contratto di convivenza.
Continua a leggere
Scritto da:
Il diritto di accesso agli atti amministrativi: l’accesso procedimentale
4 ott. 2021 • tempo di lettura 6 minuti
Il diritto di accesso agli atti amministrativi, in ossequio al principio di trasparenza dell’azione pubblica, consente ai cittadini di ottenere una informazione qualificata, di accedere ai documenti amministrativi e conoscere, nei limiti precisati dalla legge, lo stato dei procedimenti amministrativi che li riguardano, seguendo le fasi attraverso cui l’attività amministrativa si articola. Vediamo come tale diritto è riconosciuto e tutelato nel nostro ordinamento.Che cosa si intende per “diritto di accesso agli atti amministrativi”?Le tre tipologie di accesso codificate dal legislatore: cenniL’accesso procedimentale 3.1. Presupposti 3.2. Limiti 3.3. Procedimento1 - Che cosa si intende per “diritto di accesso agli atti amministrativi”?Il diritto di accesso è uno strumento che consente la partecipazione dei cittadini all’azione amministrativa, permettendo loro di esercitare un controllo sull’agire pubblico. Si tratta di un istituto che affonda le proprie radici nel principio di trasparenza della Pubblica Amministrazione. Per trasparenza, in particolare, si intende l’accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini e di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. La trasparenza, pertanto, concorre a attuare i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse. Come principio ha un fondamento espresso in ambito sovranazionale: l’art. 15 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e l’art. 42 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE affermano, infatti, che “Qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, a prescindere dal loro supporto (…)”. Il TFUE, inoltre, impone agli Stati di garantire la trasparenza dei propri lavori e di definire nel proprio regolamento interno disposizioni specifiche riguardanti l'accesso ai propri documenti.Vediamo allora come l’ordinamento italiano ha disciplinato il diritto di accesso.2 - Le tipologie di accesso agli atti amministrativi codificate dal legislatore: cenniIl nostro ordinamento conosce tre diverse tipologie di diritto di accesso agli atti amministrativi, rispondenti a esigenze diverse e caratterizzate da presupposti differenti:accesso procedimentale: consente a chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale di accedere ad un documento e di estrarne copia. Può essere esercitato solo nell’ambito di un procedimento amministrativo, cioè quella particolare procedura che culmina con l’adozione di un provvedimento amministrativo;accesso civico: nella sua forma “semplice” consente a chiunque, a prescindere da un interesse diretto, concreto e attuale, di prendere visione dei dati, delle informazioni e dei documenti per cui sussiste un obbligo di pubblicazione in capo alla p.a.; nella sua forma “generalizzata”, invece, consente a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle amministrazioni pubbliche, ulteriori rispetto a quelli per i quali vige un obbligo di pubblicazione.In questo contributo ci concentreremo sull’accesso procedimentale e approfondiremo, prossimamente, le altre due tipologie di accesso.3 - Accesso procedimentaleL’accesso procedimentale è disciplinato dalla l. 241/1990 e dal d.p.r. 184/2006: ai sensi dell’art. 10 della l. 241/1990 consiste nel diritto di “prendere visione degli atti del procedimento”. Questa tipologia di accesso, pertanto, può esercitarsi soltanto nell’ambito di un procedimento amministrativo.3.1 - PresuppostiCome abbiamo anticipato, i soggetti legittimati ad esercitare il diritto di accesso sono, ai sensi dell’art. 22 della l. 241/1990 tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”. Pertanto, la facoltà di accedere ai documenti detenuti dalla p.a. non è attribuita a chiunque ma unicamente ai soggetti titolari di una posizione differenziata e collegata al documento di cui si chiede l’ostensione.I soggetti passivi del diritto di accesso, cioè coloro nei confronti dei quali il diritto si esercita, sono le pubbliche amministrazioni, le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici e i gestori di pubblici servizi, nonché i privati limitatamente alla loro attività di pubblico interesse. Oggetto del diritto di accesso sono i “documenti amministrativi”, nel senso precisato dall’art. 22 della l. 241/1990. Si tratta di una definizione ampia, che comprende atti non solo scritti su supporto cartaceo ma anche in formato digitale; non soltanto i provvedimenti finali ma anche gli atti interni o endoprocedimentali; non solo gli atti amministrativi ma anche gli atti formati dai privati che confluiscono nel procedimento, come pareri legali o progetti tecnici. 3.2 - LimitiL’art. 24 l. 241/1990 prevede, poi, alcune ipotesi di esclusione dal diritto di accesso. In primo luogo, non sono suscettibili di essere conosciuti dai cittadini: i documenti coperti da segreto di Stato;i documenti oggetto di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge; i procedimenti tributari; l'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione; i procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi. È previsto, inoltre, un generale divieto dell’accesso che sia finalizzato ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni. 3.3 - ProcedimentoPer poter accedere a un documento amministrativo, l’interessato deve presentare un’istanza di accesso all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente. Tale richiesta deve essere motivata, deve contenere l’indicazione degli estremi del documento e deve far constatare l’identità del richiedente. L’istanza può essere presentata fino a quando la pubblica amministrazione ha l’obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.L’istanza può essere di due tipologie, a seconda delle peculiarità del caso concreto:qualora, in base alla natura del documento richiesto non risulti l’esistenza di controinteressati (soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio del diritto di accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza), l’accesso è informale: può essere esercitato mediante richiesta, anche verbale, all’ufficio dell’amministrazione, che esamina immediatamente e senza formalità la richiesta e la accoglie mediante esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea;qualora, invece, risulti, alla stregua delle informazioni esistenti, l'esistenza di controinteressati ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse ovvero sull'accessibilità del documento, l’accesso è formale: l’istante dovrà formalizzare l’istanza utilizzando l'apposito modulo (chiamato “Richiesta di accesso agli atti”) da presentare all'ufficio che detiene l'atto o allo Sportello Unico Servizi. A seguito della domanda di accesso, si aprono quattro possibili scenari:l’amministrazione accoglie l’istanza: in questo caso il privato può esercitare il diritto di accesso mediante esame gratuito ed estrazione di copia del documento, quest’ultima subordinata al rimborso del costo di riproduzione; l’esame è effettuato direttamente dal richiedente o da persona da lui incaricata. L’amministrazione può anche accogliere parzialmente l’istanza, limitando la portata dell’accesso solo ad alcune parti del documento: in questo caso deve espressamente motivare la propria scelta;l’amministrazione differisce l’accesso: in questo caso l’amministrazione deve motivare le ragioni per cui ritiene opportuno differire l’accesso. La legge prevede, inoltre, che l’accesso non può essere negato laddove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento;l’amministrazione nega l’accesso: il rifiuto può avvenire quando siano carenti i requisiti di legittimazione del richiedente e di relativa motivazione o quando gli atti richiesti siano sottratti all’accesso; in tal caso c’è un obbligo di motivazione;l’amministrazione rimane inerte: ai sensi dell’art. 25 co. 4 l. 241/1990, trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta questa si intende respinta (c.d. “silenzio-rigetto”).Contro il diniego o il differimento dell’accesso, il richiedente può presentare un ricorso giurisdizionale al giudice competente o un ricorso amministrativo al difensore civico (per gli atti degli enti territoriali) o alla Commissione nazionale per l’accesso (per gli atti delle amministrazioni statali).Il ricorso deve essere notificato agli eventuali controinteressati e deve essere presentato nel termine di trenta giorni dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d'accesso. Nel termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione i controinteressati possono presentare le loro controdeduzioni. Editor: dott.ssa Elena Pullano
Continua a leggere
Scritto da:

Egregio Avvocato
Il regime di invalidità delle delibere condominiali
1 mar. 2023 • tempo di lettura 7 minuti
Il condominio degli edifici costituisce una species del più ampio genus della comunione ordinaria ex artt. 1100 e ss. c.c., la cui caratteristica fondamentale risiede nella coesistenza all'interno del medesimo fabbricato di parti comuni ed unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli condomini.Le parti comuni dello stabile condominiale sono individuate nel codice civile all'art. 1117, che ne offre infatti una elencazione tassativa, il cui criterio di identificazione risiede nella funzionalità delle stesse al miglior utilizzo e godimento delle porzioni di proprietà esclusiva.Come noto, la disciplina sulla comunione ordinaria è estendibile al condominio degli edifici, come ad altre figure speciali di comunione, laddove le relative norme risultino compatibili.E' ormai principio consolidato dalla stessa giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale il condominio altro non è che un ente di gestione privo di una personalità giuridica autonoma e distinta da quella dei singoli condomini e che agisce per il tramite dell'organo rappresentativo, individuato nella persona dell'amministratore pro-tempore, il cui compito precipuo è quello di dare attuazione alle delibere dell'organo assembleare, convocato e costituito secondo le maggioranze indicate all'art. 1136 c.c.Una delle problematiche sicuramente più diffuse in tema condominiale riguarda l'impugnabilità delle delibere adottate dall'assemblea, il cui regime si rinviene all'art. 1137 c.c.Tale norma, dopo aver sancito l'obbligatorietà delle deliberazioni adottate dall'assemblea per tutti i condomini (con ciò acquisendo il c.d. principio collegiale o maggioritario, per cui le decisioni della maggioranza prevalgono sulla minoranza dissenziente allo scopo di garantire il corretto funzionamento del condominio stesso), prevede che le deliberazioni contrarie alla legge od al regolamento condominiale possono essere impugnate da ogni condomino assente, dissenziente od astenuto chiedendo all'A.G. l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla data di deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della delibera medesima per gli assenti.L'espressa menzione contenuta nella norma in esame della fattispecie di annullamento delle delibere assembleari, oltre all'indicazione di un termine decadenziale breve per la relativa impugnativa ha posto il problema di un'eventuale impugnazione della delibera adottata dall'assemblea condominiale che sia affetta da un vizio tanto grave da decretarne la nullità. Dunque, la domanda che ci si pone è se tale termine di decadenza vale altresì per l'impugnazione di delibere di tal fatta ovvero, nel silenzio della legge, si possono applicare in via analogica le norme sulla nullità del contratto ex artt. 1418 e ss. c.c.E' opportuno ricordare che il regime di nullità del contratto, come scolpito dal codice civile, distingue le nullità testuali da quelle strutturali da quelle ancora virtuali, che possono colpire la vicenda negoziale nel suo insieme. La nullità importa l'improduttività di effetti giuridici del negozio medesimo ab origine e la sentenza che accerta la nullità del contratto avrà appunto effetti dichiarativi e non già costitutivi, come accade in ipotesi di annullamento. Una delle differenze più rilevanti che sussistono tra nullità ed annullamento consiste nella rilevabilità d’ufficio della prima, a differenza della seconda, nonché nella sottoponibilità dell’azione di annullamento a termine di prescrizione quinquennale ex art. 1442, c. 1 c.c. al contrario di quanto accade in tema di azione di nullità, che infatti il codice considera imprescrittibile.Le ipotesi di nullità del contratto sono ricondotte dal legislatore a casi espressamente previsti, come in ipotesi di nullità del patto successorio ex art. 458 c.c. ovvero di nullità del patto commissorio ex art. 2744 c.c., ovvero possono dipendere da difetti strutturali del contratto, come assenza di taluno degli elementi essenziali, illiceità della causa od impossibilità dell’oggetto. Infine, sempre secondo l’art. 1418, c. 1 c.c. si distinguono le cc.dd. nullità virtuali, per tali intendendosi quelle conseguenti alla contrarietà del negozio giuridico a norme imperative.Dalla lettura del dato testuale rinvenibile dal regime delle impugnazioni delle delibere assembleari, ai sensi del già richiamato art. 1137 c.c. l’azione di annullamento sarebbe confinata alle ipotesi di contrarietà delle delibere medesima alla legge ovvero al regolamento condominiale, unitamente al termine perentorio come sopra indicato, il cui dies a quo viene variamente individuato a seconda che il condomino istante sia assente, dissenziente od astenuto.La Cassazione con la sentenza S.U. n. 9839 del 2021 è intervenuta proprio in tema di nullità delle deliberazioni adottate dall’assemblea di condominio, dando risposta ad una serie di quesiti sorti proprio in relazione all’art. 1137 c.c.Secondo il Giudice nomofilattico, infatti, sono affette da nullità, deducibile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, le deliberazioni dell’assemblea condominiale che manchino ab origine degli elementi costitutivi essenziali, come a titolo esemplificativo quelle che hanno un oggetto impossibile in senso materiale o in senso giuridico, dando luogo in questo secondo caso ad un “difetto assoluto di attribuzioni”, e quelle che hanno un contenuto illecito, ossia contrario a norme imperative, o all’ordine pubblico, o al buon costume; al di fuori di tali ipotesi, le deliberazioni assembleari adottate in violazione di norme di legge o del regolamento condominiale sono semplicemente annullabili e l’azione di annullamento deve essere esercitata nei modi e nei termini di cui al più volte menzionato art. 1137 c.c.Alla luce di ciò, il principio di diritto ricavabile alla stregua della sentenza citata comprende proprio l’applicabilità della norma di cui all’art. 1418 c. 2 c.c., in ordine alle nullità cc.dd. strutturali del contratto, che assume un respiro ampio, di portata generale, tanto da trovare riscontro anche al di là della disciplina del negozio giuridico.Ma v’è di più. Le Sezioni Unite hanno altresì risposto ai quesiti sorti in ordine all’esperibilità dell’azione di annullamento unitamente all’opposizione a decreto ingiuntivo su contributi condominiali, aderendo all’orientamento giurisprudenziale più recente, che ammette la possibilità di un sindacato di invalidità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell’ingiunzione. In primo luogo, sono gli stessi principi generali di diritto ad affermare come l’opposizione a decreto ingiuntivo apra un ordinario giudizio ordinario di cognizione piena sulla domanda proposta dal creditore in sede monitoria. Pertanto, l’oggetto della cognizione del Giudice può estendersi anche all’accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione; per tale motivo, risulta arduo sostenere come il giudice possa confermare il decreto senza verificare la validità del titolo. In secondo luogo, non vanno dimenticate ragioni di economia processuale: negare al giudice dell’opposizione di sindacare l’invalidità della deliberazione assembleare, posta a fondamento del credito vantato dall’Ente di gestione, porterebbe ad una consistente moltiplicazione dei giudizi.Inoltre, sempre secondo la Corte di legittimità, l’art. 1137 c.c. deve essere interpretato in modo da escludere che l’annullamento di una delibera abbia effetto su alcuni condomini e non su altri, arrivando anche a formulare il seguente principio di diritto: «Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, l’eccezione con la quale l’opponente deduca l’annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell’ingiunzione, senza chiedere una pronuncia di annullamento della deliberazione, è inammissibile e tale inammissibilità va rilevata e dichiarata d’ufficio dal giudice.»Un’ulteriore questione ha interessato il regime di invalidità delle deliberazioni che applicano criteri di riparto delle spese condominiali diversi da quelli previsti dalla legge. Riprendendo un orientamento del 2005 le Sezioni Unite hanno considerato come meritasse conferma il principio che pone una distinzione tra deliberazioni che derogano i criteri legali e deliberazioni che applicano erroneamente criteri esistenti.Secondo la Corte, sono da considerare nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalle legge o dalla convenzione, da valere per il futuro; al contrario, sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate senza modificare i criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, ma in violazione degli stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell’esercizio delle dette attribuzioni assembleari.Questo, in concreto, il ragionamento della Corte: le delibere in materia di ripartizione delle spese condominiali sono da considerarsi nulle per “impossibilità giuridica” dell’oggetto nel caso in cui l’assemblea esuli dalle proprie attribuzioni e modifichi i criteri di riparto legali con valenza futura; sono invece semplicemente annullabili le deliberazioni adottate nel caso in cui i criteri vengano violati nel singolo caso e non con valenza futura.Si tratta dunque di una conclusione assolutamente coerente con le premesse iniziali del ragionamento appena elaborato, circa la portata applicativa della norma di cui all’art. 1418 c.c., elaborata in ordine alle diverse ipotesi di nullità del contratto, ma che evidentemente deve essere letta ed interpretata in modo assai più ampio, fino a riconoscerle la qualifica di norma di principio generale, che quindi trova utile riscontro anche al di fuori dei rigidi confini segnati dal Titolo II Libro IV c.c. in tema di contratti in generale.
Continua a leggere
Scritto da:
Quali sono gli effetti della pandemia sugli obblighi familiari di mantenimento?
18 feb. 2021 • tempo di lettura 6 minuti
L’Italia sta vivendo, sin dai primi mesi del 2020, una situazione di emergenza sanitaria che ha inciso -ed inciderà- su tutti i settori della vita sociale ed economica di ogni cittadino e lavoratore.Tra i soggetti maggiormente colpiti dalle misure adottate per contenere il contagio Covid – 19 ci sono sicuramente i genitori separati o divorziati che devono garantire il contributo mensile a favore dei figli e/o del coniuge previsto in sede di separazione, divorzio o affidamento della prole nata fuori del matrimonio.Quali sono gli obblighi familiari di mantenimento?Quali sono le ripercussioni della pandemia nei confronti del genitore che provvede al versamento dell’assegno di mantenimento?È possibile modificare gli obblighi assunti in sede di separazione o divorzio a causa di un’improvvisa contrazione reddituale?Per ottenere la modifica dei provvedimenti economici nei confronti del coniuge e/o figli quale procedura si deve seguire?1 – Quali sono gli obblighi familiari di mantenimento?Nel momento in cui cessa il legame matrimoniale, e quindi in caso di separazione o divorzio (consensuali o giudiziali), possono derivare degli obblighi di mantenimento a carico di uno dei coniugi in favore dell’altro e/o dei figli (minori o maggiorenni non autosufficienti). L’assegno di mantenimento in favore del coniuge a seguito della separazione è disciplinato dall’art. 156 c.c., e consiste in una prestazione pecuniaria periodica che non richiede, a differenza degli alimenti ex artt. 443 e seguenti c.c., la sussistenza di uno stato di bisogno economico del coniuge beneficiario.La ratio della disposizione è individuata nella tutela del coniuge più debole ed è espressione della solidarietà coniugale e ha, pertanto, funzione assistenziale: il coniuge obbligato al pagamento dell’assegno è colui che versa nelle condizioni economiche migliori, indipendentemente dalla circostanza che sia responsabile o meno della crisi del matrimonio. Accanto all’assegno in favore del coniuge, l’obbligo del mantenimento può essere posto anche in favore dei figli minori e maggiorenni non economicamente autosufficienti. Gli artt. 337 bis e seguenti c.c. dettano la disciplina in ordine ai provvedimenti riguardanti i figli, applicabile anche ai procedimenti di scioglimento, cessazione degli effetti civili o nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.Ai sensi degli artt. 315 bis e 316 bis c.c., i coniugi hanno l’obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni e, a tali fini, il giudice che pronuncia la separazione fissa la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento degli stessi. Ed ancora, ai sensi del IV comma dell’art. 337 ter c.c. nella determinazione dell’assegno di mantenimento, il Giudice deve tener conto dei parametri indicati dall’art. 337 ter comma IV c.c., ovvero: 1) le attuali esigenze del figlio; 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; 4) le risorse economiche di entrambi i genitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Tali parametri di legge servono a garantire che il minore non venga pregiudicato nella sua crescita e formazione a causa della crisi o rottura dell’unione tra i genitori.2 - Quali sono le ripercussioni della pandemia nei confronti del genitore che provvede al versamento dell’assegno di mantenimento?La profonda crisi, economica, sociale ed umanitaria determinata dal Covid-19, appare senza dubbio una situazione, da doversi inquadrare nell'ottica della straordinarietà e dell'imprevedibilità, che ha generato una pesante crisi economica mondiale che durerà ben oltre la risoluzione della pandemia. Infatti, la chiusura forzata di tutte quelle attività definite “non essenziali” ha generato ingenti ripercussioni anche nei confronti dei genitori separati o divorziati, i quali, stanno riscontrano difficoltà nel garantire la corresponsione dell’importo previsto in sede di separazione o divorzio o di affidamento della prole nata fuori del matrimonio, quale contributo mensile a favore dei figli e/o del coniuge.A seguito dei numerosi Dpcm, le attività definite “non essenziali”, come bar, ristoranti, pizzerie, palestre, discoteche, ecc., sono state chiuse dal 9 marzo al 18 maggio con ovvie conseguenze pregiudizievoli sul piano finanziario e reddituale. Successivamente, il ministro della salute Speranza, ha attuato nuove disposizioni restrittive prevedendo la suddivisione delle regioni in base a tre colori: zona rossa, arancione e gialla. Tale suddivisione ha generato ulteriori difficoltà economiche e in mancanza di uno specifico intervento da parte del Governo o del Legislatore sul punto, il soggetto obbligato è tenuto a far fronte all’obbligo di mantenimento anche in caso di estrema difficoltà. Non è quindi consentito di interrompere o ridurre la corresponsione dell’assegno di mantenimento in via autonoma. Ricordiamo che il mancato versamento dell’assegno di mantenimento determina conseguenze sia dal punto di vista civile, sia sotto il profilo penale.Nell’attuale scenario, privo di una normativa che possa regolamentare questa situazione di emergenza e di eccezionalità, è di fondamentale importanza il richiamo al buon senso comune delle parti familiari, evitando strumentalizzazioni della pandemia sia da parte dell’obbligato sia da parte del beneficiario. 3 - È possibile modificare gli obblighi assunti in sede di separazione o divorzio a causa di un’improvvisa contrazione reddituale?Tutti i provvedimenti relativi ai rapporti tra gli ex coniugi e nei confronti dei figli possono essere modificati qualora mutino le condizioni che li hanno determinati.Le statuizioni in tema di diritto matrimoniale hanno valore rebus sic stantibus in quanto la decisione del tribunale e gli accordi omologati dai coniugi, trovano il proprio fondamento nei presupposti di fatto che hanno dato luogo alle relative decisioni. Questo implica che, al mutamento dei presupposti che avevano fondato le decisioni pregresse, è possibile la modifica dei provvedimenti stessi. Possono, quindi, essere modificati sia i provvedimenti che riguardano i rapporti tra i coniugi sia i provvedimenti che riguardano la prole.La pandemia, infatti, è un fatto sopravvenuto ed oggettivo indipendente dalla volontà delle parti coinvolte, che sicuramente rientra tra i “fatti nuovi” rispetto all’epoca in cui il provvedimento è stato emanato, e come tale configura “giustificato motivo”, che legittima la revisione dell’assegno di mantenimento.Sarà necessario accertare in concreto se la crisi dovuta dalla pandemia abbia comportato (e comporterà) una ridotta capacità di produrre reddito, tale da creare uno squilibrio tra le parti rispetto alle condizioni precedenti, rilevando in tal senso il tipo di lavoro dipendente o autonomo svolto dal soggetto.In ogni caso, nell’accertamento della situazione economica, occorrerà tenere conto del quadro complessivo della situazione economica e, quindi, non solo dei redditi e dei ricavi, ma anche dell’intero ammontare del patrimonio a disposizione.4 - Per ottenere la modifica dei provvedimenti della separazione o del divorzio quale procedura si deve seguire?Per ottenere la revisione dell’assegno di mantenimento sarà necessario provare il peggioramento delle condizioni economiche, attraverso il raffronto con quelle del periodo precedente l’epidemia, e che la riduzione attuale, e proiettata nel futuro, incide in maniera rilevante sull’assetto economico e patrimoniale esistente al momento della separazione o del divorzio. La revisione potrà essere ottenuta depositando ricorso giudiziale o congiunto di modifica delle condizioni di separazione ex art. 710 c.p.c. o di divorzio ex art. 9 l. 898/70, mentre nel caso di genitori non coniugati sarà possibile chiedere la revisione del provvedimento riguardante la prole, ai sensi dell’art. 337 quinquies c.c., giudizialmente o congiuntamente.Nel caso di giudizi ancora pendenti, si potrà depositare al giudice istruttore istanza per la modifica del provvedimento in vigore ai sensi dell’art. 709 comma IV c.p.c.Editor: avv. Elisa Calviello
Continua a leggere
Scritto da:

Egregio Avvocato
Commenti
Non ci sono commenti




