Risolvere o rescindere un contratto: quali sono le differenze?

Egregio Avvocato
Pubblicato il 14 nov. 2021 · tempo di lettura 1 minuti
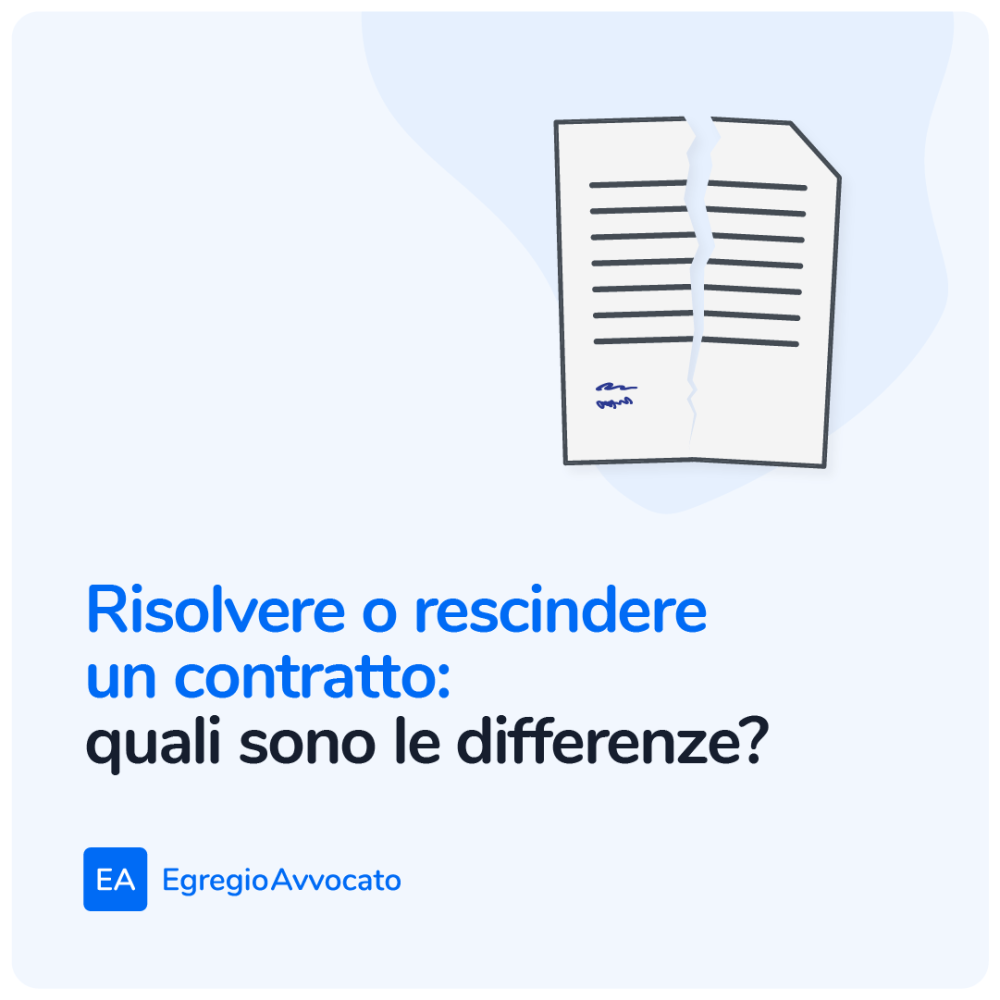
Nonostante siano comunemente usati come sinonimi, i due termini hanno significati ben diversi:
“Risolvere” il contratto significa scioglierlo, farlo venire meno se si verificano eventi che ne impediscono la prosecuzione: perché una delle parti non adempie, perché è impossibile eseguire la prestazione o questa è divenuta eccessivamente onerosa, per volontà delle parti stesse o in altri casi specifici previsti dalla legge.
Il contratto invece si “rescinde” in casi del tutto eccezionali e anomali, cioè quando il contratto è concluso in stato di pericolo ed a condizioni inique oppure quando una parte versava in condizione di bisogno e vi sia una notevole sproporzione tra i valori delle prestazioni pattuite (una vale più del doppio dell’altra).
Condividi:
Risolvere o rescindere un contratto: quali sono le differenze?
Pubblicato da:

Egregio Avvocato
Articoli che potrebbero interessarti
Mio padre mi ha diseredato: può farlo? - La diseredazione.
29 gen. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
La diseredazione è la disposizione mediante la quale il testatore esclude dalla successione un proprio successibile ex lege.Oggi la diseredazione nell’ordinamento giuridico italiano è ammessa, anche nel caso in cui sia l’unica disposizione contenuta nel testamento. L’autonomia testamentaria, infatti, è espressione dell’autonomia dei privati ed è particolarmente ampia.Tuttavia, il problema si pone nel caso in cui si voglia diseredare un cd. legittimario, ovvero, un soggetto che ha sempre diritto ad una quota del patrimonio (cd. quota di legittima), che viene individuato dalla legge nel coniuge, nei figli, e negli ascendenti nel caso in cui non vi siano figli. La tesi che prevale in giurisprudenza è quella che considera inammissibile la diseredazione del legittimario, che si porrebbe in contrasto con l’art. 549 c.c., il quale prevede la nullità di pesi e condizioni poste sulla quota di legittima; e con l’art. 457 c.c., che prevede che le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti dei legittimari. Alla luce di questa interpretazione, se si viene diseredati dal proprio padre non solo si avrà la possibilità di agire con l’azione di riduzione a tutela della propria quota di legittima, ma anche di far valere la invalidità della stessa disposizione testamentaria.Si evidenzia, tuttavia, che nel 2012 è stato inserito un nuovo articolo, il 448 bis c.c., il quale prevede espressamente la possibilità per il figlio di diseredare il proprio padre, e, quindi, contempla la possibilità di diseredare un legittimario. Secondo una prima tesi l’art. 448 bis è norma eccezionale, come tale non estendibile analogicamente, a conferma che di regola non è mai possibile diseredare un legittimario; secondo una diversa tesi, invece, è sempre possibile una diseredazione del legittimario, e la norma è si eccezionale, ma per il solo fatto che il legittimario non potrebbe neanche esperire l’azione di riduzione in questi casi.
Continua a leggere
Scritto da:

Egregio Avvocato
La donazione obnuziale
28 apr. 2022 • tempo di lettura 3 minuti
In vista di un determinato matrimonio futuro, gli sposi tra loro o anche altri soggetti possono fare un tipo particolare di donazione detta obnuziale. La donazione obnuziale è un negozio formale e tipico, caratterizzato dall’espressa menzione nell’atto pubblico che la contiene, dove l’attribuzione patrimoniale, eseguita da uno dei futuri sposi o da un terzo, sia compiuta in riguardo di un futuro e determinato matrimonio.Pertanto, per aversi donazione obnuziale è necessario che si faccia riferimento a un determinato matrimonio, cosicché è da escludere l’attribuzione patrimoniale effettuata nella prospettiva generica e accidentale del matrimonio.L’istituto della donazione obnuziale è incompatibile con l’istituto della donazione indiretta, in cui lo spirito di liberalità viene perseguito attraverso il compimento di atti diversi da quelli previsti per la donazione. 1. Chi può essere il donatario e come si perfeziona la donazione?2. Quali sono gli effetti della donazione obnuziale in caso di separazione o divorzio?3. Quali sono gli effetti della donazione obnuziale in caso di nullità del matrimonio?1 – Chi può essere il donatario e come si perfeziona la donazione?In tale tipo di donazione il donatario può essere alternativamente: a) uno o entrambi gli sposi (ad esempio un genitore dona al figlio, o al figlio e alla futura moglie); b) i figli nascituri da questi (un genitore dona al nascituro della figlia e del futuro genero).Diversamente da quanto avviene nella donazione tipica, in tale ipotesi la donazione: a) si perfeziona senza bisogno di accettazione a seguito della celebrazione del matrimonio a condizione che nell’atto pubblico sia espressamente indicato che la donazione è motivata dal matrimonio stesso; b) non produce effetti fino alla celebrazione del matrimonio (e, quindi, sottoposta alla condizione sospensiva della celebrazione dello stesso); c) non può essere revocata dal donante né per ingratitudine del donatario né in caso di sopravvenienza di figli; d) non obbliga il donatario a prestare gli alimenti al donante. 2 - Quali sono gli effetti della donazione obnuziale in caso di separazione o divorzio?A seguito della separazione dei coniugi o di divorzio il bene donato diventa di proprietà esclusiva del donatario della liberalità così come risulta dall’atto pubblico.Quando dall’atto non è possibile individuare il donatario, è necessario accertare se l’attribuzione è stata posta a favore di entrambi i coniugi o di uno solo, considerando che nella maggior parte dei casi la donazione per futuro matrimonio è destinata alla nascente famiglia e non a un donatario determinato. La donazione per futuro matrimonio risolutivamente condizionata alla pronuncia di separazione o divorzio è lecita: il donante può prevedere nel contratto di donazione che gli effetti della liberalità cessino al verificarsi di un evento futuro e incerto come lo scioglimento del matrimonio.3 - Quali sono gli effetti della donazione obnuziale in caso di nullità del matrimonio?Se il matrimonio è dichiarato nullo anche la donazione obnuziale diventa nulla. Il donatario deve restituire il bene al donante, ma restano salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede tra il giorno del matrimonio e il passaggio in giudicato della sentenza che ne dichiara la nullità.Il coniuge in buona fede non è tenuto a restituire i frutti percepiti prima della domanda di annullamento del matrimonio.Se la donazione era a favore di figli nascituri, essa rimane efficace per i figli rispetto ai quali si verificano gli effetti del matrimonio putativo (ossia del matrimonio contratto in buona fede dai coniugi che ignoravano la causa di nullità).
Continua a leggere
Scritto da:
Affidamento dei figli minori e trasferimento all'estero
27 apr. 2023 • tempo di lettura 1 minuti
Uno dei temi più dibattuti da noi avvocati matrimonialisti/divorzisti è, ovviamente, l'affido dei figli minori in seno ad un giudizio di separazione. Dando per scontato che, nella maggior parte dei casi, i Tribunali optano per l'affido condiviso, quid iuris quando uno dei genitori - per i più svariati motivi - decide di spostare la propria residenza all'estero? Il tema è stato di recente analizzato dalla Suprema Corte nella decisione in commento. (Corte di Cassazione - Ordinanza n. 24651/2022, Sez. Prima Civile) L'orientamento qui espresso pare assolutamente condivisibile. Ed invero, il consenso di un genitore al collocamento dei figli presso l'ex coniuge (id est, spesso la madre) non presuppone sic et simpliciter un'implicita autorizzazione al trasferimento all'estero, in quanto tale passo - seppur costituzionalmente garantito, stante la libertà di decidere dove vivere - comporta notevoli limitazioni alla bigenitorialità e all'esercizio di quel diritto/dovere ad essa intrinsecamente connesso. Ne discende che qualsiasi decisione unilaterale di trasferimento all'estero con figli minori è da ritenersi lesivo dei diritti dell'altro genitore, che si vede de facto limitato nell'esercizio delle prerogative genitoriali, e, pertanto, costituisce illecito di sottrazione internazionale di minori, tema che è regolamentato persino a livello internazionale dalla Convenzione internazionale de L'Aia. La decisione degli Ermellini appare impeccabile sotto un profilo logico ed interpretativo e rappresenta sicuramente un piunto fermo nella soluzione di simili controversie.Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo Matrimonialista - Divorzista - Curatore Speciale del Minore
Continua a leggere
Scritto da:
Nuove regole per le adozioni internazionali
20 dic. 2025 • tempo di lettura 6 minuti
La tutela dei minori parte dal presupposto che tali soggetti sono proprio i più deboli e, pertanto, i loro diritti - pur sulla carta indiscutibilmente riconosciuti a livello nazionale e internazionale - vengono spesso messi in secondo piano nelle vicende patologiche del rapporto coniugale.Oggi vogliamo dedicare particolare attenzione all'adozione internazionale, intesa come lo strumento volto a dare una nuova famiglia al minore a cui manchi in via definitiva il sostegno da parte della famiglia di origine e che, pertanto, si trovi in stato di abbandono. La Legge n° 184/1983 regola sia l'adozione nazionale che quella di minori stranieri e residenti all'estero. La predetta normativa stabilisce, in particolare, i requisiti minimi che una famiglia deve soddisfare per poter adottare, come l’età minima, la stabilità finanziaria e la stabilità della coppia, l’idoneità psicologica e l’idoneità fisica, al fine di garantire un ambiente sicuro e amorevole per il bambino. Inoltre, la legge 184/83 regola anche l’iter stesso, che determina tempi e modalità di valutazione dell’idoneità dei potenziali adottanti, la partecipazione degli organi competenti al processo di adozione, le visite domiciliari, le valutazioni psicologiche e sociali e le necessarie, indica i documenti e i certificati necessari. Tale struttura è stata di recente parzialmente modificata con interventi del legislatore e della stessa Corte Costituzionale. ma vediamo, in primis, l'originaria statuizione come formulata nella legge 184/83 (come modificata dalla legge 149/2001). I requisiti per l'adozione internazionale sono gli stessi previsti per l'adozione nazionale, e sono previsti dall'art. 6 della su richiamata legge: L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o per un numero inferiore di anni se i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, e ciò sia accertato dal tribunale per i minorenni.Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando, con la possibilità di deroga in caso di danno grave per il minore. Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni. I predetti limiti di età possono essere derogati nell’interesse del minore o dei minori nell’ipotesi di adozione di più fratelli. Tutte le coppie che intendono iniziare un percorso di adozione internazionale devono presentare la dichiarazione di disponibilità al Tribunale dei Minori del circondario in cui risiedono e successivamente richiedere che lo stesso dichiari la loro idoneità all’adozione. Successivamente, i servizi sociali di competenza eseguono una serie di accertamenti sulla cui base il Tribunale pronuncerà un Decreto che attesta l’idoneità o l’inidoneità. Il Tribunale, dopo aver ricevuto la valutazione del servizio sociale, provvederà ad emettere il decreto di idoneità o meno all’adozione internazionale. Entro un anno dalla pronuncia del decreto di idoneità i richiedenti devono rivolgersi ad un ente autorizzato dalla commissione per le adozioni internazionali il quale metterà in contatto gli adottanti con il minore straniero.La Commissione, in particolare, provvede a comunicare l’emissione dell’autorizzazione all’ingresso in Italia agli uffici consolari del luogo. Sono tali Uffici Consolari a rilasciare materialmente il visto d’ingresso per adozione. Il Tribunale per i Minorenni, in seguito, dichiara efficace in Italia il provvedimento di adozione pronunciato all'estero e ne ordina la trascrizione nei registri dello stato civile. Invece, nel caso in cui il provvedimento straniero, anziché disporre direttamente l’adozione, disponga l'affidamento a scopo di adozione, sarà necessario che il Tribunale per i Minorenni dichiari efficace l’affidamento a scopo adottivo in Italia. In tale ultima ipotesi, l’adozione si perfezionerà in Italia all’esito positivo del periodo di affidamento preadottivo e sarà il Tribunale per i Minorenni a decidere con Decreto l’adozione, provvedendo ad ordinarne la trascrizione nei registri dello stato civile.Le su accennate novità in materia di adozione riguardano, in particolare, il Decreto legislativo n. 149 del 2018 che ha stabilito diverse misure per ridurre i tempi di attesa e semplificare le pratiche amministrative legate all’adozione internazionale. L’obiettivo primario di tale intervento è quello di semplificare e accelerare i processi di adozione internazionale, garantendo al contempo la tutela dei diritti dei minori e dei potenziali genitori adottivi. Di seguito riassumiamo le novità più salienti: Il decreto si è occupato della riduzione dei tempi di attesa, stabilendo il principio per cui il processo di adozione internazionale debba essere condotto nel minor tempo possibile, garantendo i diritti dell’adolescente o del minore interessato e rispettando le normative internazionali. Inoltre, ha introdotto una serie di misure per semplificare le procedure burocratiche legate all’adozione internazionale, riducendo gli adempimenti e i documenti richiesti.È stata istituita una procedura unica per l’acquisizione dei documenti necessari per l’adozione, che consente di evitare duplicazioni e ridondanze.La nuova normativa ha poi previsto l’obbligo per le autorità competenti di tenere traccia del processo di adozione internazionale, garantendo una maggiore trasparenza e informazione ai genitori adottivi e ai minori interessati e ha disposto la promozione di programmi di formazione e sostegno per i genitori adottivi, al fine di fornire loro strumenti e competenze necessari per affrontare le sfide legate all’adozione internazionale.Il decreto promuove la cooperazione e la collaborazione tra le autorità competenti dei diversi paesi coinvolti nel processo di adozione internazionale, al fine di garantire una maggiore efficienza e tutela dei diritti dei minori.Forse, la novità più significativa è l'istituzione del cosiddetto "Registro delle adozioni internazionali", cioè una banca dati nazionale che raccoglie tutte le informazioni sulle adozioni internazionali in Italia e permette di controllare e gestire l’intero processo, garantendo maggiore trasparenza e sicurezza ai minori adottati.Degna di nota è, poi, l’introduzione del “periodo di pre-affido”. Questo periodo, di durata fino a sei mesi, offre agli adottanti l’opportunità di conoscere il bambino e costruire un rapporto con lui prima di ufficializzare l’adozione. Durante questo periodo i genitori adottivi sono accompagnati da un assistente sociale che li sostiene e li aiuta a superare le prime difficoltà legate all’accoglienza di un minore. Inoltre, è stato introdotto il “consulente tecnico”, cioè uno specialista il cui compito è valutare la compatibilità dell’adottante e del bambino da adottare. Questo consulente svolge un ruolo chiave nel garantire che l’adozione sia nel migliore interesse del bambino e valuta la capacità dei genitori adottivi di accettare e prendersi cura del bambino.Per quanto riguarda, poi, gli interventi giurisprudenziali, da segnalare è la sentenza n. 33 del 2025 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato incostituzionale l’art. 29 bis della Legge 184/1983, nella parte in cui escludeva dalla possibilità di adottare i single e le coppie non sposate.Tale decisione rappresenta una rivoluzione nel diritto di famiglia italiano, ponendo al centro il superiore interesse del minore rispetto allo stato civile degli adottanti, altresì offrendo ai minori maggiori opportunità di trovare una famiglia e garantendo la possibilità di adozione anche a chi, fino ad oggi, era escluso dal percorso adottivo.In conclusione, ad oggi abbiamo un sistema di adozioni internazionale sicuramente più rapido ed efficace, che avvicina l'Italia agli standard degli altri partner europei e che, pertanto, deve essere positivamente valutato.
Continua a leggere
Scritto da:
Commenti
Non ci sono commenti




