REVISIONE DEL PROCESSO PENALE (ERRORI GIUDIZIARI)

Avv. Prof. Dott. Criminologo Forense Giovanni Moscagiuro
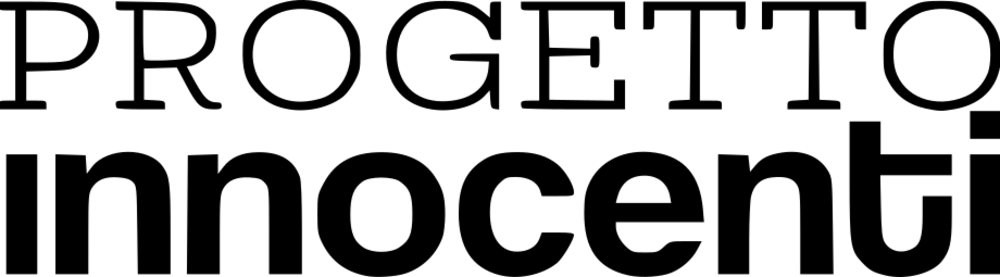
La revisione, nel processo penale italiano, è un mezzo di impugnazione straordinario esperibile avverso ai provvedimenti di condanna passati in giudicato.
la revisione è prevista dall'art.629 e seguenti:
«1. È ammessa in ogni tempo a favore dei condannati, nei casi determinati dalla legge, la revisione delle sentenze di condanna o delle sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444, comma 2, o dei decreti penali di condanna, divenuti irrevocabili, anche se la pena è già stata eseguita o è estinta.»
(Art. 629 - Condanne soggette a revisione.)
Tra le motivazioni che possono portare ad una revisione vi sono i motivi elencati dall'art.630, L'organo competente è la Corte d'Appello.
Che si voglia considerare la revisione un'impugnazione o meno, è di fatto uno strumento offerto dall'ordinamento al condannato per poter far fronte a sentenze ingiuste passate in giudicato. L'unico che può proporre una domanda di revisione è il condannato o chi agisce nel suo interesse, come i congiunti o il Procuratore Generale. L'unica domanda che si può chiedere è il proscioglimento, non anche diminuzioni di pena o sconti, giacché questo istituto mira essenzialmente a correggere decisioni vistosamente errate.
Organo competente per la revisione è la Corte d'Appello, ex art.633 c.p.p. se considerata impugnazione, non è né devolutiva in quanto non rimette il giudizio dinanzi ad un organo superiore, bensì ad uno ben individuato, la Corte d'Appello a prescindere, né tantomeno sospensiva, in quanto il giudicante non è tenuto a disporre la sospensione dell'esecuzione della pena, potendolo fare a propria discrezione in qualsiasi momento se ritiene opportuno.
La revisione può essere richiesta soltanto per motivi tassativamente previsti dalla legge e in virtù di elementi concreti ed evidenti che abbiano la capacità di far prosciogliere chi ne fa richiesta.
Questo aspetto distacca nettamente la revisione dalla possibilità che la si possa considerare una sorta di bis in idem , vietato dallo stesso ordinamento: in realtà il bis in idem è vietato per evitare la reiterata persecuzione penale di un soggetto già giudicato, specialmente se assolto.
In questo caso la situazione è completamente ribaltata in quanto è lo stesso soggetto a chiedere - non un nuovo giudizio (sarebbe impossibile) o tantomeno una reiterata persecuzione, ma - lo stravolgimento della sentenza di condanna compromessa da un errore nei precedenti giudizi.
A dire il vero un peggioramento è previsto, ma per una causa del tutto eccezionale: quando cioè, ai sensi della legge 15 marzo 1991 n.82, un soggetto abbia ottenuto attenuanti o agevolazioni per collaborazioni con la Giustizia per questioni di terrorismo o criminalità organizzata, mentendo o rendendo dichiarazioni reticenti, nonché quando sia stato ritenuto autore di un reato entro i 10 anni successivi per i quali è previsto l'arresto in flagranza obbligatorio.
Motivi
I motivi per richiedere la revisione sono elencati dall'art.630 c.p.p.:
«1. La revisione può essere richiesta:
a) se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario o di un giudice speciale;
b) se la sentenza o il decreto penale di condanna hanno ritenuto la sussistenza del reato a carico del condannato in conseguenza di una sentenza del giudice civile o amministrativo, successivamente revocata, che abbia deciso una delle questioni pregiudiziali previste dall'articolo 3 ovvero una delle questioni previste dall'articolo 479;
c) se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell'articolo 631;
d) se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come reato.»
Diversi sono stati in questi ultimi anni i casi di gravissimi Errori Giudiziari, non da ultimo il caso di Beniamino Zuncheddu, difeso dall'avv. Mauro Trogu, che prima di essere dichiarato innocente ha trascorso ben 33 anni in carcere.
Il caso piu' grave resta quello di Gulotta, trattato e difeso dall'Avv. Baldassarre Lauria, il quale detiene, purtroppo, il record di detenzione, ben 36 anni in carcere per un delitto che non ha mai commesso.
Il caso Gulotta, fu trattato anche nella trasmissione "IO SONO INNOCENTE" di Matano nel 2017, assieme ad altri casi di gravi Errori Giudiziari.
Gulotta, assieme all'avv. Baldassarre Lauria, fondarono "PROGETTO INNOCENTI", che tratta gli errori giudiziari e di conseguenza le revisioni penali.
E', difatti, una nobile organizzazione non governativa per la correzione degli errori giudiziari, cui fanno parte notevoli e preparatissimi professionisti, esperti in materia.
DI SEGUITO VENGONO RIPORTATI I RELATIVI ARTICOLI DEL C.P.P. CIRCA LA REVISONE DEL PROCESSO PENALE:
Articolo 629 –Condanne soggette a revisione.
1. È ammessa in ogni tempo a favore dei condannati, nei casi determinati dalla legge, la revisione delle sentenze di condanna o delle sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444, comma 2, o dei decreti penali di condanna, divenuti irrevocabili, anche se la pena è già stata eseguita o è estinta.
Articolo 630 - Casi di revisione.
1. La revisione può essere richiesta:
a) se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario o di un giudice speciale;
b) se la sentenza o il decreto penale di condanna hanno ritenuto la sussistenza del reato a carico del condannato in conseguenza di una sentenza del giudice civile o amministrativo, successivamente revocata, che abbia deciso una delle questioni pregiudiziali previste dall'articolo 3 ovvero una delle questioni previste dall'articolo 479;
c) se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell'articolo 631;
d) se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come reato.
Articolo 631 -Limiti della revisione.
1. Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena d'inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli articoli 529, 530 o 531.
Articolo 632 -Soggetti legittimati alla richiesta.
1. Possono chiedere la revisione:
a) il condannato o un suo prossimo congiunto ovvero la persona che ha sul condannato l'autorità tutoria e, se il condannato è morto, l'erede o un prossimo congiunto;
b) il procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto fu pronunciata la sentenza di condanna. Le persone indicate nella lettera a) possono unire la propria richiesta a quella del procuratore generale.
Articolo 633 -Forma della richiesta.
1. La richiesta di revisione è proposta personalmente o per mezzo di un procuratore speciale. Essa deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano e deve essere presentata, unitamente a eventuali atti e documenti, nella cancelleria della corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11.
2. Nei casi previsti dall'articolo 630, comma 1, lettere a) e b), alla richiesta devono essere unite le copie autentiche delle sentenze o dei decreti penali di condanna ivi indicati.
3. Nel caso previsto dall'articolo 630, comma 1, lettera d), alla richiesta deve essere unita copia autentica della sentenza irrevocabile di condanna per il reato ivi indicato.
Articolo 634 -Declaratoria d'inammissibilità.
1. Quando la richiesta è proposta fuori delle ipotesi previste dagli articoli 629 e 630 o senza l'osservanza delle disposizioni previste dagli articoli 631, 632, 633, 641 ovvero risulta manifestamente infondata, la corte di appello anche di ufficio dichiara con ordinanza l'inammissibilità e può condannare il privato che ha proposto la richiesta al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da 258 euro a 2.065 euro.
2. L'ordinanza è notificata al condannato e a colui che ha proposto la richiesta, i quali possono ricorrere per cassazione. In caso di accoglimento del ricorso, la corte di cassazione rinvia il giudizio di revisione ad altra corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11.
Articolo 635 -Sospensione dell'esecuzione.
1. La corte di appello può in qualunque momento disporre, con ordinanza, la sospensione dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, applicando, se del caso, una delle misure coercitive previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284. In ogni caso di inosservanza della misura, la corte di appello revoca l'ordinanza e dispone che riprenda l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza.
2. Contro l'ordinanza che decide sulla sospensione dell'esecuzione, sull'applicazione delle misure coercitive e sulla revoca, possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero e il condannato.
Articolo 636 -Giudizio di revisione.
1. Il presidente della corte di appello emette il decreto di citazione a norma dell'articolo 601.
2. Si osservano le disposizioni del titolo I e del titolo II del libro VII in quanto siano applicabili e nei limiti delle ragioni indicate nella richiesta di revisione.
Articolo 637 -Sentenza.
1. La sentenza è deliberata secondo le disposizioni degli articoli 525, 526, 527 e 528.
2. In caso di accoglimento della richiesta di revisione, il giudice revoca la sentenza di condanna o il decreto penale di condanna e pronuncia il proscioglimento indicandone la causa nel dispositivo.
3. Il giudice non può pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio.
4. In caso di rigetto della richiesta, il giudice condanna la parte privata che l'ha proposta al pagamento delle spese processuali e, se è stata disposta la sospensione, dispone che riprenda l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza.
Articolo 638 -Revisione a favore del condannato defunto.
1. In caso di morte del condannato dopo la presentazione della richiesta di revisione, il presidente della corte di appello nomina un curatore, il quale esercita i diritti che nel processo di revisione sarebbero spettati al condannato.
Articolo 639 -Provvedimenti in accoglimento della richiesta.
1. La corte di appello, quando pronuncia sentenza di proscioglimento a seguito di accoglimento della richiesta di revisione, anche nel caso previsto dall'articolo 638, ordina la restituzione delle somme pagate in esecuzione della condanna per le pene pecuniarie, per le misure di sicurezza patrimoniali, per le spese processuali e di mantenimento in carcere e per il risarcimento dei danni a favore della parte civile citata per il giudizio di revisione. Ordina altresì la restituzione delle cose che sono state confiscate, a eccezione di quelle previste nell'articolo 240, comma 2, n. 2, del codice penale.
Articolo 640 -Impugnabilità della sentenza.
1. La sentenza pronunciata nel giudizio di revisione è soggetta al ricorso per cassazione.
Articolo 641 -Effetti dell'inammissibilità o del rigetto.
1. L'ordinanza che dichiara inammissibile la richiesta o la sentenza che la rigetta non pregiudica il diritto di presentare una nuova richiesta fondata su elementi diversi.
Articolo 642 -Pubblicazione della sentenza di accoglimento della richiesta.
1. La sentenza di accoglimento, a richiesta dell'interessato, è affissa per estratto, a cura della cancelleria, nel comune in cui la sentenza di condanna era stata pronunciata e in quello dell'ultima residenza del condannato. L'ufficiale giudiziario deposita in cancelleria il certificato delle eseguite affissioni.
2. Su richiesta dell'interessato, il presidente della corte di appello dispone con ordinanza che l'estratto della sentenza sia pubblicato a cura della cancelleria in un giornale, indicato nella richiesta; le spese della pubblicazione sono a carico della cassa delle ammende.
Prof. Dr. Giovanni Moscagiuro
Studio delle Professioni e Scienze forensi e Criminologia dell'Intelligence ed Investigativa
Editori e Giornalisti europei in ambito investigativo
Esperto e docente in Diritto Penale , procedura penale, Amministrativo , Tributario , Civile Pubblica Amministrazione , Esperto in Cybercrime , Social Cyber Security , Stalking e Gang Stalking, Cyberstalking, Bullismo e Cyberbullismo, Cybercrime, Social Crime, Donne vittime di violenza, Criminologia Forense, dell'Intelligence e dell'Investigazione, Diritto Militare, Docente di Diritto Penale e Scienze Forensi, Patrocinatore Stragiudiziale, Mediatore delle liti, Giudice delle Conciliazioni iscritto all'albo del Ministero di Grazia e Giustizia, Editori e Giornalisti European news Agency
Condividi:
REVISIONE DEL PROCESSO PENALE (ERRORI GIUDIZIARI)
Pubblicato da:
Articoli che potrebbero interessarti
La recidiva
3 mag. 2021 • tempo di lettura 7 minuti
Un istituto che trova ampia applicazione nell’ordinamento italiano e che pone conseguenti problemi applicativi è quello della recidiva. L’art. 99 del codice penale prevede la disciplina di tale istituto, sul quale – anche di recente – si è espressa più volte la Corte di Cassazione a Sezioni Unite. Vediamo insieme gli aspetti più importanti.Campo di applicazione e natura giuridica della recidivaI diversi tipi di recidivaI cd. effetti secondari della recidiva1 - Campo di applicazione e natura giuridica della recidivaL’art. 99 c.p. dispone che chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo. Da ciò si desume che al fine di poter applicare la recidiva devono sussistere almeno due presupposti:a. il soggetto deve avere commesso un delitto non colposo, per il quale sia stato già condannato con sentenza passata in giudicato; e questo delitto si chiamerà reato fondante;b. dopo il passaggio in giudicato della prima condanna, il soggetto deve aver commesso un nuovo delitto non colposo, che si chiamerà reato espressivo. È a questo secondo reato che verrà applicata la recidiva. Tuttavia, è ormai pacifico in giurisprudenza che non sono sufficienti questi due soli presupposti, e che mai vi potrà essere un automatismo nell’applicazione della recidiva – non può essere conseguenza automatica della mera sussistenza di questi due presupposti. Il giudice, invero, dovrà sempre condurre una valutazione in concreto sul fatto di applicare o meno la recidiva, tale per cui si ritiene che debba sussistere un terzo presupposto:c. il reato espressivo deve palesare una maggiore consapevolezza e una maggiore pericolosità sociale dell’autore del reato.Se non vi è questa valutazione, o se comunque il reato espressivo non ha nulla a che vedere con il reato fondante, allora il giudice non potrà applicare la recidiva: in quanto la ricaduta non è sintomatica di una maggiore colpevolezza e non denota il soggetto autore del reato come maggiormente pericoloso.In merito alla natura giuridica della recidiva, si evidenzia che ad oggi è stata del tutto superata la tesi tradizionale secondo cui veniva classificata quale status. Tale tesi poneva l’accento sul fatto che la legge sembrava riferirsi sempre al recidivo quale soggetto, parlando sempre del “recidivo”.Oggi la tesi prevalente ritiene che si tratti di una circostanza aggravante del reato, e ciò si desume non solo dall’art. 99 c.p., ma anche da altre disposizioni come l’art. 69 c.p., che disciplina il bilanciamento tra circostanze, e l’art. 70 c.p., che distingue tra circostanze oggettive e soggettive, ed entrambe le disposizioni citano la recidiva.Da tale classificazione come circostanza aggravante derivano importanti conseguenze, tra le più importanti vi è quella per la quale anche la recidiva deve soggiacere alle normali regole in materia di concorso di circostanze (artt. 63 e ss. c.p.), come sottolineato anche dalle pronunce della Corte di Cassazione a Sezioni Unite. Una prima sentenza del 2011 ha evidenziato che l’art. 63 co. 4 c.p. sul concorso tra circostanze ad effetto speciale si applica anche alla recidiva; e una seconda sentenza del 2021 ha ribadito che la recidiva è una circostanza, ed è circostanza ad effetto speciale (tranne che nel comma 1), quindi deve trovare applicazione anche la disciplina ex art. 649 bis c.p. sul regime di procedibilità d’ufficio.2 - I diversi tipi di recidivaL’art. 99 c.p. prevede diversi tipi di recidiva.Il primo comma prevede la recidiva semplice, che sussiste nel momento in cui un soggetto commette un qualsiasi delitto non colposo dopo essere stato giudicato con sentenza passata in giudicato per un precedente delitto non colposo. In questo caso è previsto l’aumento di un terzo della pena.Il secondo comma prevede la recidiva monoaggravata, che ricorre o quando il reato espressivo (quindi il secondo delitto) è della stessa indole del primo; o è stato commesso entro 5 anni dalla precedente condanna; o, ancora, è stato commesso nel corso dell’esecuzione della pena. A fronte di tale circostanza aggravante il legislatore prevede un aumento della pena fino alla metà.Il terzo comma disciplina la recidiva pluriaggravata, la quale prevede che ricorrano due o più circostanze del secondo comma; quindi ad es. il reato espressivo sia contemporaneamente della stessa indole del primo e sia stato commesso nei cinque anni dalla precedente condanna. L’aumento di pena in questo caso è della metà.Il quarto comma prevede la recidiva reiterata, che sussiste nel momento in cui un soggetto già dichiarato recidivo commetta un altro delitto non colposo. In questo caso l’aumento di pena è della metà nel caso di cui al primo comma, e di due terzi negli altri casi.Infine, il comma 5 prevedeva originariamente una forma di recidiva obbligatoria. Oggi tale ipotesi di obbligatorietà è stata espunta dall’ordinamento, perché considerata incostituzionale dalla Corte in quanto del tutto irragionevole: si applicava a prescindere dal reato fondante, e teneva conto del solo reato espressivo, il quale doveva rientrare in un catalogo del tutto eterogeneo ex art. 407 c.p.p. Nella disciplina attuale l’unica obbligatorietà concerne il quantum di pena, e non anche la valutazione sull’an, quindi la valutazione in merito alla sussistenza o meno della recidiva.3 - Gli effetti secondari della recidivaLa legge penale ricollega delle conseguenze pregiudizievoli ulteriori al soggetto che è stato dichiarato recidivo. Infatti, non si ha il solo effetto diretto dell’incremento di pena, ma si hanno anche ulteriori effetti, tra cui, una maggiore difficoltà nel riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62 bis co. 2 bis c.p.); un limite minimo di aumento della pena nel caso di reato continuato commesso dal recidivo reiterato (art. 81 co. 4 c.p.); un allungamento del termine di prescrizione (art. 157 c.p.); una maggiore limitazione in caso di amnistia e indulto (artt. 151 co. 5 e 171 co. 3 c.p.).La Corte di Cassazione a Sezioni Unite si è occupata più volte del campo di applicazione di tali effetti pregiudizievoli ulteriori. È pacifico che se il giudice non ha proprio applicato la recidiva, perché ha ritenuto che tra reato fondante e reato espressivo non vi era alcun collegamento, allora non si verificherà né l’effetto principale dell’aumento di pena, né gli effetti secondari.Se, invece, ha applicato la recidiva perché sussiste un collegamento tra i due reati, allora si produrranno anche gli effetti secondari, oltre all’aumento di pena. Il caso problematico è quello del concorso eterogeneo di circostanze, cioè il caso in cui il fatto di reato è connotato sia da circostanze attenuanti sia da circostanze aggravanti, quali la recidiva. Il giudice dovrà operare il giudizio di bilanciamento previsto dall’art. 69 c.p. alla luce del quale la circostanza aggravante della recidiva potrà essere considerata prevalente, equivalente o subvalente rispetto alle attenuanti.Nel caso in cui risulti prevalente la recidiva, è pacifico che si produrranno gli effetti secondari oltre all’effetto principale dell’aumento di pena.Se, invece, la recidiva risulta equivalente rispetto alle attenuanti, una prima tesi ha sostenuto che vi sia stata una elisione della stessa, a fronte della quale è scomparsa, e non essendoci stato un aumento di pena non possono esservi neanche gli effetti secondari. Le Sezioni Unite nel 2010, diversamente, hanno sostenuto che, anche se apparentemente scomparsa, in realtà il giudice ha ritenuto esistente la recidiva, perché altrimenti non avrebbe potuto fare il giudizio di bilanciamento. Quindi anche in caso di equivalenza la recidiva è da ritenersi applicata, e quindi trovano applicazione anche le norme sugli effetti secondari.Infine, nel caso in cui la recidiva venga ritenuta subvalente rispetto alle attenuanti, sono state sostenute due tesi. Una prima tesi, accolta dalle Sezioni Unite nel 2021, ritiene che anche in questo caso la recidiva è da ritenersi applicata e di conseguenza anche tutti gli effetti secondari troveranno applicazione. Una seconda tesi, accolta da altre Sezioni Unite nel 2018, ritiene invece che solo nel caso in cui sia espressamente previsto dalla legge anche in caso di subvalenza dovranno applicarsi gli effetti secondari, come avviene per la disciplina della prescrizione (artt. 157 e 161 c.p. che ritengono comunque esistente la recidiva, anche se subvalente), e non invece negli altri casi in cui non esiste una norma specifica.Editor: dott.ssa Claudia Cunsolo
Continua a leggere
Scritto da:

Egregio Avvocato
I messaggi WhatsApp e gli Sms posso essere usati come prova in un processo penale?
20 set. 2022 • tempo di lettura 2 minuti
Il modo attraverso cui le persone comunicano ed interagiscono tra loro è profondamente mutato, infatti spesso capita di conversare attraverso Sms oppure utilizzando la piattaforma messaggistica nota con il nome WhatsApp. Può capitare, però, che il contenuto delle comunicazioni possa configurare alcune ipotesi di reato (ad esempio possono contenere una minaccia, una diffamazione, forme di bullismo, ecc.) e, quindi, verrebbe da chiedersi se possano assumere dignità di prova all’interno del processo penale. Sul punto la giurisprudenza si è interrogata e, analizzando l’art. 234 del codice di procedura penale, ha espresso il principio di diritto secondo cui “i messaggi WhatsApp così come gli sms conservati nella memoria di un apparecchio cellulare hanno natura di documenti ai sensi dell'art. 234 c.p.p., di tal che la relativa attività acquisitiva non soggiace alle regole stabilite per la corrispondenza, né tantomeno alla disciplina delle intercettazioni telefoniche, con l'ulteriore conseguenza che detti testi devono ritenersi legittimamente acquisiti ed utilizzabili ai fini della decisione ove ottenuti mediante riproduzione fotografica a cura degli inquirenti” (così Cass. Pen. Sez. VI, n. 31364/2022). L’art. 234 c.p.p. disciplina la prova documentale, la quale consiste in scritti o altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose, mediante la fotografia, cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo.Il Legislatore italiano, nel prevedere la possibilità di acquisire scritti o altri documenti durante un processo penale, non ha fornito una definizione univoca del termine documento. Sulla scorta di questa considerazione, è di tutta evidenza che non pochi dubbi sono emersi circa la possibilità di acquisire, in un procedimento penale, Sms o messaggi WhatsApp contenuti nella memoria di uno smartphone. I dubbi erano sostanzialmente incentrati sulla necessità o meno di applicare, sia nel caso degli Sms che nel caso dei messaggi WhatsApp, le regole stabilite per la corrispondenza o per le intercettazioni telefoniche.Ed invero, detti flussi di comunicazione non soggiacerebbero alla disciplina prevista per la corrispondenza perché non rientrerebbero nel concetto stesso di "corrispondenza", cioè di un'attività di spedizione in corso o comunque avviata dal mittente mediante consegna a terzi per il recapito.D’altra parte, altresì, i messaggi WhatsApp e gli Sms non richiederebbero l’applicazione delle regole previste per le intercettazioni, in quanto l'attività di intercettazione postula, per sua natura, la captazione di un flusso di comunicazioni in corso, là dove, invece, i dati presenti sulla memoria del telefono acquisiti ex post costituirebbero la mera documentazione di detti flussi. È opportuno, però, sottolineare che gli Sms e i messaggi WhatsApp possono assumere dignità di prova processuale, solamente se sono ottenuti mediante riproduzione fotografica a cura degli inquirenti, cioè se il testo del messaggio venga materialmente fotografato dall’operante di Pg direttamente dal display dello smartphone che lo ha ricevuto.
Continua a leggere
Scritto da:
Il rapporto tra il reato di maltrattamenti in famiglia ed atti persecutori, anche con riferimento all’operatività del divieto di bis in idem.
23 mag. 2020 • tempo di lettura 8 minuti
Le figure di reato in esame hanno da sempre sollevato non pochi problemi con riferimento ad ipotesi di concorso apparente di norme a stento risolvibile secondo le regole del principio di specialità, di cui all’art. 15 c.p., in ragione del quale appunto, ove la stessa materia sia regolata da plurime leggi penali ovvero plurime disposizioni della medesima legge penale, la legge, o la disposizione di legge speciale, deroga alla legge, od alla disposizione di legge generale, salvo che sia diversamente stabilito.Si tratta di fattispecie incriminatrici, tuttavia, estremamente distinte per plurime ragioni, non da ultimo sotto il profilo della struttura del fatto tipico profilabile in ciascuna delle predette previsioni normative.Se da un lato, infatti, la norma di cui all’art. 572 c.p. è posta a tutela della famiglia, ovvero delle comunità ad essa assimilabili, dall’altro l’art. 612bis punisce la condotta antigiuridica di colui che lede la libertà morale della persona, con atti reiterati tali da impedire alla medesima di condurre una regolare attività di vita quotidiana. Ciò detto, la differenza forse che balza maggiormente agli occhi riguarda la connotazione del fatto tipico: per l’una, ossia per il delitto di maltrattamenti, si tratta di un reato proprio, considerato che la condotta incriminata può essere commessa solo da colui che riveste un determinato ruolo all’interno della compagine familiare o sociale, assimilabile alla famiglia come nucleo essenziale di qualsiasi società umana; al contrario, il delitto di atti persecutori (breviter noto come stalking) è un reato comune, alla luce anche del dettato normativo che utilizza non a caso il pronome “chiunque”, purchè il soggetto attivo ponga in essere atti di minaccia o molestia, reiterati nel tempo, e che non presuppone l’esistenza di interrelazioni soggettive specifiche. E’ utile rammentare, al riguardo, come la S.C. con la sentenza n. 8832 del 07/03/2011 ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 612bis c.p., che gli atti ritenuti persecutori abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima.Un’altra differenza altrettanto rilevante risiede nel fatto che, se da un lato la condotta di atti persecutori deve essere, ai fini della sua esatta integrazione, reiterata nel tempo, il delitto di maltrattamenti circoscrive un reato tipicamente abituale. La differenza consiste nel fatto che, se da una parte il reato abituale si verifica in presenza di condotte costanti da parte del reo, consistenti, nella species dei maltrattamenti, in atti di prevaricazione sulla vittima in ragione proprio del ruolo di supremazia esercitato sulla vittima all’interno di un consesso familiare o parafamiliare, dall’altro la reiterazione delle condotte può coinvolgere un lasso più o meno ampio di tempo (potendosi dunque integrare la fattispecie di reato di cui all’art. 612bis anche solo in presenza di due sole condotte intervallate da un consistente lasso temporale), a condizione che le stesse siano tali da causare determinati eventi o sul piano psichico (perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero fondato timore per la propria incolumità o quella di un prossimo congiunto) o sul piano comportamentale (alterazione delle proprie abitudini di vita).Vista la diversità strutturale tra le fattispecie sopra menzionate, bisogna escludere che tra le medesime sussista un rapporto di specialità assimilabile a quello di cui all’art. 15 c.p., che all’uopo dispone il principio generale di soluzione del concorso apparente di norme incriminatrici sovente utilizzato dalla maggioritaria giurisprudenza di legittimità. Orbene, vale la pena rammentare a noi stessi il significato dell’espressione testè utilizzata. Il concorso o conflitto apparente di norme si realizza ogni qual volta lo allo stesso fatto siano applicabili solo apparentemente plurime fattispecie incriminatrici, essendo il fatto in sé sottoponibile ad una sola di esse. Lo stesso è a dirsi per il caso in cui a plurimi fatti siano astrattamente applicabili plurime fattispecie di reato, sebbene solo una di esse possa irrogarsi nel caso concreto, con conseguente impunità del fatto antecedente o di quello susseguente al fatto concretamente punito. Sulla scorta di tali premesse, è ormai noto che, a fronte dei diversi criteri elaborati dalla dottrina per la soluzione dei casi di conflitto apparente di norme (criteri di specialità, sussidiarietà e consunzione od assorbimento), la giurisprudenza di legittimità, in ossequio alla c.d. teoria monistica, ha ormai avallato il criterio cardine elaborato dallo stesso legislatore del 1930, ossia il criterio di specialità di cui è menzione al più volte menzionato art. 15 c.p., secondo cui “quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o disposizione di legge speciale deroga alla legge od alla disposizione di legge generale, salvo che sia diversamente stabilito.” E’ giocoforza sostenere che, in caso di abrogazione della norma speciale, la norma generale acquisterà la portata originaria, precedentemente compressa dalla previsione a carattere speciale.Tornando ora al rapporto tra le fattispecie ut supra descritte, il rapporto di specialità è escluso altresì alla luce della previsione del dettato normativo evincibile dall’art. 612bis c.p. ossia “salvo che il fatto costituisca più grave reato”, che permette di risolvere il conflitto apparente configurabile alla stregua del principio di sussidiarietà , sebbene ad oggi la clausola anzidetta risulti di ardua applicazione in relazione all’ipotesi aggravata del reato di atti persecutori, introdotto al secondo comma della previsione in esame come introdotto dalla novella legislativa del 2013. La conseguenza di quanto detto è che il concorso viene quindi ammesso solo quando vi sia cessazione del sodalizio familiare: infatti, l’art. 612bis c.p. diviene idoneo a sanzionare comportamenti che, sorti in seno alla comunità familiare (od altra assimilata) esulerebbero dalla fattispecie di maltrattamenti in ragione della cessazione del vincolo familiare, come sovente accade a seguito di divorzio o cessazione degli effetti civili del matrimonio ex L. 898/1970.A questo proposito, la giurisprudenza di legittimità costante ritiene ormai che il reato di maltrattamenti sia parimenti configurabile in ipotesi di separazione legale dei coniugi, essendo opinione largamente condivisa quella per cui gli effetti civili del matrimonio cessino solo in conseguenza di divorzio o della sentenza costitutiva di divorzio, integrando la separazione personale dei coniugi, come scolpita dal legislatore del 1942, una mera situazione di fatto comportante sospensione dei doveri coniugali con attenuazione dell’obbligo di fedeltà.Come già anticipato, uno dei problemi più rilevanti in tema di rapporto tra le fattispecie in esame riguarda il rapporto del reato di maltrattamenti con l’ipotesi aggravata di cui al secondo comma dell’art. 612bis c.p., introdotta dalla Novella del 2013, stante l’aumenta di pena massima edittale prevista dal legislatore della riforma, secondo cui infatti “La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.”Tale ultima previsione ha comportato una serie di problemi di interpretazione, specie avendo riguardo al rapporto con la fattispecie di cui all’art. 572 c.p., in relazione alla quale viene a cessare la relazione di sussidiarietà come prevista dalla clausola generale contenuta nella norma di cui all’art. 612bis c.p. La soluzione, idonea ad evitare un cumulo sanzionatorio, potrebbe essere quella di ritenere applicabile la fattispecie aggravata di cui al novellato secondo comma dell’art. 612bis c.p., che assorbe secondo il principio di consunzione la previsione di maltrattamenti in famiglia. In questo modo, però, si derogherebbe alla tesi monista illustrata in precedenza e sposata dalla migliore giurisprudenza di legittimità in materia, secondo cui, appunto, in assenza di specifiche e diverse disposizioni di legge, si applica sempre e comunque il criterio di specialità previsto dall’art. 15 c.p.Per concludere, ai fini dell’applicazione del divieto di bis in idem processuale di cui all0art. 649 c.p.p., in ragione del quale “l’imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, il grado o per le circostanze.Anche in tal caso, l’interpretazione giurisprudenziale registratasi in tema di ne bis in idem (ex multis Cass. Sez. V 15 febbraio 2019 n. 24555) ha formulato il seguente principio di diritto: ai fini della medesimezza del fatto, è necessario che sia sussistente una corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti gli elementi costitutivi, ossia condotta, evento e nesso causale, nonché con riguardo alle circostanze di tempo, luogo e persona. Una simile conclusione non può essere messa in dubbio ove il processo definito con sentenza irrevocabile abbia avuto ad oggetto una qualificazione del fatto diversa da quella correttamente applicabile, come accade nel caso in cui venga contestato il reato di atti persecutori, anziché quello di maltrattamenti, al coniuge che con condotte plurime lede la libertà personale dell’altro coniuge in costanza del vincolo matrimoniale.La soluzione appena esposta risulta essere altresì conforme all’approdo della giurisprudenza costituzionale, a proposito del divieto di bis in idem processuale, in ragione della quale si è addivenuti ad un sostanziale incremento dell’ambito applicativo della norma di cui all’art. 649 c.p. In ragione del citato orientamento del Giudice delle Leggi, dunque, la medesimezza del fatto storico, interpretata in ragione dell’identità degli elementi costitutivi delle fattispecie e delle circostanze di tempo, luogo e persona, esclude la possibilità di una ulteriore iniziativa penale anche nell’ipotesi in cui la seconda fattispecie in parola appaia riconducibile all’alveo del concorso formale rispetto alla fattispecie per cui si è formato il giudicato.Pertanto, l’identità del fatto deve essere vagliata in relazione al concreto oggetto del giudicato e della nuova contestazione che il Magistrato del Pubblico Ministero intenda muovere, senza confrontare gli elementi che aiutano a circoscrivere le astratte previsione normative.
Continua a leggere
Scritto da:
Tutela Fasce Deboli nel nostro ordinamento penale
16 ago. 2023 • tempo di lettura 2 minuti
Tutela della disabilità nel diritto nazionaleNell’ordinamento penale sono presenti numerose disposizioni che configurano come reati determinate condotte in danno delle persone disabili. In alcune di queste la disabilità è considerata elemento costitutivo del reato stesso. Alcuni esempi sono rappresentati dai seguenti articoli del codice penale:558 bis, co 2: Costrizione o induzione al matrimonio ai danni di persona in condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica574: Sottrazione di persone incapaci. 579, co 3, n.2: Omicidio del consenziente, quando questo è persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un’altra infermità.591: Abbandono di persone minori o incapaci.593: Omissione di soccorso su persona incapace di provvedere a sé stessa, per malattia di mente o di corpo.600: Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù quando la vittima versa in condizione di inferiorità fisica o psichica.609 bis, co 2 n.1: Violenza sessuale quando la vittima versa in condizione di inferiorità fisica o psichica al momento del fatto.612 bis: Atti persecutori su persone disabili (secondo la definizione specificata dall’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104).L’art. 36 della l. 104/1992 prevede invece un’aggravante speciale, ad effetto speciale, che comporta l’aumento – da un terzo alla metà – delle sanzioni penali, per i reati seguenti, quando compiuti ai danni di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale:art. 527 cp (atti osceni).Reati non colposi elencati nel libro secondo, titolo XII (dei delitti contro la persona) e titolo XIII (dei delitti contro il patrimonio) del codice penale.Reati di cui alla L. 75/1958 (c.d. “legge Merlin”): reclutamento, induzione, favoreggiamento, sfruttamento della prostituzione, qualora commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale come definite dall’art. 3 della medesima legge.L’aggravante prevista dall’articolo 36 non si applica però quando la condizione di disabilità della vittima integri già un elemento costitutivo o una circostanza aggravante speciale del reato.Prof. Dr. Giovanni Moscagiuro studio delle Professioni e Scienze forensi e Criminologia dell'Intelligence ed Investigativa Editori e Giornalisti europei in ambito investigativo Diritto Penale , Amministrativo , Tributario , Civile Pubblica Amministrazione , Esperto in Cybercrime , Social Cyber Security , Stalking e Cyberstalking, Bullismo e Cyberbullismo, Cybercrime, Social Crime, Donne vittime di violenza, Criminologia Forense, dell'Intelligence e dell'Investigazione, Diritto Militare, Docente di Diritto Penale e Scienze Forensi, Patrocinatore Stragiudiziale, Mediatore delle liti, Giudice delle Conciliazioni iscritto all'albo del Ministero di Grazia e Giustizia, Editori e Giornalisti European news Agencyenail: studiopenaleassociatovittimein@gmail.com
Continua a leggere
Commenti
Non ci sono commenti






