Truffa online e circostanza aggravante della c.d. minorata difesa

Egregio Avvocato
Pubblicato il 21 giu. 2021 · tempo di lettura 6 minuti
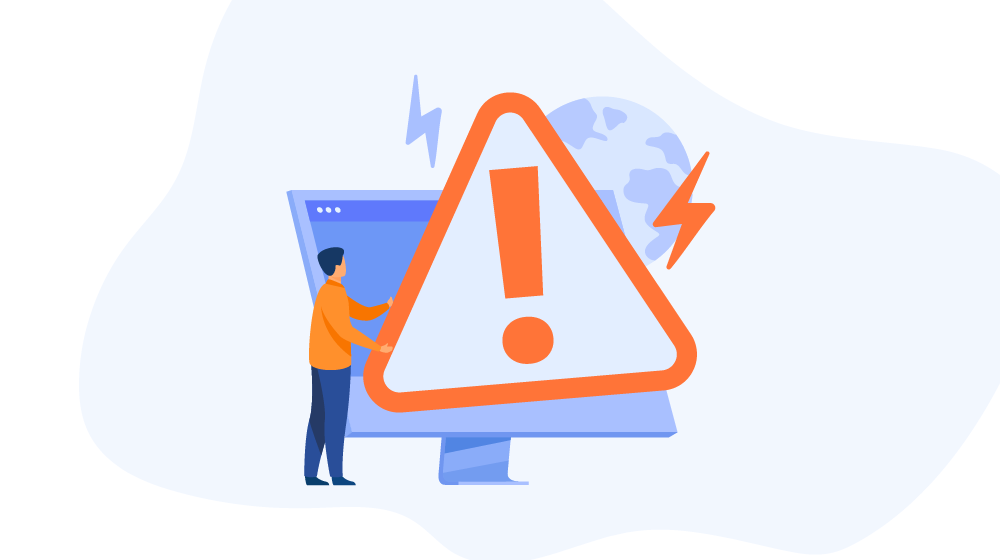
La rapida diffusione della tendenza di condurre le pratiche commerciali sul web ha portato la giurisprudenza di legittimità a interrogarsi sulla configurabilità della circostanza aggravante della c.d. minorata difesa in relazione alle ipotesi delittuose di truffa perpetrate online. Cerchiamo dunque di fornire la definizione di ‘minorata difesa’ e di analizzare i presupposti che ad avviso della Corte di cassazione devono sussistere ai fini del riconoscimento dell’aggravante in caso di truffa online.
- Quali sono gli elementi costitutivi del reato di truffa?
- Cosa si intende per ‘minorata difesa’?
- Truffa online e minorata difesa: qual è la posizione della giurisprudenza?
- Quali sono le conseguenze derivanti dalla sussistenza della circostanza aggravante?
1 - Quali sono gli elementi costitutivi del reato di truffa?
Abbiamo già avuto l’occasione di affrontare l’argomento del reato di truffa perpetrato attraverso l’utilizzo di mezzi telematici (se sei interessato clicca qui per saperne di più). Per quanto qui di interesse – vale a dire l’applicabilità della circostanza aggravante della c.d. minorata difesa – sarà dunque sufficiente menzionare concisamente gli elementi costitutivi della disposizione incriminatrice.
Nel codice penale, la c.d. truffa online – nella quale una persona potrebbe incorrere navigando in internet – non trova collocazione in una fattispecie delittuosa ad hoc, ma può essere sussunta nel ‘tradizionale’ reato di truffa di cui all’art. 640 c.p. La peculiarità della truffa online risiede semplicemente nel luogo di verificazione della condotta illecita e, quindi, delle relative modalità di manifestazione del reato: gli artifizi e i raggiri, difatti, si concretizzano attraverso l’utilizzo del web.
La regolamentazione predisposta dal legislatore penale, tuttavia, è sempre la medesima. L’art. 640 c.p., infatti, prevede in ogni caso la pena detentiva da sei mesi a tre anni e una multa compresa tra 51 e 1.032 euro per colui il quale, attraverso artifizi o raggiri, induca taluno in errore provocando per sé o per altri un profitto ingiusto e, specularmente, arrecando un danno all’altra persona.
Affinché il reato possa dirsi consumato, quindi, è necessario che la condotta truffaldina (gli artifizi o i raggiri) induca dapprima in errore la vittima, la quale è così portata ad avere un comportamento che altrimenti non avrebbe tenuto; da ciò deve derivarne, da un lato, un danno, che secondo l’opinione prevalente deve essere di natura patrimoniale, e dall’altro un profitto ingiusto, che invece può essere inteso anche in un senso non strettamente economico.
2 - La circostanza aggravante della c.d. minorata difesa
Con l’appellativo ‘minorata difesa’ si fa riferimento a una circostanza aggravante comune e ad efficacia comune – ossia che determina un aumento sino a un terzo della pena che dovrebbe essere inflitta per il reato ‘semplice’ – prevista dall’art. 61, co. 1 n. 5 c.p., che più specificatamente prescrive l’aggravamento di pena per “aver approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o la privata difesa”.
La circostanza aggravante, in altre parole, concerne una serie di situazioni legate a fattori ambientali o personali di cui il soggetto attivo del reato approfitta consapevolmente al fine di trarre in inganno la vittima. Così, ad esempio, il caso in cui si compia una truffa a danno di una persona che versi in uno stato fisico o psichico di particolare debolezza o, come vedremo nel paragrafo successivo, qualora il reato venga commesso approfittando delle peculiari condizioni di operatività del web.
Come previsto espressamente dalla disposizione, inoltre, non è necessario che la difesa della persona offesa sia completamente impedita, ma è sufficiente che venga soltanto ostacolata.
3 - Truffa online e minorata difesa: la posizione della giurisprudenza di legittimità
La configurabilità della circostanza aggravante della minorata difesa con riferimento all’ipotesi delittuosa della truffa perpetrata online è stata più volte oggetto di attenzione da parte della giurisprudenza di legittimità. Specialmente negli ultimi anni – in ragione della repentina diffusione delle pratiche commerciali sul web – la Corte di cassazione ha affrontato la questione in svariate occasioni.
I giudici di legittimità, nel riconoscere la potenziale sussistenza della circostanza aggravante in caso di truffa online, hanno identificato quale elemento dirimente ai fini dell’integrazione della minorata difesa la costante distanza intercorrente tra venditore e acquirente, i quali, operando tramite internet, si trovano in luoghi fisici diversi e, con ogni probabilità, molto distanti tra loro [così Cass. pen., sez. II, ud. 14 ottobre 2020 (dep. 13 gennaio 2021), n. 1085, nonché più di recente Cass. pen., sez. II, 14 gennaio 2021 (dep. 31 marzo 2021), n. 12427].
La distanza nella contrattazione, a ben vedere, pone il venditore in una posizione di vantaggio rispetto al soggetto acquirente, il quale, non avendo la possibilità di visionare personalmente il prodotto, per concludere la trattativa deve fidarsi delle immagini che gli vengono messe a disposizione. Inoltre, il venditore, utilizzando gli strumenti informatici e telematici, può schermare la propria identità, nonché sottrarsi con facilità alle conseguenze della propria condotta truffaldina.
È di tutta evidenza, dunque, come le peculiarità della contrattazione telematica – determinando un ostacolo nella privata difesa – consentono il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all’art. 61, co. 1 n. 5 c.p.
Con riferimento alla condizione di ricorrenza dell’aggravante in questione – vale a dire la distanza nella contrattazione condotta tra acquirente e venditore – è tuttavia necessaria una specificazione. La distanza, come detto, deve essere costante, ossia deve permanere per tutta la durata delle trattative. Qualora ciò non avvenga – come sostenuto dalla Corte di cassazione – non potrebbe dirsi integrata l’aggravante della minorata difesa [ancora Cass. pen., sent. n. 1085/2020, che non ha riconosciuto la sussistenza dell’aggravante]. È l’ipotesi, ad esempio, della contrattazione iniziata su piattaforme telematiche e poi proseguita anche attraverso incontri di persona. In un caso del genere, evidentemente, verrebbe meno la posizione di svantaggio in cui versa il potenziale acquirente all’inizio della trattativa condotta online.
4 - Quali sono le conseguenze derivanti dalla sussistenza della circostanza aggravante?
Dal riconoscimento della circostanza aggravante di cui si discute discendono una serie di conseguenze particolarmente significative in punto di contestazione del reato di truffa.
Quella più evidente, anzitutto, riguarda il trattamento sanzionatorio del reato, la cui cornice edittale, ai sensi dell’art. 640, co. 2 c.p. si innalza nella pena detentiva sino a un massimo di cinque anni e nella multa sino a 1.549 euro.
In virtù dell’art. 131-bis, co. 2 c.p., che menziona espressamente la circostanza della minorata difesa, il fatto di reato non può essere considerato di particolare tenuità e, pertanto, non è incluso nell’ambito applicativo della causa di esclusione della punibilità.
Da un punto di vista processuale, poi, il reato diviene procedibile d’ufficio e non più in funzione della querela presentata dalla persona offesa. Ai sensi dell’art. 278 c.p.p., inoltre, differentemente dalla regola generale si tiene conto della minorata difesa nella determinazione della pena ai fini dell’applicazione delle misure cautelari. Da ciò ne discende, sempre con riferimento alla truffa, che innalzandosi la pena detentiva massima sino a cinque anni potrà essere disposta, laddove ricorrano i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari, la custodia cautelare in carcere [questione peraltro oggetto della citata sentenza della Corte di cassazione, si veda supra Cass. pen., sent. n. 1085/2020].
Editor: Avv. Davide Attanasio
Condividi:
Truffa online e circostanza aggravante della c.d. minorata difesa
Pubblicato da:

Egregio Avvocato
Articoli che potrebbero interessarti
Cosa è lo stalking organizzato e il controllo mentale
21 lug. 2023 • tempo di lettura 5 minuti
Lo stalking organizzato è un sistema di “guerra non convenzionale/psicologica“, di persecuzione e di tortura che ha come scopo l’eliminazione di un obbiettivo, di solito attivisti politici non controllati, ricercatori delle cospirazioni, gente che si oppone all’immigrazione e al globalismo, spie, gente che tenta di denunciare gravi crimini e abusi perpetrati da parte di grandi aziende o organizzazioni statali eccetera. Lo stalking organizzato è secondo me un metodo per portare avanti la dittatura del nuovo ordine mondiale.Lo stalking organizzato è un programma simile al programma COINTELPRO dell’FBI in cui l’FBI prendeva di mira, sabotava, screditava ed eliminava attivisti politici in diversi modi e si infiltrava in organizzazioni politiche. È anche simile – una combinazione tra i due programmi – al progetto MKULTRA della CIA, visto che alcune vittime prese di mira (Targeted Individuals) vengono attaccate con armi elettroniche (armi ad energia diretta e controllo mentale) e usate come cavie umane per testarle.Lo stalking organizzato si potrebbe definire anche come un nuovo “Phoenix Program” su scala globale, un programma in cui la CIA in Vietnam selezionava obbiettivi civili che venivano messi in delle liste per poi venire neutralizzati/eliminati.Lo stalking organizzato è anche molto simile alla tecnica “Zersetzung” che veniva usata dalla STASI, la polizia segreta della Germania dell’est durante il comunismo, in cui 1 cittadino su 6 lavorava come collaboratore non ufficiale per i servizi segreti.“Una guerra silenziosa si sta verificando nelle città di tutto il mondo. Viene coperta dai media, dalla psichiatria, dalle organizzazioni non governative (ONG) e dai politici. Ora che l’élite finanziaria ha finito di usare le forze armate americane e i loro alleati per conquistare nazioni con l’obbiettivo del totale dominio mondiale, stanno neutralizzando individui e gruppi di individui che vivono tra le popolazioni civili che ancora resistono. Per lo scopo hanno reclutato gran parte della popolazione civile per perseguitare coloro che sono stati identificati come nemici. Le “forze di sicurezza” stanno conducendo operazioni psicologiche (PsyOps) contro civili e torturandoli con armi ad energia diretta. L’intera operazione è al servizio di un gruppo di ricchi psicopatici che governano la nostra società, come parte di una rivoluzione mondiale creata per portare avanti una dittatura mondiale conosciuta come il Nuovo Ordine Mondiale.” – New world War: Revolutionary Methods for Political Control by Mark M. RichLo stalking organizzato è un operazione civile-militare (CMO) illegale/criminale (mettiamo che abbiano una qualche legge o ordine esecutivo che li permette di portare avanti queste operazioni, questa gente hanno truffato in massa e mentito per ottenere tali leggi anticostituzionali/criminali e quindi sono illegali sotto ogni aspetto come l’operazione stessa) portata avanti da una coalizione internazionale formata da lavoratori, aziende, civili, militari, agenti segreti, forze di polizia, organizzazioni non governative (NGO) e organizzazioni intergovernative (IGO). I metodi e le tattiche principali usate da questa forza multinazionale per neutralizzare/distruggere obbiettivi civili sono le “operazioni psicologiche” (PsyOps) e le “armi non letali“.“C’è un protocollo di base usato in ogni nazione della NATO con il quale cominciano le operazioni di stalking organizzato.Iniziano con la sorveglianza illegale degli obiettivi, il monitoraggio della loro vita privata e violando il loro domicilio. Questo viene fatto in modo da profilare i tratti della loro personalità.‘C’è un protocollo di base con il quale gli stalkers iniziano’, afferma McKinney, ‘ma l’individuo bersaglio (Targeted Individual) contribuisce alla modifica.’Dr. Munzert parla fondamentalmente dello stesso modello che descrive come una “strategia a doppio taglio”.‘Una parte consiste nell’attaccare le vittime con armi a microonde (armi ad energia diretta)’ e l’altra parte della strategia, dice, ‘è quella di cercare di fare passare gli individui bersaglio come pazzi.’” – The Hidden Evil Mark M. Rich“Lo stalking organizzato è una forma di terrorismo utilizzato nei confronti di un individuo in cui si tenta di ridurre la qualità della vita di una persona e fare in modo che: abbia un esaurimento nervoso, venga incarcerata, istituzionalizzata, subisca costantemente dolore mentale, emotivo o fisico, diventi un senza tetto e finisca con il suicidarsi. Il tutto viene fatto usando accuse ben orchestrate, bugie, diffamazioni, false indagini, intimidazioni, minacce dirette o subliminali, vandalismo, furti, sabotaggi, torture, umiliazioni, terrorismo psicologico e molestie in generale. È un sistema in cui molti agiscono contro un individuo nella comunità venendo coordinati da un organizzatore che recluta gente per partecipare nella sistematica persecuzione di un individuo e per terrorizzarlo.”La maggior parte degli “stalkers” – dipende dai livelli – non sanno di cosa si tratti veramente, pensano che sia una forma di mobbing organizzato al di fuori del posto di lavoro e vengono usati per sensibilizzare la vittima a nuovi inneschi e torturarla. O viene detto loro che l’obbiettivo preso di mira (Targeted Individual) è un individuo pericoloso o potenzialmente pericoloso e che deve per un qualche motivo essere controllato. No, al contrario di quello che molti pensano lo stalking organizzato non ha niente a che fare con il mobbing, punire/controllare criminali o con il “normale” stalking in cui un uomo – o donna – molesta e perseguita la sua ex. Nello stalking organizzato è l’intero stato, l’imprenditoria privata eccetera che ti fa stalking non degli individui che agiscono di propria iniziativa.Alcune delle tattiche più usate nello stalking organizzato sono: le campagne diffamatore, campagne di rumore, campagne di sensibilizzazione (PNL), mirroring, operazioni psicologiche (PsyOps), Gaslighting, Street Theater e altro.Tattica di stalking organizzato – Campagne di rumoreQuesta tattica consiste nel molestare costantemente la vittima con rumori, generare rumori con trapani e altri macchinari, sbattere intenzionalmente porte e tutto il resto. Serve chiaramente per tenere la vittima in uno stato di stanchezza e confusionale e per sensibilizzare la vittima a dei suoni per la tortura e le persecuzioni.Tattica di stalking organizzato – Campagne di sensibilizzazione PNLQuesta tattica consiste nel sensibilizzare – con la ripetizione – la vittima a gesti, oggetti, parole, suoni, simboli per torturarla e perseguitarla. Serve per fare sapere alla vittima che viene seguita ovunque mostrando il simbolo, la parola eccetera a cui è stata sensibilizzata. Gli stalkers cercano di sensibilizzare la vittima a più parole, oggetti, scene eccetera possibile così da torturarla molto di più ma senza dare nell’occhio perché una volta è un numero, una volta è un gesto e così via. Questi oggetti, gesti, suoni eccetera vengono poi associati a emozioni di tipo negativo come la rabbia, l’impotenza e la paura diventando così degli inneschi PNL (NLP Triggers) che evocano appunto emozioni di tipo negativo. Gli stalkers usano eventi che occorrono anche normalmente e ne aumentano la frequenza.Gli stalkers nascondono gran parte delle loro molestie usando una semplice formula.Da quello che ho potuto constatare le formule base sono:La frequenza: descrive quanto spesso un evento accada. Riguarda anche il numero di atti durante un singolo evento.Durata: riguarda la lunghezza di un singolo evento. Riguarda anche la natura delle molestie che sono continue e non finiscono mai.Intensità: l’amplificazione degli atti come fare rumore, la vista, l’affollamento, eccetera all’interno di un evento.
Continua a leggere
Estinzione del reato per condotte riparatorie ex art. 162-ter c.p.
22 lug. 2021 • tempo di lettura 4 minuti
La l. 23 giugno 2017, n.103, ha introdotto, all’art. 162-ter c.p., una particolare causa estintiva del reato, grazie alla quale l’imputato ha la possibilità di ottenere l’estinzione del reato riparando interamente il danno cagionato dal reato e elidendo, ove possibile, le conseguenza dannose o pericolose dello stesso.RatioAmbito di applicazioneCome avviene la riparazione del danno?Procedimento 1 - RatioAi sensi dell’art. 162-ter c.p., nei reati perseguibili a querela, il giudice dichiara l’estinzione del reato quando l'imputato ha riparato interamente il danno con le restituzioni o il risarcimento e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato.La ratio della norma risponde all'esigenza di deflazionare il carico giudiziario, offrendo all'imputato uno strumento per conseguire l'estinzione del reato. L’integrale riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e l’eventuale eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato costituiscono condotte riparatorie che, generalmente, inducono il querelante a rimettere la querela, con conseguente estinzione del reato ai sensi dell’art. 152 c.p.: secondo questa norma, “nei delitti punibili a querela della persona offesa, la remissione estingue il reato”.La novità sostanziale introdotta con l'art. 162-ter c.p. sta allora nel fatto che, anche qualora la persona offesa non rimetta la querela, il giudice dichiara comunque estinto il reato quando ritenga che il danno da esso cagionato sia stato interamente riparato dall'imputato.2 - Ambito di applicazioneSecondo quanto disposto dall’art. 162-ter c.p., l’estinzione del reato per condotte riparatorie può operare solo in relazione a reati procedibili a querela di parte.Due ulteriori limitazioni.In primo luogo, deve trattarsi di reati in cui la querela è soggetta a rimessione, cioè “revocabile” da parte della persona offesa. Risulta escluso, ad esempio, il delitto di violenza sessuale, in relazione al quale l’art. 609-septies c.p. stabilisce che “la querela proposta è irrevocabile”.In secondo luogo, a mente dell’u. co. dell’art. 162-ter c.p., introdotto nel 2017, non può essere estinto a seguito di condotte riparatorie il delitto di atti persecutori (c.d. “stalking”) di cui all’art. 612-bis c.p.3 - Come avviene la riparazione del danno?La riparazione del danno cagionato può avvenire in due modi:risarcimento: consiste nel versamento di una somma di denaro equivalente al pregiudizio causato alla persona offesa;restituzioni: consistono nella reintegrazione dello stato di fatto preesistente alla commissione del reato.Inoltre, l’imputato deve, ove possibile, eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato.Se il giudice riconosce che l’imputato abbia riparato interamente il danno cagionato, dichiara l’estinzione del reato anche in mancanza di una formale rimessione di querela da parte della persona offesa.L’art. 162-ter c.p. prevede, inoltre, che il risarcimento del danno possa essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale (cioè l'offerta effettiva della prestazione), formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo.Nei casi fino ad ora esaminati, l’imputato deve provvedere entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.Tuttavia, l’art. 162-ter co. 2 c.p. consente all’imputato di dimostrare di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine massimo di cui sopra. In questo caso, l'imputato può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine (che non superi i sei mesi), per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento: il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito per il pagamento.Durante tale periodo di sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso.4 - ProcedimentoL’istanza di estinzione del reato per condotte riparatorie può essere presentata dall’imputato personalmente o tramite il proprio difensore al giudice che procede.Se l'imputato ha già riparato interamente il danno, chiederà al giudice di riconoscerlo e dichiarare estinto il reato; se ha fatto offerta reale di risarcimento, non accettata dalla persona offesa, chiederà che il giudice anzitutto riconosca la congruità della somma offerta. Il pagamento deve avvenire, come già si è detto, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.Una volta ricevuta la richiesta dell’imputato, il giudice sente le parti e la persona offesa ma, anche se quest'ultima si oppone, egli potrà comunque ritenere la tempestività e congruità della condotta riparatoria e, di conseguenza, dichiarare estinto il reato. Quando, invece, la riparazione non è ancora avvenuta, se l'imputato dimostra di non aver potuto adempiere in tempo per fatto a lui non addebitabile, potrà chiedere al giudice la fissazione di un termine per provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento. In questo caso, il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo (per un massimo di sei mesi) e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza, imponendo specifiche prescrizioni.All'esito positivo delle condotte riparatorie, il giudice dichiara l'estinzione del reato: l’imputato andrà esente da pene, principali o accessorie, dagli effetti penali e dalle misure di sicurezza, ad eccezione della confisca obbligatoria ex art. 240 co. 2 c.p.Editor: dott.ssa Elena Pullano
Continua a leggere
Scritto da:

Egregio Avvocato
La responsabilità amministrativa degli enti
11 apr. 2022 • tempo di lettura 5 minuti
Il d.lgs. 231/2001 detta la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti per i reati commessi a suo interesse o vantaggio da un soggetto apicale oppure da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di questi. Premessa: che cosa significa responsabilità amministrativa degli enti e a chi si applicaPresuppostiReati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli entiSanzioni1 - Premessa: che cosa significa responsabilità amministrativa degli enti e a chi si applicaLa responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato è un tipo di responsabilità che possiede caratteristiche proprie della responsabilità penale e della responsabilità amministrativa.Sotto il primo punto di vista, la responsabilità scaturisce dalla commissione da parte di soggetti apicali dell’ente o di soggetto a loro gerarchicamente subordinati dei reati previsti dal decreto ed è la manifestazione della cosiddetta “colpa di organizzazione” dell’ente. L’accertamento della responsabilità, inoltre, è demandata alla competenza del giudice penale. Sotto il secondo punto di vista, quando è accertata la responsabilità, l’ente è soggetto a sanzioni di natura amministrativa (come la confisca).Ai sensi dell’art. 1 d. lgs. 231/2001, la responsabilità può essere imputata a:enti forniti di personalità giuridica;società e associazioni anche prive di personalità giuridica.Non possono essere chiamati a rispondere, invece, lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici e gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.L’ente si costituisce in giudizio tramite un legale rappresentante individuato nello statuto o nell’atto costitutivo. 2 - PresuppostiAi sensi dell’art. 5 del decreto, l’ente risponde per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da:soggetti in posizione apicale: si tratta di chi riveste “funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale” nonché di chi esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente stesso;soggetti sottoposti all’altrui direzione. L’ente, quindi, non è responsabile quando l’autore del reato ha agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi. A questo proposito, la giurisprudenza afferma che, qualora i soggetti agenti abbiano agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi, viene meno lo schema di immedesimazione organica: di conseguenza, l’illecito commesso, pur tornando a vantaggio dell’ente, non può più ritenersi come fatto suo proprio, ma un vantaggio fortuito, non attribuibile alla volontà della persona giuridica.L’ente, in secondo luogo, non è responsabile in altri due casi. Se il reato è commesso da un soggetto in posizione apicale, l’ente va esente da responsabilità se dimostra:di aver adottato il modello di organizzazione e gestione dei reati della specie di quello verificatosi; di aver affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l´osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; che le persone che hanno commesso il reato lo hanno fatto eludendo fraudolentemente il modello di organizzazione e di gestione;che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo preposto alla stessa. Tale ultima eventualità è sempre esclusa se l’ente ha adottato efficacemente il modello. A questo fine, i parametri per valutare l’efficacia del modello sono esplicitati all’art. 7 co. 4 del decreto: a titolo esemplificativo, il modello deve essere sottoposto a veridica periodica e deve essere elaborato un codice disciplinare volto a sanzionare le condotte contrarie a quanto prescritto.Se il reato è commesso da uno dei soggetti sottoposti all’altrui direzione, l’ente non è responsabile ove dimostri:che la commissione del reato non è stata permessa dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza;di avere, prima della commissione del reato, adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.Nei casi in cui l’ente risponde, la sua responsabilità è autonoma rispetto a quella della persona fisica (art. 8 del decreto): l’ente risponde, infatti, anche se l’autore del reato non è stato identificato o non è punibile e se il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia. 3 - Reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli entiLa responsabilità amministrativa degli enti è soggetta, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. 231/2001, al principio di legalità: l’ente risponde del reato commesso dalla persona fisica solo se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.A questo scopo, gli artt. 24 ss. d. lgs. 231/2001 contengono un fitto catalogo di reati che, se commessi, sono presupposto oggettivo di responsabilità amministrativa degli enti. Ricordiamo a titolo esemplificativo: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture;Delitti di criminalità organizzata, con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico;Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio;Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili e delitti contro la personalità individuale (ad es. prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico); Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonchè autoriciclaggio e delitti in materia di violazione del diritto d´autore.4 - SanzioniUna volta che viene accertata la commissione del reato da parte delle persone fisiche, quando sussistono i presupposti affinché anche l’ente sia ritenuto responsabile, quest’ultimo risponde di una delle seguenti sanzioni amministrative (art. 9 del decreto):sanzione pecuniaria;confisca;sanzioni interdittive (ai sensi dell’art. 9 co. 2, si tratta dell’interdizione dall’esercizio dell’attività; della sospensione o della revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; del divieto di contrattare con la p.a.; dell’esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi; del divieto di pubblicizzare beni o servizi);pubblicazione della sentenza.Le prime due sanzioni sono volte ad incidere direttamente sul patrimonio dell’ente, che risponde, secondo il principio della responsabilità patrimoniale di cui all’art. 27 del decreto, con il suo stesso patrimonio o con il fondo comune. Le altre due sanzioni hanno lo scopo di disincentivare la commissione di illeciti da parte degli enti. Le sole sanzioni interdittive possono non essere applicate se, ai sensi dell’articolo 17 del decreto, prima che venga dichiarata l’apertura del dibattimento nel primo grado di giudizio, l’ente dimostra di:aver risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero di essersi efficacemente adoperato in tal senso;aver eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l´adozione e l´attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;aver messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.Editor: dott.ssa Elena Pullano
Continua a leggere
Scritto da:

Egregio Avvocato
Wokefisher
27 set. 2023 • tempo di lettura 4 minuti
Il termine "Wokefisher" è un neologismo che combina due parole: "woke" e "catfisher". Per comprenderlo meglio, è utile comprendere il significato di entrambi questi termini:Woke: "Woke" è un termine slang che deriva dall'inglese afroamericano e che è stato adottato in modo più ampio per descrivere una persona che è socialmente consapevole e attenta alle questioni di giustizia sociale, in particolare legate a questioni come il razzismo, il sessismo, l'omofobia e altre forme di discriminazione. Una persona "woke" è generalmente vista come qualcuno che è impegnato nell'attivismo e nella promozione dell'uguaglianza e della diversità.Catfisher: "Catfish" è un termine usato per descrivere una persona che crea un falso profilo online, spesso con foto e informazioni inventate, per ingannare o trarre in inganno gli altri. Questo termine deriva da un documentario e da una serie televisiva chiamati "Catfish" che esplorano le storie di persone che si sono fatte ingannare da individui che hanno creato identità fittizie online.Quando si parla di "Wokefisher", si fa riferimento a una persona che finge di essere "woke" o socialmente consapevole, ma lo fa in modo disonesto o ipocrita.In altre parole, un "Wokefisher" è qualcuno che adotta una posizione apparentemente progressista o attivista per attirare o manipolare gli altri, ma in realtà non è autentico o impegnato nelle questioni di giustizia sociale.Il termine "Wokefisher" è stato coniato per mettere in evidenza l'ipocrisia di coloro che cercano di apparire socialmente consapevoli o progressisti per guadagnare l'approvazione o l'attenzione degli altri, senza avere un vero impegno verso le questioni di giustizia sociale. Questo termine è spesso utilizzato per criticare le persone che sembrano abbracciare le idee progressiste solo superficialmente o per vantarsi delle loro convinzioni senza un reale coinvolgimento attivo in cause sociali.Il suo comportamento e' sicuramente moralmente discutibile e assolutamente manipolatorio.Di seguito solo alcune delle azioni che un "Wokefisher" potrebbe compiere:Fingere convinzioni sociali per attirare qualcuno: Un "Wokefisher" potrebbe mentire sulle sue convinzioni sociali o politiche per attirare qualcuno in una relazione o amicizia. Ad esempio, potrebbe sostenere di condividere le stesse opinioni politiche o di essere attivamente coinvolto in cause di giustizia sociale solo per guadagnare l'interesse o la simpatia degli altri.Strumentalizzare cause sociali: Un "Wokefisher" potrebbe strumentalizzare cause di giustizia sociale o lotte per i diritti come parte di una strategia per ottenere benefici personali, come guadagnare popolarità, ottenere vantaggi professionali o finanziari, o evitare la critica.Ipercritica o fingerpointing: Potrebbe essere incline a criticare o giudicare gli altri per non essere abbastanza "woke" o consapevoli, mentre lui stesso non vive secondo i valori che proclama. Questo comportamento può essere considerato ipocrita e divisivo.Diffondere disinformazione: Un "Wokefisher" potrebbe diffondere disinformazione o informazioni distorte su questioni di giustizia sociale per promuovere una narrativa che gli conviene, anche se queste informazioni non sono accurate.Tuttavia, il comportamento di un "Wokefisher" può avere conseguenze sociali, come la perdita di fiducia e il danneggiamento delle relazioni personali o professionali e puo' commettere reati o violazioni legali a seconda delle azioni specifiche che compie per fingere o manipolare gli altri.Ecco alcune possibili azioni che un "Wokefisher" potrebbe intraprendere e che potrebbero comportare conseguenze legali:Frode: Se il "Wokefisher" utilizza il suo finto impegno sociale o politico per ottenere denaro, benefici o vantaggi in modo fraudolento, potrebbe essere accusato di frode.Diffamazione: Se diffonde informazioni false o diffamatorie sulle persone o sulle organizzazioni nelle sue simulazioni o manipolazioni, potrebbe essere soggetto a denunce di diffamazione o calunnia, a seconda delle leggi locali.Violazione dei diritti d'autore: Se utilizza materiale protetto da copyright senza autorizzazione per promuovere una falsa immagine di attivismo, potrebbe essere accusato di violazione dei diritti d'autore.Violazione della privacy: Se il "Wokefisher" invade la privacy degli altri raccogliendo informazioni personali o diffondendo informazioni sensibili in modo non autorizzato, potrebbe violare le leggi sulla privacy.Incitamento all'odio: Se il comportamento del "Wokefisher" include la promozione dell'odio, della discriminazione o della violenza nei confronti di determinati gruppi o individui, potrebbe violare leggi antidiscriminazione o essere accusato di incitamento all'odio.È importante notare che le conseguenze legali dipenderanno dalle leggi specifiche del paese o dello stato in cui si verificano le azioni del "Wokefisher" e dalle circostanze specifiche di ciascun caso. In ogni caso, è responsabilità delle autorità legali determinare se un comportamento costituisce un reato e intraprendere le azioni legali appropriate.Prof. Dr. Giovanni MoscagiuroStudio delle Professioni e Scienze forensi e Criminologia dell'Intelligence ed Investigativa Editori e Giornalisti europei in ambito investigativo Diritto Penale , Amministrativo , Tributario , Civile Pubblica Amministrazione , Esperto in Cybercrime , Social Cyber Security , Stalking e Cyberstalking, Bullismo e Cyberbullismo, Cybercrime, Social Crime, Donne vittime di violenza, Criminologia Forense, dell'Intelligence e dell'Investigazione, Diritto Militare, Docente di Diritto Penale e Scienze Forensi, Patrocinatore Stragiudiziale, Mediatore delle liti, Giudice delle Conciliazioni iscritto all'albo del Ministero di Grazia e Giustizia, Editori e Giornalisti European news Agencyemail: studiopenaleassociatovittimein@gmail.com
Continua a leggere
Commenti
Non ci sono commenti



