Il possesso di buona fede

Egregio Avvocato
Pubblicato il 22 mar. 2022 · tempo di lettura 1 minuti
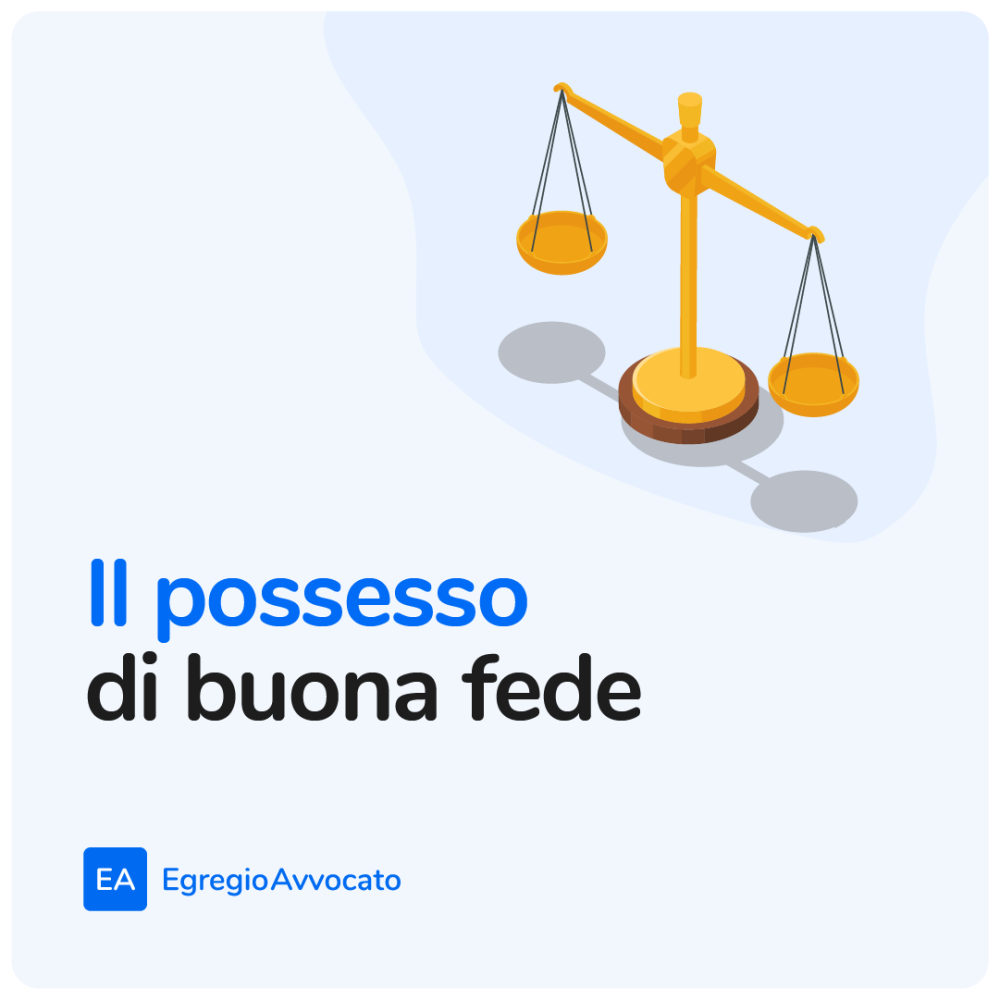
Il Legislatore distingue due tipologie di possessori, a seconda dello stato psicologico in cui versavano al momento dell’acquisto del possesso.
Chi in tale istante ignorava di ledere l’altrui diritto è possessore in buona fede. L’ignoranza dovuta a colpa grave è equiparata a mala fede.
Si discute se il dubbio sia sempre equiparato a mala fede o colpa grave o se, invece, debba equipararsi a scienza o a ignoranza a seconda che il possessore propenda per tenere vera la rappresentazione conforme a realtà, o quella conforme ad errore.
Per l’ordinamento, il possesso può essere di buona fede anche se non si appoggia ad alcun titolo.
Non è sempre stato approfondito dagli autori il preciso significato della formula “scienza della lesione di un altrui diritto”.
Quando il possessore sappia che il proprio titolo è affetto da un vizio, ci si domanda se la mala fede sia la scienza del vizio o la concreta previsione del futuro annullamento ( come nel caso della conoscenza dell’errore, della sua essenzialità, della sua riconoscibilità , e previsione che l’errante chiederà l’annullamento) o la conoscenza di quell’elemento della fattispecie che cagiona un potenziale pregiudizio al soggetto che ha posto in essere il titolo.
Condividi:
Il possesso di buona fede
Pubblicato da:

Egregio Avvocato
Articoli che potrebbero interessarti
Il divieto di aggressione tra stati
11 mar. 2022 • tempo di lettura 2 minuti
Il crimine di aggressione è incluso tra i crimini internazionali nello Statuto di Roma della Corte penale internazionale. Infatti, l’art. 5.1 prevede che la Corte ha giurisdizione, oltre ai reati di: genocidio; i vari crimini contro l’umanità; dei crimini di guerra e sul crimine di aggressione.A differenza degli altri, non si trovò un accordo immediato sulla definizione di crimine di aggressione e, dunque, venne stabilito che la Corte avrebbe potuto esercitare la sua giurisdizione solo dopo aver individuato la definizione e i criteri necessari per potervi ricorrere. Nel 2010 a seguito della Conferenza di revisione dello Statuto, si sono apportate modifiche notevoli, trovandosi un accordo sulla definizione di “crimine di aggressione”. Tale espressione indica “la pianificazione, la preparazione, l’inizio o l’esecuzione, da parte di una persona in grado di esercitare effettivamente il controllo o di dirigere l’azione politica o militare di uno Stato, di un atto di aggressione che, per il suo carattere, gravità e portata, costituisce una manifesta violazione della Carta delle Nazioni Unite.” Da sempre il diritto internazionale ha mostrato una posizione di notevole importanza al concetto di aggressione. Sin dalla Convenzione della Società delle Nazioni (1919), il concetto di aggressione esterna contro territori esterni, ricorre in diversi accordi e convenzioni, ma è in occasione del processo di Norimberga che se ne tratteggiano le caratteristiche per la prima volta. Successivamente, nei primi anni del 2000, il concetto di aggressione acquista una identità specifica e differenziata rispetto ai vari crimini presenti nel panorama internazionale.Si è espresso con forza la proibizione dell’uso della forza nel diritto internazionale, ricomprendendo anche l’atto di aggressione, dovendosi distinguere tra il concetto di “atto di aggressione” e “crimine di aggressione”. Per quel che riguarda il primo esso s’inquadra “nell’uso della forza armata da parte di uno Stato contro la sovranità, l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di un altro Stato, o in qualunque altro modo contrario alla Carta delle Nazioni Unite”. Per il secondo, invece, si ritiene che non debba essere riportato sempre ad un crimine di aggressione; ma, anzi, vari atti di aggressione; quindi, per natura esercitati dallo Stato, non possono essere considerati contemporaneamente crimini internazionali dell’individuo.
Continua a leggere
Scritto da:

Egregio Avvocato
Il giudizio immediato
8 mar. 2022 • tempo di lettura 2 minuti
Uno dei procedimenti speciali previsto dal c.p.p. è il cd. giudizio immediato, il quale sacrifica il controllo giurisdizionale sulla necessità del rinvio a giudizio: non prevede lo svolgimento dell’udienza preliminare, e dalle indagini preliminari si transita direttamente all’udienza dibattimentale.Può essere richiesto sia dall’imputato sia dal Pubblico ministero. Nel primo caso, l’imputato può avanzare richiesta di giudizio immediato soltanto dopo che il PM abbia formulato l’imputazione ed il giudice fissato l’udienza preliminare. La richiesta deve essere presentata nella cancelleria del giudice almeno tre giorni prima dell’udienza preliminare e deve essere notificata al PM e alla persona offesa.Il PM, invece, è obbligato ad avanzare richiesta di giudizio immediato nell’ipotesi di evidenza della prova (cd. ipotesi tradizionale), o quando l’imputato si trovi in stato di custodia cautelare (cd. ipotesi custodiale). Il PM è esentato dall’obbligo di avanzare tale richiesta nel caso in cui ciò possa pregiudicare gravemente le indagini.In particolare, nell’ipotesi tradizionale il PM deve chiedere al Gip il rito immediato se vi è l’evidenza della prova; vi è stato interrogatorio dell’indagato; e non sono decorsi più di 90 giorni dall’iscrizione della notizia di reato nel registro ex art. 335 c.p.p.Nell’ipotesi custodiale, invece, i presupposti per la richiesta di giudizio immediato sono: lo stato di custodia cautelare; un determinato grado di stabilità del provvedimento custodiale (es. confermato in sede di riesame); la non decorrenza di 180 giorni dall’esecuzione della misura; la permanenza della valutazione dei gravi indizi per la misura custodiale.Sulla richiesta del PM decide il giudice per le indagini preliminari inaudita altera parte, e quindi sentendo esclusivamente la parte pubblica. Se ritiene sussistenti i presupposti, dispone con decreto il rito immediato e provvede a formare il fascicolo per il dibattimento. Il decreto, non motivato, viene comunicato al PM e notificato all’imputato e alla persona offesa almeno 30 giorni prima della data fissata per l’udienza.
Continua a leggere
Scritto da:

Egregio Avvocato
Cosa è la comunione legale tra i coniugi?
14 nov. 2021 • tempo di lettura 1 minuti
La comunione legale tra i coniugi è uno dei regimi patrimoniali della famiglia, cioè l’insieme delle regole che governa la titolarità dei beni nel corso del matrimonio, individuando quali debbano considerarsi di proprietà di uno solo dei coniugi e quali, invece, di entrambi.Nel caso di comunione legale, la legge prevede che, di regola e salvo alcune categorie di beni escluse dal codice civile, gli acquisti realizzati durante il matrimonio debbano considerarsi appartenenti alla comunione legale, a cui entrambi i coniugi partecipano in pari misura.A partire dalla riforma del diritto di famiglia del 1975, la comunione legale è il regime “ordinario”, che si applica nei casi in cui i coniugi non scelgano espressamente un regime diverso – come quello della separazione dei beni o di una comunione convenzionale.Tale impostazione era ispirata a diverse ragioni, inclusa quella di tutelare il c.d. coniuge debole, cioè quello che non percepisce un proprio reddito o ne percepisce uno inferiore, (situazione molto ricorrente ai tempi della riforma) e garantire una perequazione delle risorse familiari, realizzate grazie all’impegno profuso da entrambi i coniugi, ancorché attraverso attività diverse. Resta comunque sempre possibile optare per un regime diverso, anche nel corso del matrimonio, stipulando una convenzione da annotare a margine dell’atto di matrimonio.
Continua a leggere
Scritto da:

Egregio Avvocato
Cosa è la ricognizione?
17 dic. 2021 • tempo di lettura 2 minuti
La ricognizione è un mezzo di prova mediante il quale, ad una persona che abbia percepito con i propri sensi una persona o una cosa, si chiede di riconoscerla individuandola tra altre simili. Momento fondamentale nello svolgimento della ricognizione, soprattutto di persone, è la cd. predisposizione della scena. In assenza di colui che è chiamato ad effettuare il riconoscimento, il giudice dispone che siano presenti almeno altre due persone (definite come distrattori), che siano il più possibile somiglianti “anche nell’abbigliamento” a quella sottoposta a ricognizione. Quest’ultima è invitata a scegliere il proprio posto rispetto alle altre persone, curando che si presenti, ove possibile, nelle stesse condizioni nelle quali sarebbe stata vista dalla persona chiamata ad operare il riconoscimento. Solo quando la scena è pronta, potrà entrare colui che deve effettuare il riconoscimento, il quale dovrà quindi indicare il soggetto che ritiene essere la persona alla quale il reato è attribuito. Molto spesso la ricognizione avviene in giudizio mediante degli album fotografici predisposti dalla Polizia di Stato, i quali riportano una serie di foto di soggetti tendenzialmente simili tra loro e a ognuno dei quali è riconosciuto un numero. Solo alla fine dell’album sarà indicata anche la cd. legenda, ove ogni numero corrisponde al nome del soggetto in foto. Il soggetto chiamato ad effettuare la ricognizione dovrà quindi indicare il numero che corrisponde alla foto della persona che ritiene autore del reato, e sarà poi il giudice ad associare quel numero al nome. Può accadere anche che, nel corso della deposizione dibattimentale, al testimone sia chiesto se riconosce tra i presenti in aula la persona alla quale il reato è attribuito. In questo caso, sembrerebbe che la testimonianza fornisca lo stesso risultato che si sarebbe ottenuto mediante una ricognizione vera e propria, senza però avere le formalità che invece sono richieste per la ricognizione. La giurisprudenza sostiene che si tratti di una cd ricognizione informale, che si possa considerare come prova atipica e come tale utilizzabile. La dottrina obietta, però, che le formalità della ricognizione sono poste a tutela dell’attendibilità del risultato e che un riconoscimento effettuato in dibattimento, nel corso dell’esame incrociato e senza la presenza di distrattori, sia una prova che aggira le garanzie richieste dal c.p.p. e che fornisce un risultato non attendibile.
Continua a leggere
Scritto da:

Egregio Avvocato
Commenti
Non ci sono commenti


