Reati con soglie di punibilità: si può applicare l’art. 131 bis c.p.?

Egregio Avvocato
Pubblicato il 31 gen. 2022 · tempo di lettura 1 minuti
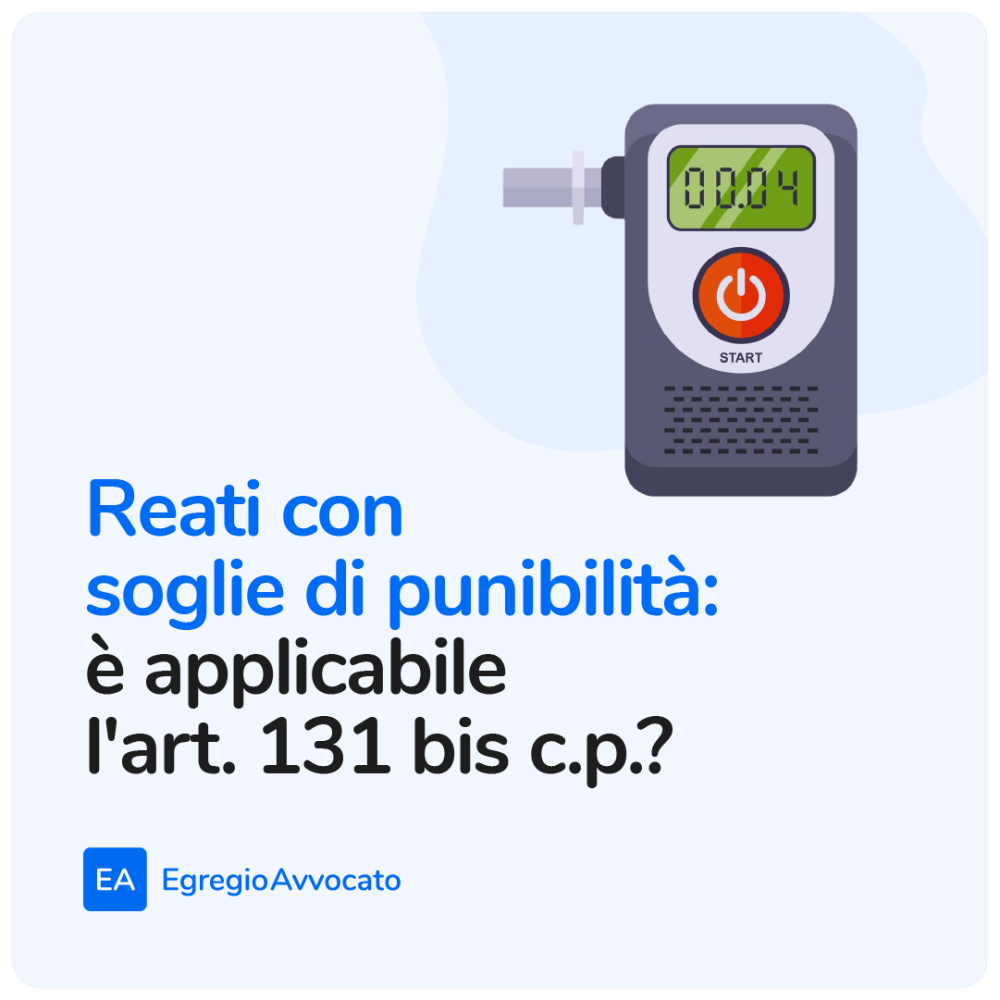
L’art. 131 bis c.p. prevede che in caso di reato con offesa particolarmente tenue, il soggetto agente, a date condizioni, non viene punito. I presupposti che devono sussistere sono tre: pena detentiva non superiore a 5 anni; modalità della condotta; esiguità del danno o del pericolo.
Ci si chiede se tale norma possa applicarsi a quei fatti che costituiscono reato solo al superamento di una certa soglia: es. guida in stato di ebbrezza (0,8 a 1,5 e poi sopra 1,5); art. 316-ter co. 2 c.p. (al di sotto di 3999,98 euro il fatto sarà solo illecito amministrativo).
Secondo una prima tesi, la risposta è negativa: se si potesse applicare il 131 bis c.p., il giudice si andrebbe a sostituire al legislatore, il quale ha previsto esplicitamente una soglia e quindi ha preso una posizione netta su quando un fatto è penalmente rilevante o meno. Inoltre, in questi casi vi sarebbe un paradosso poiché il soggetto che ha commesso un reato non verrebbe punito né con la sanzione penale, ma neanche con quella amministrativa.
Una diversa tesi, invece, sostenuta anche dalla Cassazione a Sezioni Unite, ritiene che l’art. 131 bis c.p. possa trovare applicazione anche nei reati con le soglie di punibilità. Invero, il legislatore, anche quando ha previsto delle soglie, ha operato in astratto, mentre il 131 bis c.p. opera in concreto e sul caso specifico, prendendo in considerazione tutti gli altri elementi del caso. Non sussiste, quindi, una contraddizione tra l’esistenza della soglia e l’applicazione del 131 bis c.p.
Condividi:
Reati con soglie di punibilità: si può applicare l’art. 131 bis c.p.?
Pubblicato da:

Egregio Avvocato
Articoli che potrebbero interessarti
Che succede se si acquista merce contraffatta?
14 nov. 2021 • tempo di lettura 1 minuti
Nel caso di acquisto di merce contraffatta è configurabile la responsabilità non solo per il venditore (autore del reato di contraffazione) ma anche per chi acquista i prodotti.Occorre tuttavia distinguere:1. se chi acquista è consapevole della contraffazione, si configura il reato di ricettazione previsto all’art. 648 c.p., punito con la reclusione da 2 a 8 anni e con la multa da 516 a 10.329 euro;2. se chi acquista è in colpa, perché non verifica la legittima provenienza, nonostante per le circostanze emergessero dubbi sulla provenienza legittima del bene, si integra invece il reato di incauto acquisto di cui all’art. 712c.p., punito con l’arresto fino a 6 mesi o con l’ammenda non inferiore a 10 euro;In entrambi i casi, è esclusa la responsabilità penale se l’acquisto è avvenuto per uso personale. In tal caso si rischia “solo” una sanzione amministrativa pecuniaria (prevista dal D.L. 35 del 2005 e successive modificazioni), da 100,00 fino a 7.000,00 euro.
Continua a leggere
Scritto da:

Egregio Avvocato
Cosa è la ricognizione?
17 dic. 2021 • tempo di lettura 2 minuti
La ricognizione è un mezzo di prova mediante il quale, ad una persona che abbia percepito con i propri sensi una persona o una cosa, si chiede di riconoscerla individuandola tra altre simili. Momento fondamentale nello svolgimento della ricognizione, soprattutto di persone, è la cd. predisposizione della scena. In assenza di colui che è chiamato ad effettuare il riconoscimento, il giudice dispone che siano presenti almeno altre due persone (definite come distrattori), che siano il più possibile somiglianti “anche nell’abbigliamento” a quella sottoposta a ricognizione. Quest’ultima è invitata a scegliere il proprio posto rispetto alle altre persone, curando che si presenti, ove possibile, nelle stesse condizioni nelle quali sarebbe stata vista dalla persona chiamata ad operare il riconoscimento. Solo quando la scena è pronta, potrà entrare colui che deve effettuare il riconoscimento, il quale dovrà quindi indicare il soggetto che ritiene essere la persona alla quale il reato è attribuito. Molto spesso la ricognizione avviene in giudizio mediante degli album fotografici predisposti dalla Polizia di Stato, i quali riportano una serie di foto di soggetti tendenzialmente simili tra loro e a ognuno dei quali è riconosciuto un numero. Solo alla fine dell’album sarà indicata anche la cd. legenda, ove ogni numero corrisponde al nome del soggetto in foto. Il soggetto chiamato ad effettuare la ricognizione dovrà quindi indicare il numero che corrisponde alla foto della persona che ritiene autore del reato, e sarà poi il giudice ad associare quel numero al nome. Può accadere anche che, nel corso della deposizione dibattimentale, al testimone sia chiesto se riconosce tra i presenti in aula la persona alla quale il reato è attribuito. In questo caso, sembrerebbe che la testimonianza fornisca lo stesso risultato che si sarebbe ottenuto mediante una ricognizione vera e propria, senza però avere le formalità che invece sono richieste per la ricognizione. La giurisprudenza sostiene che si tratti di una cd ricognizione informale, che si possa considerare come prova atipica e come tale utilizzabile. La dottrina obietta, però, che le formalità della ricognizione sono poste a tutela dell’attendibilità del risultato e che un riconoscimento effettuato in dibattimento, nel corso dell’esame incrociato e senza la presenza di distrattori, sia una prova che aggira le garanzie richieste dal c.p.p. e che fornisce un risultato non attendibile.
Continua a leggere
Scritto da:

Egregio Avvocato
L’elezione del Presidente della Repubblica
25 gen. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune, integrata dai delegati regionali eletti dai rispettivi Consigli regionali, in modo da avere la rappresentanza delle minoranze. La presenza dei delegati regionali ha lo scopo di rafforzare la caratterizzazione del Presidente della Repubblica come rappresentante dell’unità nazionale.I requisiti per essere eletto Presidente della Repubblica sono indicati dall’art. 84 della Costituzione: la cittadinanza italiana; il compimento del cinquantesimo anno di età ed il godimento dei diritti civili e politici.All’elezione si procede per iniziativa del Presidente della Camera che, 30 giorni prima della scadenza del mandato presidenziale, convoca il Parlamento in seduta comune e i delegati regionali per l’elezione del nuovo Presidente.L’elezione del Presidente della Repubblica avviene a scrutinio segreto e con la maggioranza dei 2/3 dell’Assemblea; dopo il terzo scrutinio, è richiesta la sola maggioranza assoluta, cioè il voto favorevole della metà più uno degli aventi diritto al voto. Il quorum elevato è volto ad evitare che la nomina del Presidente sia espressione della sola maggioranza politica. Una volta eletto, il Presidente della Repubblica, prima di essere immesso nell’esercizio delle sue funzioni, presta giuramento di fedeltà di fronte al Parlamento in seduta comune, accompagnato, per prassi, da un breve discorso, nel quale il Presidente eletto illustra i principi a cui tende ispirare le proprie funzioni. Il mandato presidenziale decorre dalla data del giuramento e dura per un periodo di sette anni. Durante il mandato il Presidente della Repubblica dispone di un assegno personale e di una dotazione (quali la residenza del PdR e per gli uffici presidenziali, a cui si aggiunge un assegno periodico) ed è posta alle dipendenze esclusive una struttura amministrativa, chiamata Segretariato generale della Presidenza della repubblica.
Continua a leggere
Scritto da:

Egregio Avvocato
Cosa è la connivenza? È punibile?
17 nov. 2021 • tempo di lettura 1 minuti
La connivenza è quel comportamento per il quale un soggetto ha la consapevolezza che qualcun altro sta per commettere un reato, ma non fa nulla per impedirlo. Il soggetto connivente rimane quindi inerte e non interviene, pur sapendo che sta per perpetrarsi un reato. Ad esempio, io so che il mio migliore amico sta per commettere un furto, e non faccio nulla per fermarlo.Di regola, la connivenza – e quindi la totale inerzia del soggetto consapevole – non è punibile nell’ordinamento giuridico italiano. Non esiste, infatti, nel nostro sistema una norma giuridica che preveda un obbligo incombente sui comuni cittadini di impedire il verificarsi di reati da parte di altri soggetti. L’unico caso in cui il soggetto che non interviene può essere punito è il caso in cui incomba su di lui un obbligo giuridico di impedire l’evento (i.e. la commissione del reato), e quindi, a fronte della qualifica assunta, riveste una posizione di garanzia: ciò è quanto avviene, ad esempio, per i pubblici ufficiali. Se il soggetto riveste tale posizione di garanzia, e non impedisce un evento che ha l’obbligo giuridico di impedire, dovrà rispondere di concorso omissivo nell’altrui delitto commissivo.
Continua a leggere
Scritto da:

Egregio Avvocato
Commenti
Non ci sono commenti


