Sostanze stupefacenti e uso personale: cosa cambia tra coltivazione e detenzione?

Egregio Avvocato
Pubblicato il 14 nov. 2021 · tempo di lettura 1 minuti
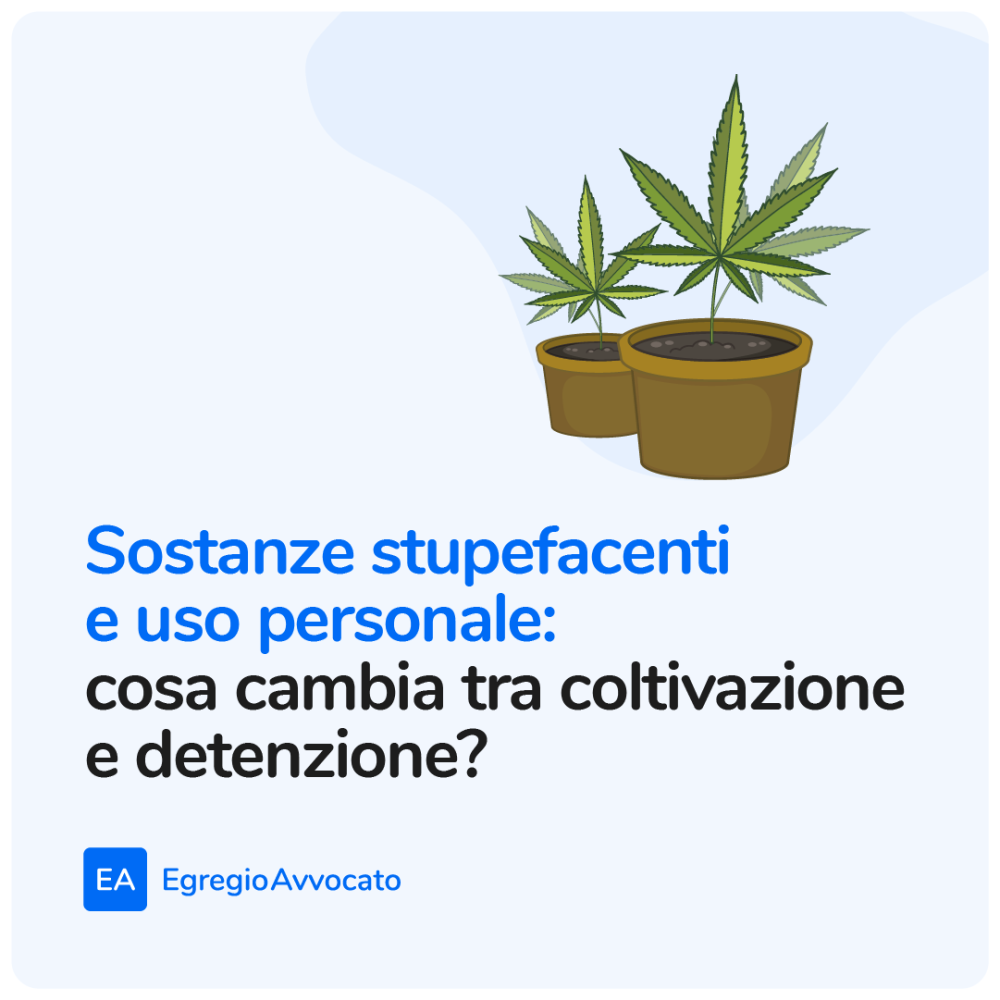
Molteplici sono le condotte che assumono rilevanza penale alla luce del Testo Unico stupefacenti (n. 309/90). Tuttavia, nel caso in cui tali condotte siano poste in essere per uso personale (e quindi a fini domestici), il legislatore ha ritenuto di prevedere una disciplina estranea al diritto penale.
Tra la coltivazione e la detenzione di sostanze stupefacenti, la differenza sta nel fatto che nel primo caso la sostanza drogante non è ancora venuta ad esistenza, mentre nel secondo caso è già esistente e strettamente collegata all’uso (non posso farne uso, se non la detengo).
La detenzione per uso personale viene presa in considerazione dall’art. 75 TU stupefacenti, secondo il quale la condotta integra un illecito amministrativo.
In merito alla coltivazione per uso personale, invece, una recente sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 12348/2020) ha stravolto l’orientamento tradizionale e ha evidenziato come tale condotta non debba avere alcun tipo di rilevanza – né penale, né amministrativa. Ciò alla luce del principio di offensività: la mera coltivazione domestica, avente determinate caratteristiche, non è idonea ad offendere il bene giuridico. Mancando l’offesa, infatti, manca il reato.
Verrà applicata, quindi, la sanzione amministrativa solo nel caso in cui sia integrata la condotta di detenzione per uso personale; non potendo essere applicata alcuna sanzione nel caso di coltivazione per uso personale
Condividi:
Sostanze stupefacenti e uso personale: cosa cambia tra coltivazione e detenzione?
Pubblicato da:

Egregio Avvocato
Articoli che potrebbero interessarti
Come si diventa cittadini italiani?
28 mar. 2022 • tempo di lettura 4 minuti
Ogni Stato adotta criteri propri per l’attribuzione e la perdita della cittadinanza. Per quanto riguarda l’Italia, la legge 5 febbraio 1992, n.91 prevede quattro criteri di attribuzione della cittadinanza italiana: per nascita; per matrimonio; per beneficio di legge; per naturalizzazione.Acquisto della cittadinanza italiana per nascitaAcquisto della cittadinanza italiana per matrimonioAcquisto della cittadinanza italiana per naturalizzazioneAcquisto della cittadinanza italiana per beneficio di leggeCome presentare la domanda1 - Acquisto della cittadinanza italiana per nascitaL’art. 1 l. 91/1992 prevede quattro ipotesi di acquisto della cittadinanza per nascita.a) l’acquisto iure sanguinis: è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini italiani. Più in particolare, il possesso della cittadinanza italiana per nascita si trasmette di genitore in figlio, indipendentemente dal luogo di nascita: è cittadino italiano il figlio di padre o madre cittadini italiani, anche se nato all’estero, purché venga trascritto l’atto di nascita nei registri dello Stato Civile. b) l’acquisto iure soli: è considerato cittadino italiano per nascita chi è nato nel territorio dello Stato da genitori ignoti o apolidi.c) l’acquisto ius soli residuale: è considerato cittadino per nascita anche il figlio di ignoti che sia trovato nel territorio italiano, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.d) l’acquisto giudiziale: diventa cittadino italiano il figlio a seguito del riconoscimento o della dichiarazione giudiziale della filiazione, purché avvenuti durante la minore età. e) in caso di adozione di minorenne.2 - Acquisto della cittadinanza italiana per matrimonioL’acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio è riconosciuto al cittadino straniero, o apolide, sposato con il coniuge cittadino italiano che possiede i requisiti previsti dagli artt. 5 e 6 l. 91/1992.In primo luogo, il cittadino straniero deve essere residente in Italia da almeno due anni dopo la data del matrimonio. Se è stato residente all’estero, devono passare almeno tre anni dopo la data del matrimonio. Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.In secondo luogo, non deve essere intervenuta sentenza di scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell’unione civile.Ancora, il cittadino straniero deve certificare la conoscenza della lingua italiana (livello b1).Infine, il richiedente non deve aver riportato condanne penali né essere stato dichiarato pericoloso socialmente.3 - Acquisto della cittadinanza italiana per naturalizzazioneLo straniero può ottenere la cittadinanza italiana anche per effetto della residenza, nel territorio italiano, per un periodo definito di tempo. Il periodo di residenza in Italia è pari a 10 anni per i cittadini extracomunitari e a 4 anni per i cittadini dell’Unione Europea. È indispensabile dimostrare la presenza in Italia con la documentazione relativa alla propria iscrizione all’anagrafe.Sono necessari ulteriori requisiti: la conoscenza della lingua italiana (pari a livello b1), l’assenza di condanne penali nonché un reddito minimo, pari a 8.263,31 euro per richiedenti senza persone a carico e a 11.362,05 euro per richiedenti con coniuge a carico (aumentabili di 516,00 euro per ogni ulteriore persona a carico).4 - Acquisto della cittadinanza italiana per beneficio di leggeL’art. 4 l. 91/1992 prevede ulteriori casi di acquisto della cittadinanza italiana. Fra questi, diviene cittadino lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dal diciottesimo compleanno.Inoltre, lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino:a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;c) se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.5 - Come presentare la domandaLo straniero può presentare la domanda di concessione della cittadinanza italiana esclusivamente per via telematica, attraverso il sito www.portaleservizi.dlci.interno.it. Dopo essersi registrato, il richiedente dovrà compilare telematicamente il modulo di domanda, indicare nell'apposito spazio gli estremi della marca da bollo e allegare in formato elettronico tutta la documentazione richiesta.Terminata la procedura, al cittadino straniero richiedente viene rilasciato il numero della pratica che gli servirà poi a rintracciare lo stato di avanzamento della richiesta sul portale dedicato e viene attivata l'istruttoria.Dopo aver presentato la domanda, collegandosi al portale lo straniero potrà visualizzare tutte le comunicazioni a lui inviate dalla Prefettura concernenti l'avvenuta accettazione della sua domanda e l'avvio del procedimento nonchè l'eventuale irregolarità della documentazione allegata.A partire dal dicembre 2020, è stato dimezzato il termine di durata massima dei procedimenti di cittadinanza italiana: il Ministero dell’Interno ha, oggi, 24 mesi di tempo prorogabili fino ad un massimo di 3 anni per emettere la decisione, positiva o negativa.Editor: dott.ssa Elena Pullano
Continua a leggere
Scritto da:

Egregio Avvocato
Qual è la differenza tra la Corte di Giustizia e la Corte Europea dei diritti dell'Uomo (c.d. Corte EDU)?
16 feb. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Le due corti, note anche come Corte di Lussemburgo e di Strasburgo in virtù della rispettiva sede, sono due organi differenti e del tutto autonomi.La Corte di Giustizia è l’istituzione che svolge funzioni di natura giurisdizionale nel sistema dell’Unione Europea, esercitando competenze di tipo contenzioso rispetto ai ricorsi per infrazione, di annullamento, in carenza e per risarcimento, nonché pronunciandosi in via pregiudiziale sull’interpretazione dei trattati e sulla validità e l’interpretazione degli atti delle istituzioni, degli organi o organismi dell’Unione. Anche le singole persone fisiche o giuridiche possono adire in alcuni casi la Corte, ad esempio esperendo ricorso per annullamento contro gli atti (legislativi o comunque di una istituzione dell’UE) adottati nei loro confronti o loro riguardanti direttamente e individualmente, ancorché a tal fine debbano essere soddisfatte peculiari condizioni (sono in tal senso considerati ricorrenti “non privilegiati”).La Corte svolge anche funzioni consultive, quando deve rendere pareri (ad es. in caso di accordi internazionali dell’UE).La Corte EDU, invece, è stata istituita dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (la CEDU), firmata a Roma nel 1950 e promossa dal Consiglio d’Europa, un’organizzazione internazionale fondata sul metodo della cooperazione intergovernativa. Quest’ultima, a sua volta, deve essere tenuta distinta dal Consiglio Europeo e dal Consiglio dell’Unione, organi ricompresi nel quadro delle istituzioni dell’Unione Europea.La Corte EDU si occupa di garantire il rispetto della Convenzione da parte degli Stati contraenti. Essa può essere adita anche dalle persone fisiche per l’accertamento delle violazioni dei diritti tutelati dalla CEDU o dei suoi protocolli da parte dello Stato aderente alla Convenzione, nel rispetto delle condizioni previste dalla CEDU stessa.
Continua a leggere
Scritto da:

Egregio Avvocato
L’organismo di diritto pubblico
6 mag. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Si tratta di una figura nuova per l’ordinamento italiano, che deriva dall’ordinamento comunitario e nasce grazie alla nuova nozione funzionale della PA: l’ente pubblico può essere funzionale e cangiante; e quindi anche gli enti privati possono essere considerati enti pubblici a certi fini, rimanendo privati per altri. L’organismo di diritto pubblico è un soggetto ibrido, individuato sulla base di dati sostanziali – può avere anche forma privatistica (anche società), e in virtù di determinate caratteristiche viene considerato alla stregua di una PA per il contratto di appalto, con la conseguenza di avere l’obbligo di fare la gara per la scelta del contraente, e quindi di dovere applicare la procedura ad evidenza pubblica del codice appalti.Le tre caratteristiche sostanziali per riconoscere l’organismo di diritto pubblico sono:Personalità giuridicaInfluenza dominante dello Stato o altro ente pubblicoRequisito teleologicoIn particolare, il requisito teleologico viene considerato come l’elemento determinante: deve perseguire bisogni di interesse generale, non aventi carattere industriale o commerciale. È una formula che sembra comporsi di due elementi, uno positivo (perseguimento di bisogni di interesse generale) e uno negativo (non aventi carattere industriale o commerciale). Si tratta di attività svolte senza reale rischio di impresa: non si ha il pungolo di scegliere il meglio; non si rischia di fallire; e quindi la formazione della volontà negoziale deve necessariamente essere guidato mediante la procedura ad evidenza pubblica – se lasciati liberi di agire potrebbero scegliere secondo criteri non concorrenziali, compiendo scelte anche discriminatorie.
Continua a leggere
Scritto da:

Egregio Avvocato
Che succede se si acquista merce contraffatta?
14 nov. 2021 • tempo di lettura 1 minuti
Nel caso di acquisto di merce contraffatta è configurabile la responsabilità non solo per il venditore (autore del reato di contraffazione) ma anche per chi acquista i prodotti.Occorre tuttavia distinguere:1. se chi acquista è consapevole della contraffazione, si configura il reato di ricettazione previsto all’art. 648 c.p., punito con la reclusione da 2 a 8 anni e con la multa da 516 a 10.329 euro;2. se chi acquista è in colpa, perché non verifica la legittima provenienza, nonostante per le circostanze emergessero dubbi sulla provenienza legittima del bene, si integra invece il reato di incauto acquisto di cui all’art. 712c.p., punito con l’arresto fino a 6 mesi o con l’ammenda non inferiore a 10 euro;In entrambi i casi, è esclusa la responsabilità penale se l’acquisto è avvenuto per uso personale. In tal caso si rischia “solo” una sanzione amministrativa pecuniaria (prevista dal D.L. 35 del 2005 e successive modificazioni), da 100,00 fino a 7.000,00 euro.
Continua a leggere
Scritto da:

Egregio Avvocato
Commenti
Non ci sono commenti


