La libertà sindacale e il diritto di sciopero

Egregio Avvocato
Pubblicato il 8 feb. 2022 · tempo di lettura 1 minuti
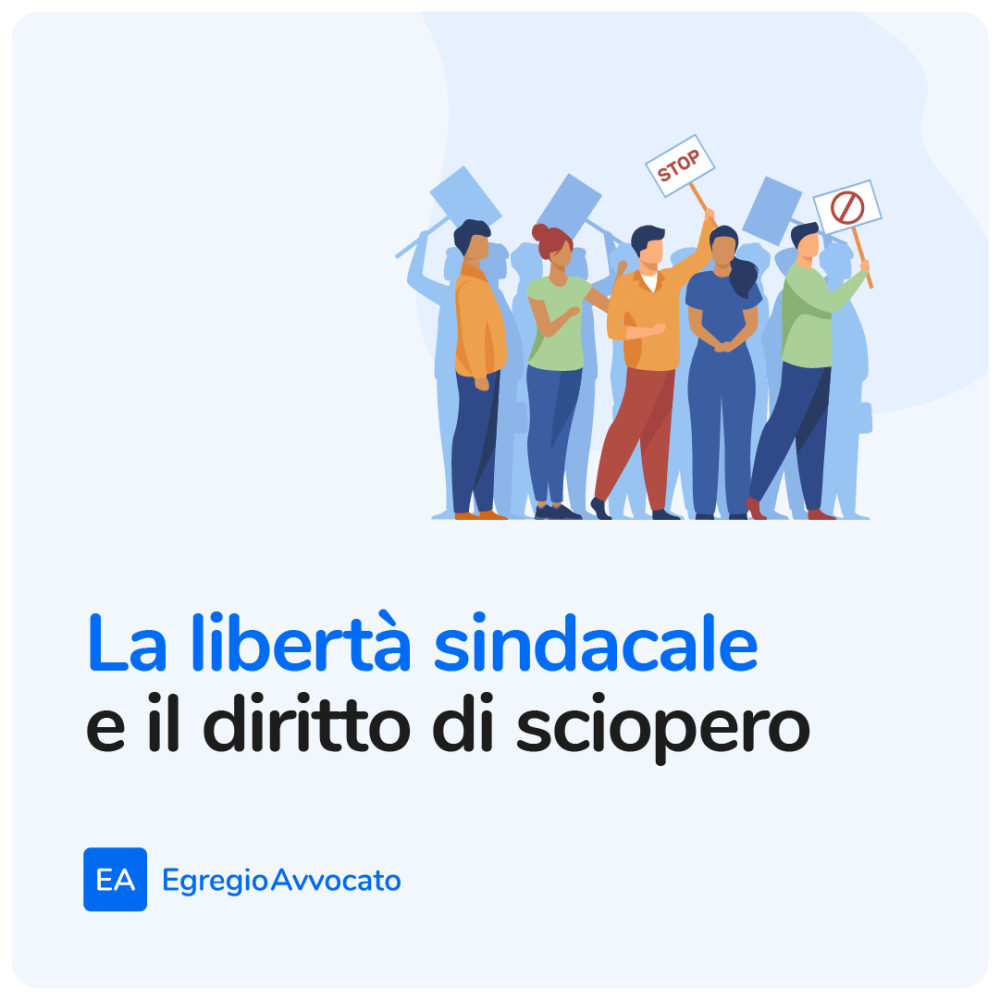
L’art. 39 della Costituzione, che regolamenta l’organizzazione sindacale, non è stato mai applicato nel nostro ordinamento, salvo il primo comma che sancisce la libertà di organizzazione sindacale.
La Costituzione, infatti, prefigura un modello specifico di organizzazione sindacale, che ricorda lontanamente le corporazioni del periodo fascista: ovvero un sindacato che viene registrato, acquista la personalità giuridica e può entrare in rappresentanze unitarie che stipulano contratti collettivi di lavoro con efficacia normativa, poiché vincolanti per tutti gli appartenenti alla categoria.
I sindacati però si sono sempre rifiutati di dare attuazione alla norma. Pertanto, gli attuali sindacati sono semplici associazioni di diritto privato e i contratti che stipulano non sono fonti dell’ordinamento generale, ma hanno valore vincolante solo per i soggetti contraenti e per i loro iscritti.
Lo sciopero è la sospensione collettiva temporanea delle prestazioni di lavoro rivolta alla tutela di un particolare interesse dei lavoratori: è un diritto riconosciuto e, infatti, chi sciopera non può subire conseguenze negative sul piano penale, civile o disciplinare (a parte la sospensione della retribuzione).
Lo sciopero tutelato dall’art. 40 Cost., però, è solo quello che i lavoratori dipendenti attuano per interessi, anche non economici, di categoria, e non anche quello politico o quello attuato dai datori di lavoro (c.d. serrata) o dai liberi professionisti. Tuttavia anche queste manifestazioni sono libere e consentite, anche se non dall’art. 40 Cost., attraverso altre libertà costituzionalmente garantite, come quella di riunione.
L’art. 40 Cost., rinvia alle leggi la regolazione e i limiti del diritto di sciopero.
Ma anche questa disposizione è priva di attuazione, in quanto non è mai stata approvata una disciplina generale del diritto di sciopero: esiste solo la disciplina del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, con la L. 146/1990, cioè la sanità, la giustizia, i trasporti pubblici e così via, nei quali devono comunque essere garantite le prestazioni indispensabili.
Condividi:
La libertà sindacale e il diritto di sciopero
Pubblicato da:

Egregio Avvocato
Articoli che potrebbero interessarti
Amnistia e indulto: le differenze
16 feb. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
L'amnistia e l'indulto sono due istituti per certi versi analoghi, ma che presentano tra loro delle differenze sostanziali. Si tratta di istituti conosciuti dalla Costituzione all’art. 79, nel quale è previsto che entrambi i provvedimenti devono essere deliberati con larga maggioranza parlamentare e, precisamente, con due terzi dei componenti di ogni Camera. Tale maggioranza è prevista al fine di ricercare una larga condivisione per la decisione di perdonare determinati reati ed evitare abusi nell’adozione di tali istituti. Entrambi i tipi di provvedimenti hanno efficacia retroattiva, ma, per espressa previsione costituzionale, non possono essere applicati con riferimento a reati commessi dopo la presentazione del disegno di legge alle Camere.La principale differenza tra i due istituti in esame consta nel fatto che l’amnistia estingue il reato, mentre l’indulto estingue solo la pena. Con l'amnistia, in genere, si cerca di stemperare eventuali tensioni all'interno del Paese per mantenere una situazione di armonia all'interno della società (cd. pacificazione sociale). L’amnistia ha causa di clemenza ed è giustificata dalla presenza di situazioni oggettivamente eccezionali e per certi versi irripetibili. L'indulto, invece, è maggiormente mirato a contrastare il fenomeno del sovraffollamento carcerario; essendo una causa di estinzione della pena opera soltanto sulla pena concretamente inflitta al soggetto, non aggredendo il reato nella sua interezza che invece continuerà a produrre quegli effetti che può ancora esplicare.
Continua a leggere
Scritto da:

Egregio Avvocato
Il divieto di aggressione tra stati
11 mar. 2022 • tempo di lettura 2 minuti
Il crimine di aggressione è incluso tra i crimini internazionali nello Statuto di Roma della Corte penale internazionale. Infatti, l’art. 5.1 prevede che la Corte ha giurisdizione, oltre ai reati di: genocidio; i vari crimini contro l’umanità; dei crimini di guerra e sul crimine di aggressione.A differenza degli altri, non si trovò un accordo immediato sulla definizione di crimine di aggressione e, dunque, venne stabilito che la Corte avrebbe potuto esercitare la sua giurisdizione solo dopo aver individuato la definizione e i criteri necessari per potervi ricorrere. Nel 2010 a seguito della Conferenza di revisione dello Statuto, si sono apportate modifiche notevoli, trovandosi un accordo sulla definizione di “crimine di aggressione”. Tale espressione indica “la pianificazione, la preparazione, l’inizio o l’esecuzione, da parte di una persona in grado di esercitare effettivamente il controllo o di dirigere l’azione politica o militare di uno Stato, di un atto di aggressione che, per il suo carattere, gravità e portata, costituisce una manifesta violazione della Carta delle Nazioni Unite.” Da sempre il diritto internazionale ha mostrato una posizione di notevole importanza al concetto di aggressione. Sin dalla Convenzione della Società delle Nazioni (1919), il concetto di aggressione esterna contro territori esterni, ricorre in diversi accordi e convenzioni, ma è in occasione del processo di Norimberga che se ne tratteggiano le caratteristiche per la prima volta. Successivamente, nei primi anni del 2000, il concetto di aggressione acquista una identità specifica e differenziata rispetto ai vari crimini presenti nel panorama internazionale.Si è espresso con forza la proibizione dell’uso della forza nel diritto internazionale, ricomprendendo anche l’atto di aggressione, dovendosi distinguere tra il concetto di “atto di aggressione” e “crimine di aggressione”. Per quel che riguarda il primo esso s’inquadra “nell’uso della forza armata da parte di uno Stato contro la sovranità, l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di un altro Stato, o in qualunque altro modo contrario alla Carta delle Nazioni Unite”. Per il secondo, invece, si ritiene che non debba essere riportato sempre ad un crimine di aggressione; ma, anzi, vari atti di aggressione; quindi, per natura esercitati dallo Stato, non possono essere considerati contemporaneamente crimini internazionali dell’individuo.
Continua a leggere
Scritto da:

Egregio Avvocato
Quali sono le differenze tra riservatezza, reputazione e identità personale?
31 gen. 2022 • tempo di lettura 2 minuti
Il diritto alla riservatezza, alla reputazione e alla propria identità personale appartengono alla categoria dei diritti della personalità, cioè i diritti che attengono al controllo della persona sugli attributi materiali e immateriali, funzionali alla esplicazione della sua personalità.Ancorché siano talvolta considerati equivalenti, essi sono distinguibili perché individuano e tutelano aspetti diversi della personalità dell’individuo.Il diritto alla riservatezza si definisce come l’interesse al riserbo su notizie attinenti alla propria vita privata, rispetto alle quali non sussiste un interesse alla conoscenza apprezzabile in capo ai terzi e che il soggetto ha diritto a sottrarre alla conoscenza comune.Per questo, si ritiene che esso abbia un contenuto prevalentemente negativo e si correli di una tutela di tipo oppositivo, rispetto alla divulgazione di informazioni proprie, e di controllo, rispetto alla circolazione di queste informazioni, qualora autorizzata o inevitabile.Il diritto alla reputazione è, invece, l’interesse del soggetto a tutelare non solo il proprio onore, quale valore intrinseco, ma anche la credibilità sociale, cioè il giudizio che la collettività ha della sua persona, anche in relazione alle attività che compie. L’accento è quindi sul giudizio di stima di cui il soggetto gode nella comunità.Il diritto alla identità personale è, invece, il diritto ad essere se stessi e nient’altro che se stessi e a che non venga travisata la propria personalità, complessivamente considerata, né attribuita la paternità di dati o azioni non corretti o non coerenti con il proprio modo d’essere, a prescindere dal fatto che questi siano lesivi o meno. Si tratta di una situazione giuridica che protegge la personalità individuale del soggetto, consolidatasi nel corso del tempo, alla luce delle sue manifestazioni morali, sociali, politiche, intellettuali e professionali. Essa coincide con quella che si è esteriorizzata nel contesto sociale di riferimento e potrebbe finanche non coincidere con quella che il soggetto ha di se stesso.Diversamente dalla riservatezza, qui il diritto si connota positivamente, perché comprende gli elementi che valgono a identificare socialmente il soggetto.
Continua a leggere
Scritto da:

Egregio Avvocato
Reati con soglie di punibilità: si può applicare l’art. 131 bis c.p.?
31 gen. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
L’art. 131 bis c.p. prevede che in caso di reato con offesa particolarmente tenue, il soggetto agente, a date condizioni, non viene punito. I presupposti che devono sussistere sono tre: pena detentiva non superiore a 5 anni; modalità della condotta; esiguità del danno o del pericolo.Ci si chiede se tale norma possa applicarsi a quei fatti che costituiscono reato solo al superamento di una certa soglia: es. guida in stato di ebbrezza (0,8 a 1,5 e poi sopra 1,5); art. 316-ter co. 2 c.p. (al di sotto di 3999,98 euro il fatto sarà solo illecito amministrativo). Secondo una prima tesi, la risposta è negativa: se si potesse applicare il 131 bis c.p., il giudice si andrebbe a sostituire al legislatore, il quale ha previsto esplicitamente una soglia e quindi ha preso una posizione netta su quando un fatto è penalmente rilevante o meno. Inoltre, in questi casi vi sarebbe un paradosso poiché il soggetto che ha commesso un reato non verrebbe punito né con la sanzione penale, ma neanche con quella amministrativa. Una diversa tesi, invece, sostenuta anche dalla Cassazione a Sezioni Unite, ritiene che l’art. 131 bis c.p. possa trovare applicazione anche nei reati con le soglie di punibilità. Invero, il legislatore, anche quando ha previsto delle soglie, ha operato in astratto, mentre il 131 bis c.p. opera in concreto e sul caso specifico, prendendo in considerazione tutti gli altri elementi del caso. Non sussiste, quindi, una contraddizione tra l’esistenza della soglia e l’applicazione del 131 bis c.p.
Continua a leggere
Scritto da:

Egregio Avvocato
Commenti
Non ci sono commenti


