Cosa è l’incidente probatorio?

Egregio Avvocato
Pubblicato il 30 nov. 2021 · tempo di lettura 2 minuti
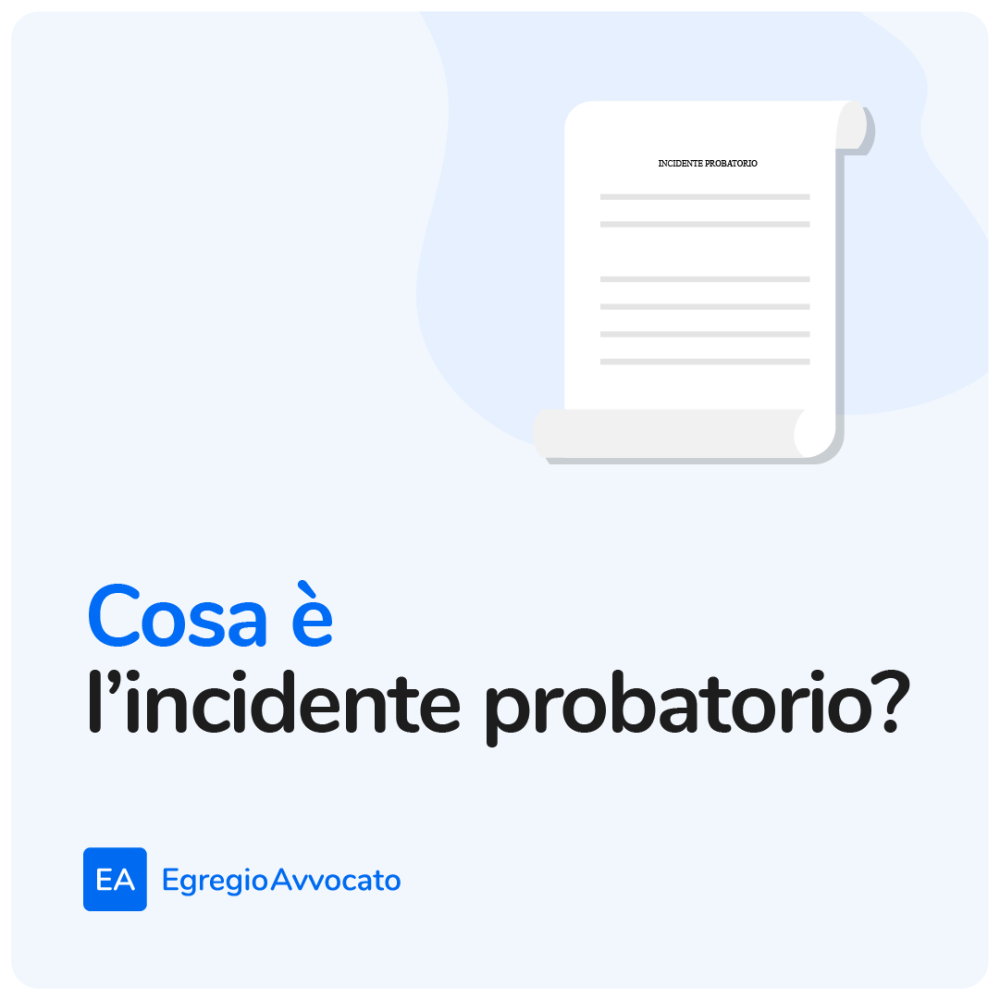
L’incidente probatorio consiste in una udienza che si svolge dinanzi al giudice per le indagini preliminari in camera di consiglio, e quindi senza la presenza del pubblico, e nella quale si assumono le prove non rinviabili al dibattimento (art. 392 c.p.p.) Tali prove sono assunte nelle medesime forme prescritte per il dibattimento; ad esempio, la prova dichiarativa è assunta con l’esame incrociato.
A poter fare richiesta di incidente probatorio sono il pubblico ministero, l’indagato e il suo difensore. La persona offesa non può invece rivolgersi direttamente al giudice, ma può fare richiesta solo mediante il pubblico ministero, il quale valuterà se accogliere o meno l’istanza.
Il codice di procedura penale prevede dei casi tassativi di non rinviabilità della prova all’art. 392 c.p.p., tra cui ricordiamo la testimonianza e il confronto, i quali sono ammessi se il dichiarante non potrà deporre in dibattimento a causa di un grave impedimento (es. infermità) o di una minaccia affinché non deponga o deponga il falso. Vi sono però anche degli altri mezzi di prova che devono essere assunti nell’incidente probatorio sulla base del solo presupposto che il p.m. o l’indagato ne abbiano fatto richiesta al gip, senza che sia necessario il requisito della non rinviabilità né dell’urgenza. Ciò accade, ad esempio, quando si tratta dell’esame del testimone di giustizia (art. 392, co. 1, lett. d).
La funzione dell’incidente probatorio, dunque, è quello di consentire una non dispersione delle prove, e di far salvi anche quei mezzi di prova che altrimenti potrebbero non arrivare in dibattimento. Le prove assunte in sede di incidente probatorio, infatti, hanno lo stesso valore delle prove assunte in dibattimento, e possono essere poste a fondamento della decisione del giudice. Unico limite di utilizzabilità delle prove assunte in sede di incidente probatorio è quello delle prove che siano state assunte senza la partecipazione del difensore dell’imputato, e quindi senza la garanzia del contraddittorio.
Condividi:
Cosa è l’incidente probatorio?
Pubblicato da:

Egregio Avvocato
Articoli che potrebbero interessarti
Cos'è il concordato in appello?
31 gen. 2022 • tempo di lettura 2 minuti
Il concordato in appello è un istituto introdotto dal c.p.p. del 1988, successivamente abrogato e ripristinato dalla Legge Orlando del 2017.Ai sensi del 599-bis c.p.p. è previsto che l’imputato, il Pubblico Ministero e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria possono accordarsi sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri motivi; se i motivi dei quali chiedono l’accoglimento da parte del giudice comportano una nuova determinazione della pena, le parti devono indicare al giudice la pena sulla quale sono d’accordo.Sulla richiesta, la Corte d’Appello decide in camera di consiglio, potendo alternativamente: accogliere il concordato, senza possibilità di modifica; oppure ordinare la citazione a comparire al dibattimento in appello, quando ritiene di non poterlo accettare allo stato degli atti. In questi casi, la richiesta e la rinuncia perdono effetto ma possono essere riproposte durante il dibattimento. Esse non avranno comunque effetto se il giudice dovesse decidere in modo difforme dall’accordo.Si tratta di uno strumento che permette di ridurre notevolmente i tempi dell’appello e risparmiare i tempi del giudizio di cassazione, che non sarebbe in tal caso esperibile.Al pari del patteggiamento, per il concordato sono previste delle preclusioni oggettive (nel senso che il concordato non può farsi in caso di processi inerenti ad alcuni reati indicati dalla legge), e soggettive (nel senso che coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza non possono promuoverlo).Comune è anche l’effetto deflattivo. Tuttavia, si ritiene che il concordato non sia un patteggiamento sulla pena, perché essa è quella che il giudice avrebbe potuto applicare anche senza il consenso del P.M., nel caso in cui avesse accolto il motivo menzionato dall’accordo e respinto gli altri. La nuova pena non è fissata dalla legge e dipende pertanto dai motivi accolti. Inoltre, la sentenza che segue il concordato è una condanna a tutti gli effetti e non sono previsti effetti premiali.
Continua a leggere
Scritto da:

Egregio Avvocato
Differenze: diritto soggettivo e interesse legittimo
16 mar. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Nel diritto amministrativo odierno la differenza tra diritto soggettivo e interesse legittimo ha assunto una rilevanza fondamentale: nel nostro ordinamento vi è un cd. doppio binario di giurisdizione, cioè si ha una giurisdizione ordinaria o una giurisdizione amministrativa a seconda che il privato richieda la tutela dell’uno o dell’altra situazione giuridica soggettiva.In particolare, a differenza di quanto avveniva in precedenza, oggi sia il diritto soggettivo sia l’interesse legittimo sono delle situazioni giuridiche meritevoli di essere tutelate, e l’interesse legittimo non deve essere considerato un quid minus rispetto al diritto soggettivo, ma invece una situazione giuridica soggettiva avente pari dignità. Questo è l’esito di una lunga evoluzione giurisprudenziale, che trova fondamento anche nel fatto che l’art. 24 della Costituzione ponga le due situazioni sullo stesso piano. Tuttavia, qualche differenza comunque permane. Il diritto soggettivo, infatti, gode di una tutela assoluta e incondizionata, che non può essere in alcun modo sacrificata in favore dell’interesse pubblico. La giurisdizione preordinata alla sua tutela è quella ordinaria, e il giudice ordinario possiede il solo potere di disapplicazione del provvedimento amministrativo lesivo (artt. 4 e 5 Laac). L’interesse legittimo, invece, gode di una tutela relativa e condizionata: la Pubblica amministrazione ha il potere di sacrificare l’interesse del privato in favore di un interesse pubblico, e quindi legittimamente di non soddisfare la pretesa del privato. A fronte di un interesse legittimo, la giurisdizione si incardina dinanzi al giudice amministrativo, il quale ha dei poteri più incisivi rispetto al giudice ordinario, prima di tutti quello di annullamento del provvedimento.
Continua a leggere
Scritto da:

Egregio Avvocato
Tentativo circostanziato di delitto e tentativo di delitto circostanziato
31 gen. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Il tentativo circostanziato di delitto è quella fattispecie ove il soggetto agente pone in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un reato, nei quali sia presente in rerum natura una circostanza di reato. Si può fare l’esempio di un soggetto che si reca in banca per commettere una rapina con un’arma, però viene arrestato in flagranza: si ha una tentata rapina e la circostanza dell’uso delle armi sussiste in rerum natura.Il tentativo di delitto circostanziato, invece, è quella fattispecie nella quale la circostanza di reato non esiste nella realtà, ma vi sarebbe stata solo se il reato fosse arrivato a consumazione. Ad esempio, il soggetto agisce per rubare un famosissimo quadro, ma viene arrestato mentre lo sta afferrando: è un tentato furto, e la circostanza del danno ingente non c’è ma ci sarebbe stata solo in caso di consumazione.Mentre l’ammissibilità della prima fattispecie è pacificamente ammessa, la seconda fattispecie, il tentativo di delitto circostanziato, pone maggiori problemi. La dottrina prevalente ritiene non ammissibile tale fattispecie, perché la norma sul tentativo (art. 56 c.p.) si riferisce solo al delitto e non anche alla circostanza. La giurisprudenza a Sezioni Unite, invece, ritiene ammissibile il tentativo di delitto circostanziato per un’esigenza di proporzionalità e ragionevolezza della pena, ma richiede due presupposti: la certezza della verificazione della circostanza in caso di consumazione; e che nel proposito criminoso del soggetto agente rientri anche la sussistenza della circostanza (che, quindi, deve essere oggetto di rappresentazione).
Continua a leggere
Scritto da:

Egregio Avvocato
Il c.d. spoil system negli incarichi dirigenziali della P.a
28 apr. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
L’istituto dello spoil system, caratterizza una parte del personale burocratico come di stretta estrazione fiduciaria, legandone l’ingresso e uscita dall’amministrazione all’avvicendamento dei diversi esecutivi.Quanti eseguono un ufficio in virtù dell’esercizio della prerogativa governativa di assunzione/ nomina discrezionale restano legati all’amministrazione da un rapporto di lavoro segnato geneticamente dalla previsione della sua cessazione al mutare dell’esecutivo.Di una forma di spoils system all’italiana, si è parlato in relazione al comma 8 dell’art. 19 D. lgs. 165/2001. Con specifico riguardo agli incarichi dirigenziali apicali delle amministrazioni statali, le cui funzioni risultano strettamente contigue con gli indirizzi politico- amministrativi espressi dagli organi politici. Tali incarichi apicali cessano automaticamente decorsi 90 giorni dal voto sulla fiducia ottenuto dal Governo subentrante. Non risulta inciso il sottostante rapporto del dirigente di ruolo, scaturente dal contratto a tempo indeterminato stipulato al momento dell’immissione in ruolo.Il meccanismo, quindi coinvolge i dirigenti professionali di ruolo e non comporta la perdita del rapporto di lavoro ma solo quella del temporaneo incarico in corso.A tale previsione va aggiunto il disposto di cui all’art. 14, co. 2 D. lgs. 165/200, secondo cui all’atto del giuramento del ministro, tutte le assegnazioni del personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione: “decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo ministro”.
Continua a leggere
Scritto da:

Egregio Avvocato
Commenti
Non ci sono commenti


