Che differenza c’è tra proscioglimento e assoluzione?

Egregio Avvocato
Pubblicato il 17 nov. 2021 · tempo di lettura 1 minuti
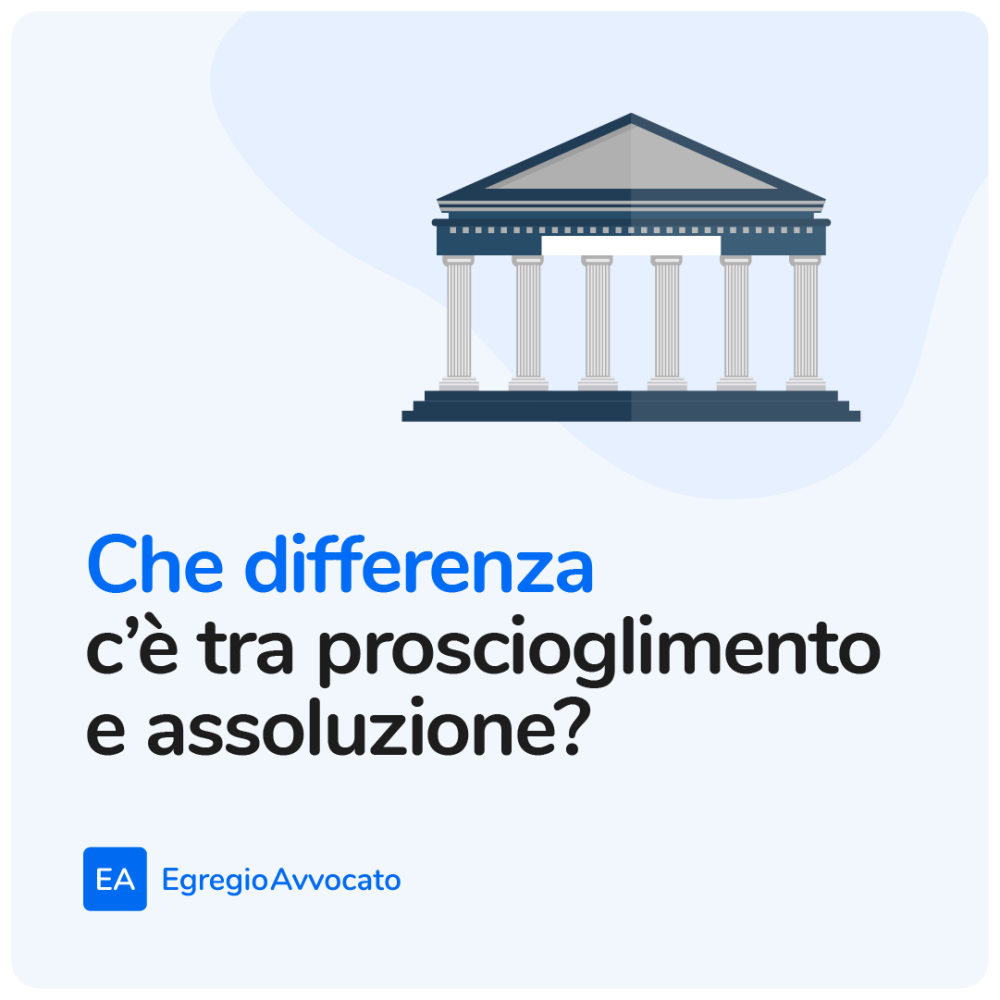
Le sentenze che intervengono all’esito di un processo penale possono ricondursi a due macro categorie: quelle di proscioglimento e quelle di condanna.
Tra le sentenze di proscioglimento è possibile distinguere tra le sentenze di «non doversi procedere» e le sentenze di «assoluzione» (che rappresentano quindi un sottotipo).
La differenza principale sta nel fatto che soltanto quelle di assoluzione contengono un accertamento da parte del giudice, compiuto mediante prove, e come tali sono in grado di fondare l’efficacia del giudicato nei processi civili, amministrativi e disciplinari.
Le sentenze di non doversi procedere, invece, si limitano a statuire su aspetti processuali che impediscono l’accertamento stesso – e come tali sono definite come pronunce “meramente processuali”. Ciò si verifica quando l’azione penale non doveva essere iniziata o proseguita (ad es. perché manda una condizione di procedibilità, come la querela); o quando il reato si è estinto (ad es. perché il reato è prescritto).
Un aspetto formale, comune ad entrambi i tipi di proscioglimento, è che il giudice deve adottare una delle “formule terminative” previste dalla legge, che servono a precisare e sintetizzare la causa della decisione, fungendo anche da sorte di riassunto della motivazione.
Il fatto che solo nel caso di assoluzione vi sia un vero e proprio accertamento nel merito rende tali sentenze più “vantaggiose” rispetto alle altre, anche per l’impatto che esse hanno sull’opinione pubblica.
Per conciliare il possibile interesse dell’imputato a ottenere l’assoluzione nel merito (e non una pronuncia processuale) con le esigenze di economia processuale – che invece imporrebbero di non proseguire il processo in carenza dei presupposti – l’ordinamento prevede il giudice debba pronunciare sentenza di assoluzione quando l’innocenza dell’imputato risulti «evidente dagli atti» disponibili quando si verifica anche il fatto estintivo.
È inoltre sempre possibile per l’imputato rinunciare alla prescrizione del reato ai sensi dell’art. 157 c.p.
Condividi:
Che differenza c’è tra proscioglimento e assoluzione?
Pubblicato da:

Egregio Avvocato
Articoli che potrebbero interessarti
Criminal Profiler
10 ott. 2023 • tempo di lettura 3 minuti
Criminal profilerMa di cosa si occupa precisamente e come lo si diventa?Il piccolo e il grande schermo sono pieni di storie di efferati delitti, i titoli dedicati al mondo dell’investigazione non mancano. In questo contesto una figura professionale presenta al tempo stesso un enorme fascino e un alone di mistero.Il criminal profilerMolti ne hanno sentito parlare, ma pochi saprebbero dire di cosa si occupi e quale sia il suo percorso.Una tecnica investigativa che permette di ricostruire, attraverso le tracce comportamentali, il profilo psicologico di un criminale ancora ignoto.È il tipico caso del serial killer che tutti cercano di acciuffare nelle serie televisive. E infatti, non a caso, i criminal profiler sono tradizionalmente chiamati in causa per i reati reiterati, come gli omicidi o gli stupri seriali, ma anche nei casi di piromania.Una serie di omicidi o una serie di aggressioni sessuali vengono solitamente compiuti sulla spinta di particolari motivazioni o “fantasie”. Queste fanno parte stabilmente dell’universo psicologico dell’assassino. In questi casi quindi è abbastanza probabile ritrovare delle tracce psicologiche di queste fantasie nei crimini commessi.Chi compie questo tipo di crimini soffre in genere di una psicopatologia, anche per questo nella formazione di un criminal profiler le competenze in ambito psicologico sono fondamentali.Nello specifico, il criminal profiler si occupa di diversi aspetti funzionali alla futura cattura del furfante.Analizza il modus operandi del criminale deducendolo dall’analisi della scena del crimine e individua alcune caratteristiche mentali. (L’individuazione di una lista di sospettati è invece compito del personale di polizia).Secondo l’FBI, inoltre, il criminal profiler identifica «le cause della morte, le condizioni psicologiche del carnefice al momento del crimine e le strategie investigative da seguire».La profilazione criminale è una tecnica nata negli Stati Uniti, dove l’FBI ha istituito anni fa un’unità dedicata alle scienze comportamentali (Behavioral Science Unit), poi inglobata nella Behavioral Analysis Unit. Le operazioni di questa unità sono proprio quelle hanno ispirato i romanzi di Thomas Harris, da cui sono stati tratti film quali Il silenzio degli innocenti e Hannibal.Nelle fiction spesso l’assassino viene catturato grazie al profilo psicologico tracciato dall’esperto criminologo di turno.Nella realtà il profilo è uno strumento che sistematizza le informazioni raccolte e aiuta nella ricerca di ulteriori indizi comportamentali.I metodi per stilare il profilo sono diversi: ▪️analisi criminale investigativa▪️approcci statistici▪️approcci clinici▪️l’analisi del comportamentoUn passaggio dell’individuazione del responsabile dei crimini è il linkage, cioè la messa in relazione dei diversi crimini alla ricerca di tratti comuni. È tutt’altro che scontato e lineare riconoscere degli elementi comuni all’interno di più crimini. Ogni singolo caso, infatti, deve comunque e necessariamente essere analizzato a partire dalla sua unicità. Solo in seguito può eventualmente essere ricondotto a una serie di atti criminali di uno stesso autore.Attualmente il criminal profiler viene chiamato in causa essenzialmente per i crimini seriali, che fortunatamente sono molto pochi.In Italia dal 1980 a oggi abbiamo avuto, ad esempio, circa 170 omicidi seriali contro i circa 30.000 omicidi singoli. Ma negli omicidi singoli il numero dei casi irrisolti è piuttosto elevato, attestandosi nel mondo dal 30% al 60% dei crimini avvenuti (percentuale che varia per anno e area geografica).Prof. Dr. Giovanni MoscagiuroStudio delle Professioni e Scienze forensi e Criminologia dell'Intelligence ed Investigativa Editori e Giornalisti europei in ambito investigativoDiritto Penale ,Amministrativo , Tributario , Civile Pubblica Amministrazione , Esperto in Cybercrime , Social Cyber Security , Stalking e Gang Stalking, Cyberstalking, Bullismo e Cyberbullismo, Cybercrime, Social Crime, Donne vittime di violenza, Criminologia Forense, dell'Intelligence e dell'Investigazione, Diritto Militare, Docente di Diritto Penale e Scienze Forensi, Patrocinatore Stragiudiziale, Mediatore delle liti, Giudice delle Conciliazioni iscritto all'albo del Ministero di Grazia e Giustizia, Editori e Giornalisti European news Agency
Continua a leggere
Qual'è la differenza tra difensore d’ufficio e patrocinio a spese dello Stato?
29 gen. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
La difesa d’ufficio è un istituto previsto dall’ordinamento per garantire che vi sia sempre la difesa tecnica dell’imputato, in ogni fase del procedimento in cui serva il suo intervento, qualora l’imputato non abbia ancora nominato un difensore o nel caso in cui ne sia rimasto privo per qualsiasi motivo. A tal fine, è previsto che quando il giudice, il P.M. o la polizia giudiziaria devono compiere un atto per il quale è prevista l’assistenza del difensore, devono chiedere il nominativo di un difensore d’ufficio ad un apposito ufficio presso l’ordine forense di ciascun capoluogo di corte d’appello, attinto da un elenco di avvocati a tal fine predisposto, composto da soggetti che hanno fatto richiesta di iscrizione. Successivamente, viene dato avviso dell’atto che sta per essere compiuto al difensore, il quale ha obbligo di prestare il patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo.Il patrocinio a spese dello Stato consente, invece, di porre a carico dello Stato le spese di assistenza, difesa e rappresentanza delle parti processuali che abbiano un reddito annuo (calcolato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche) non superiore a 11.493,82 euro.Di recente, il patrocinio a spese dello Stato è stato utilizzato anche per provvedere alla difesa di persone ritenute meritevoli di una particolare tutela, quali:le persone offese dai reati di violenza familiare o di genere, in deroga ai limiti di reddito;parimenti, per gli orfani di crimini domestici;la persona prosciolta, anche con archiviazione, dall’imputazione di omicidio verificatosi in presenza di legittima difesa domiciliare.
Continua a leggere
Scritto da:

Egregio Avvocato
Gli alimenti
15 feb. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Fra le obbligazioni di carattere patrimoniale che possono nascere nell’ambito della famiglia particolare importanza la ha l’obbligazione degli alimenti.Il fondamento di tale obbligazione è quello del diritto all’assistenza materiale della persona priva di mezzi e che prima veniva mantenuta dalla famiglia: Trattasi, infatti di un dovere derivante dal principio di solidarietà familiare.Il diritto agli alimenti è un diritto personalissimo. Esso non può essere oggetto di cessione, né di compensazione; non può essere sottoposto ad esecuzione forzata, è intrasmissibile, irrinunciabile e imprescrittibile.Tenute agli alimenti sono le persone legate da vincolo di parentela, o adozione, o affinità con l’alimentando; fra le persone suddette esiste un vero e proprio ordine gerarchico, a seconda dell’intensità del vincolo; tale ordine è stabilito dall’art. 433. in caso di più obbligati alla prestazione alimentare, l’obbligato più vicino provvede all’intero. Qualora questi non sia in grado di adempiere, si fa ricorso agli obbligati ulteriori. Se, invece, vi sono più obbligati di pari grado, ciascuno è tenuto in base alle proprie condizioni economiche. Inoltre la violazione dell’obbligazione alimentare nei confronti dei parenti più stretti e del coniuge è penalmente sanzionata ex. art. 570 c.p.Di recente, a seguito della Legge Cirinnà, il co. 9 L. 76/2016 estende all’unione civile tra persone dello stesso sesso la disciplina sugli obblighi alimentari prevista dal codice civile.Inoltre, con riferimento alla convivenza di fatto, ai sensi del co. 65 L. 76/2016 in caso di cessazione del rapporto di convivenza il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro gli alimenti, qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento, venendo assegnati gli alimenti per un periodo proporzionale alla durata della convivenza.
Continua a leggere
Scritto da:

Egregio Avvocato
Le lettere di patronage: deboli e forti
29 gen. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Le lettere di patronage sono delle dichiarazioni che vengono rilasciate ad una banca da un soggetto (di solito, una società capogruppo) in modo da indurre la banca stessa a concedere, rinnovare o mantenere un finanziamento ad un altro soggetto (di solito, una società controllata dalla prima).Sono molto utilizzate nell’ordinamento italiano, sebbene non esplicitamente disciplinate. Si differenziano, da un lato, dal mandato di credito (art. 1937 c.c.), che prevede un incarico vero e proprio a fare credito, il quale viene accettato dall’altra parte; e dall’altro lato, si differenziano dalla fideiussione (artt. 1936 e ss. c.c.), ove la volontà di prestare garanzia deve essere espressamente manifestata.Vi sono le cd. lettere di patronage deboli, ove il soggetto capogruppo si limita a dare alla banca delle informazioni riguardanti l’altro soggetto rispetto al quale si ha interesse a che venga erogato il credito. Se le informazioni fornite sono sbagliate, si risponderà a titolo di responsabilità precontrattuale, nel caso in cui sia stato falsato il processo di conclusione del contratto (si rientra nella fase delle trattative).Ma vi sono anche le cd. lettere di patronage forti, alla luce delle quali sussiste una vera e propria garanzia atipica. In questi casi, secondo una prima tesi si ha un contratto atipico con obbligo di facere, e cioè impegnarsi a tenere un certo comportamento nella gestione della società controllata. Secondo una diversa tesi, invece, si ha una promessa del fatto del terzo, che dà luogo ad un’obbligazione indennitaria o risarcitoria nel caso in cui non venga mantenuto il comportamento promesso.
Continua a leggere
Scritto da:

Egregio Avvocato
Commenti
Non ci sono commenti



