Accettazione di eredità: tacita o presunta?

Egregio Avvocato
Pubblicato il 14 nov. 2021 · tempo di lettura 1 minuti
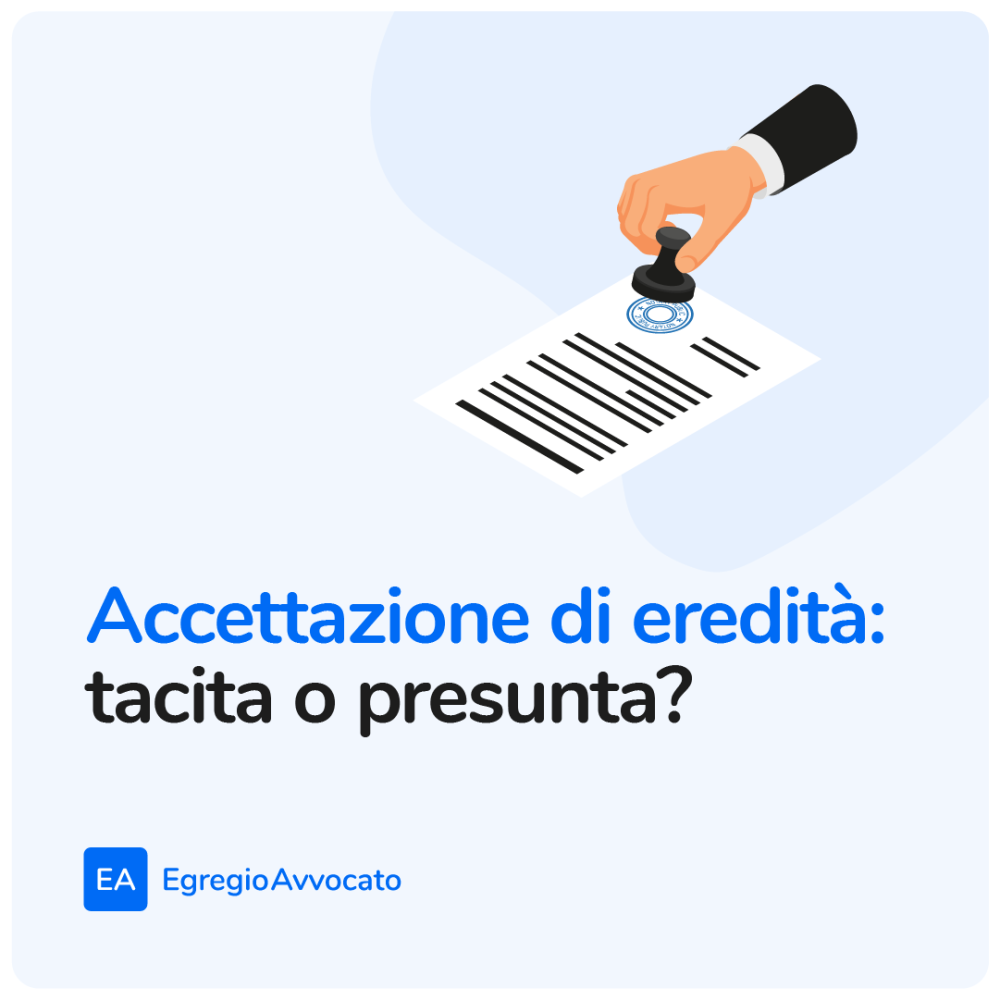
L’accettazione di eredità è l’atto conclusivo del procedimento successorio, mediante il quale il cd. delato (cioè il soggetto chiamato all’eredità) subentra nella posizione del de cuius.
Oltre alla classica accettazione espressa (mediante atto pubblico, o mediante scrittura privata), l’ordinamento italiano conosce anche l’accettazione tacita e l’accettazione presunta.
In entrambi i casi manca una manifestazione espressa di volontà del delato. Tuttavia, l’accettazione tacita si realizza mediante dei comportamenti concludenti cui è connessa l’espressione di volontà e il conseguente effetto dell'acquisto dell'eredità. Dunque, la volontà del delato comunque assume particolare rilevanza.
Nell’accettazione presunta (anche detta ope legis), invece, l’acquisto dell’eredità è previsto dal legislatore al verificarsi di specifiche situazioni, prescindendo dalla concreta sussistenza in capo al chiamato della volontà di accettare.
Un’ipotesi discussa, ad esempio, è quella prevista dall’art. 477 c.c. in merito al delato che ponga in essere atti di donazione, vendita e cessione dei diritti di successione: secondo la dottrina si tratta di un’ipotesi di accettazione tacita (ove rileva la volontà), mentre secondo la giurisprudenza prevalente si tratta di accettazione presunta.
Condividi:
Accettazione di eredità: tacita o presunta?
Pubblicato da:

Egregio Avvocato
Articoli che potrebbero interessarti
Concorso di reati: cumulo materiale e cumulo giuridico
31 gen. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Si ha concorso di reati nel caso in cui un unico soggetto commetta più reati, per i quali dovranno trovare applicazione tutte le norme incriminatrici violate. Si distingue tra concorso formale di reati: ove con un’unica azione o omissione, e con l’unica condotta il soggetto commette più reati; e concorso materiale di reati, ove con più azioni od omissioni il soggetto commette più reati.Nel caso di concorso formale, il legislatore ha previsto un trattamento di favore, cioè il c.d. cumulo giuridico: si parte dalla pena del reato più grave e tutti gli altri reati perdono autonomia sanzionatoria; il giudice potrà procedere ad aumentare la pena per gli altri reati (potrà farlo fino al triplo).Nel caso di concorso materiale di reati, invece, si applica il cd. cumulo materiale: è la somma algebrica delle pene previste da tutte le norme incriminatrici violate.All’interno della categoria di concorso materiale di reati, peraltro, vi è un’ipotesi speciale: il reato continuato, che si configura nel caso in cui il soggetto con più azioni od omissioni commette più reati in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Se ricorre la continuazione, si applicherà il cumulo giuridico in deroga alla regola prevista per il concorso materiale di reati.
Continua a leggere
Scritto da:

Egregio Avvocato
Reati con soglie di punibilità: si può applicare l’art. 131 bis c.p.?
31 gen. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
L’art. 131 bis c.p. prevede che in caso di reato con offesa particolarmente tenue, il soggetto agente, a date condizioni, non viene punito. I presupposti che devono sussistere sono tre: pena detentiva non superiore a 5 anni; modalità della condotta; esiguità del danno o del pericolo.Ci si chiede se tale norma possa applicarsi a quei fatti che costituiscono reato solo al superamento di una certa soglia: es. guida in stato di ebbrezza (0,8 a 1,5 e poi sopra 1,5); art. 316-ter co. 2 c.p. (al di sotto di 3999,98 euro il fatto sarà solo illecito amministrativo). Secondo una prima tesi, la risposta è negativa: se si potesse applicare il 131 bis c.p., il giudice si andrebbe a sostituire al legislatore, il quale ha previsto esplicitamente una soglia e quindi ha preso una posizione netta su quando un fatto è penalmente rilevante o meno. Inoltre, in questi casi vi sarebbe un paradosso poiché il soggetto che ha commesso un reato non verrebbe punito né con la sanzione penale, ma neanche con quella amministrativa. Una diversa tesi, invece, sostenuta anche dalla Cassazione a Sezioni Unite, ritiene che l’art. 131 bis c.p. possa trovare applicazione anche nei reati con le soglie di punibilità. Invero, il legislatore, anche quando ha previsto delle soglie, ha operato in astratto, mentre il 131 bis c.p. opera in concreto e sul caso specifico, prendendo in considerazione tutti gli altri elementi del caso. Non sussiste, quindi, una contraddizione tra l’esistenza della soglia e l’applicazione del 131 bis c.p.
Continua a leggere
Scritto da:

Egregio Avvocato
Cause di esclusione della pena: le differenze
12 gen. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
La nozione utilizzata dal codice penale “cause di esclusione della pena” (art. 59, co. 1 e 4, c.p.) racchiude in sé situazioni eterogenee, non riconducibili ad un principio ispiratore unitario, ma accomunate dal solo fatto che la loro sussistenza esclude la sanzione penale. All’interno delle cause di esclusione della pena possono individuarsi tre differenti categorie: le cause di giustificazione; le cause di esclusione della colpevolezza (scusanti); le cause di non punibilità in senso stretto.Le cause di giustificazione, come la legittima difesa (art. 52 c.p.), rispondono ad un’esigenza di non contraddizione: l'ordinamento giuridico non può consentire o imporre un determinato comportamento con una certa disposizione e, contestualmente, incriminarlo con un’altra disposizione. Le cause di giustificazione rendono lecito un fatto tipico nell’intero ordinamento, e, pertanto, escludono anche la responsabilità civile dell’autore del fatto.Le cause di esclusione della colpevolezza (scusanti) escludono la rimproverabilità di un soggetto per un certo fatto. Trovano il proprio fondamento nel principio di inesigibilità, secondo cui non è esigibile dal soggetto un comportamento diverso da quello tenuto a causa di determinate situazioni che incidono sul suo processo motivazionale, giocando un ruolo di pressione psichica sullo stesso. Le scusanti escludono la colpevolezza di un fatto tipico e antigiuridico.Le cause di non punibilità in senso stretto, infine, escludono la punibilità di un fatto tipico, antigiuridico e colpevole. Si fondano su una valutazione di opportunità del Legislatore che, per salvaguardare determinati contro-interessi che verrebbero lesi dall’applicazione della pena, reputa di non intervenire con la sanzione.
Continua a leggere
Scritto da:

Egregio Avvocato
Le lettere di patronage: deboli e forti
29 gen. 2022 • tempo di lettura 1 minuti
Le lettere di patronage sono delle dichiarazioni che vengono rilasciate ad una banca da un soggetto (di solito, una società capogruppo) in modo da indurre la banca stessa a concedere, rinnovare o mantenere un finanziamento ad un altro soggetto (di solito, una società controllata dalla prima).Sono molto utilizzate nell’ordinamento italiano, sebbene non esplicitamente disciplinate. Si differenziano, da un lato, dal mandato di credito (art. 1937 c.c.), che prevede un incarico vero e proprio a fare credito, il quale viene accettato dall’altra parte; e dall’altro lato, si differenziano dalla fideiussione (artt. 1936 e ss. c.c.), ove la volontà di prestare garanzia deve essere espressamente manifestata.Vi sono le cd. lettere di patronage deboli, ove il soggetto capogruppo si limita a dare alla banca delle informazioni riguardanti l’altro soggetto rispetto al quale si ha interesse a che venga erogato il credito. Se le informazioni fornite sono sbagliate, si risponderà a titolo di responsabilità precontrattuale, nel caso in cui sia stato falsato il processo di conclusione del contratto (si rientra nella fase delle trattative).Ma vi sono anche le cd. lettere di patronage forti, alla luce delle quali sussiste una vera e propria garanzia atipica. In questi casi, secondo una prima tesi si ha un contratto atipico con obbligo di facere, e cioè impegnarsi a tenere un certo comportamento nella gestione della società controllata. Secondo una diversa tesi, invece, si ha una promessa del fatto del terzo, che dà luogo ad un’obbligazione indennitaria o risarcitoria nel caso in cui non venga mantenuto il comportamento promesso.
Continua a leggere
Scritto da:

Egregio Avvocato
Commenti
Non ci sono commenti


